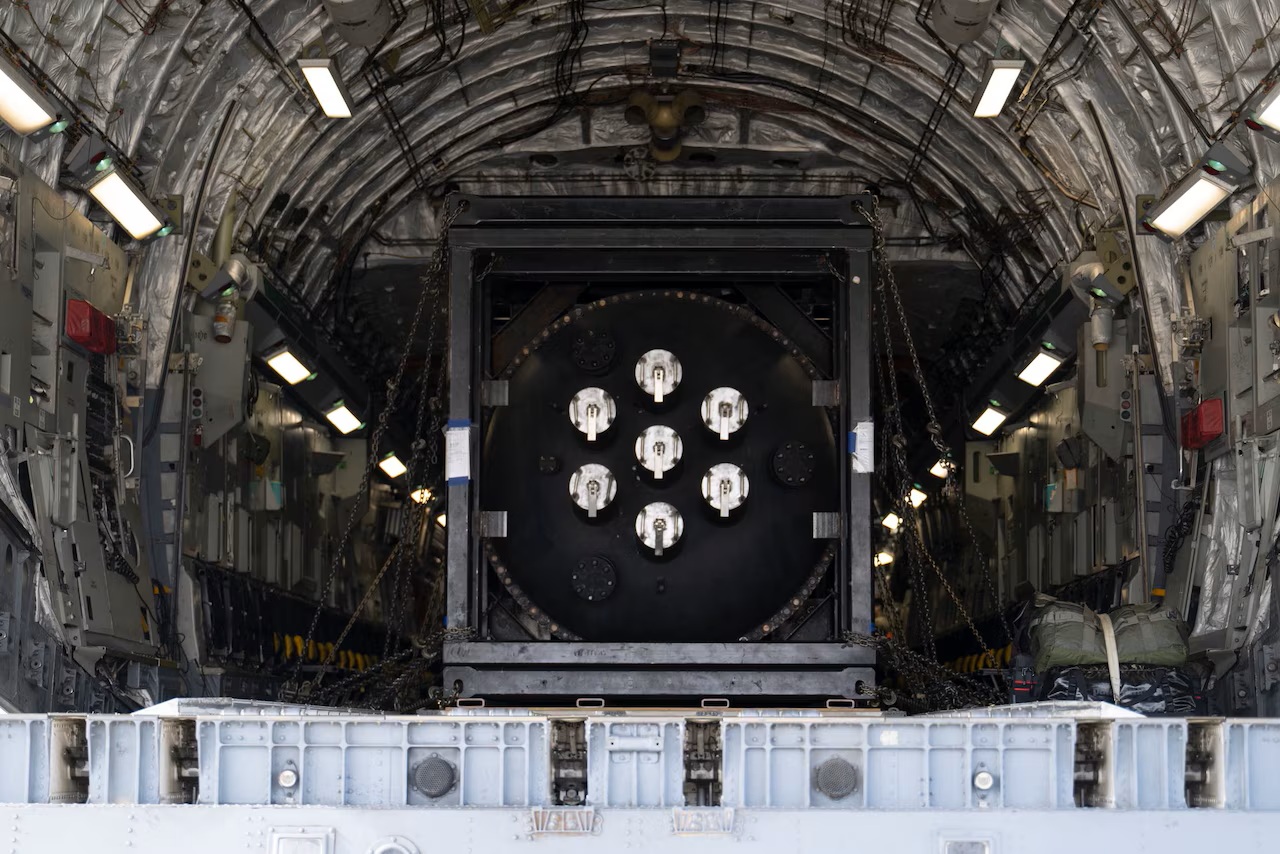Musk piglia tutto nello spazio e l’Europa resta indietro.
È il quadro (desolante) che sta emergendo negli ultimi tempi dopo che il dossier Starlink ha contribuito a puntarci i riflettori: la costellazione di satelliti in orbita bassa di SpaceX, la società aerospaziale di Elon Musk, domina il settore delle mega costellazioni e i rivali sono in corsa, ma indietro, mentre il progetto dell’Ue Iris2 sconta già ritardi e sforamenti di costi.
Sull’eventuale accordo del nostro paese con Starlink per le comunicazione governative sicure pesa (anche) il timore dell’Ue di dipendere eccessivamente dalla società SpaceX e dal mutevole Musk, e ci si chiede perché il Vecchio Continente sia arrivato in ritardo con Iris2. L’obiettivo è che l’Europa utilizzi il progetto per rendersi meno dipendente da SpaceX e per aumentare la competitività in calo del Vecchio Continente.
In realtà non è solo nel campo delle telecomunicazioni satellitari che SpaceX ha sconvolto l’industria spaziale europea. Con il suo razzo Falcon 9, SpaceX ha un cavallo di battaglia per raggiungere lo spazio che ha reso nervosi gli altri player nel settore spaziale commerciale.
L’azienda di Musk si è messa in una posizione di comando nel nuovo settore spaziale commerciale con una velocità sorprendente. Sono passati 15 anni da quando è diventata la prima società privata a lanciare il proprio razzo in orbita, irrompendo in un settore precedentemente dominato dagli stati nazionali.
E l’Europa? Ci sono i lanciatori Vega C (prodotto dall’italiana Avio) e Ariane 6 (prevalentemente francese). Quest’ultimo ha debuttato (in ritardo) lo scorso luglio e non è previsto che voli di nuovo a breve.
Dal punto di vista industriale, l’Italia è tra i pochi paesi le cui aziende coprono l’intera filiera spaziale, come sottolineato di recente anche da Massimo Comparini, responsabile divisione Spazio di Leonardo. In Europa, Roma è al secondo posto per numero totale di asset in orbita ed è attualmente il terzo contributore dell’Agenzia spaziale europea (Esa).
Inoltre, come emerso dal rapporto dell’Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano pubblicato il 28 marzo, nel 2024 l’Italia si è posizionata in terza posizione europea per investimenti in startup della Space Economy, trainata dal mega-round della startup D-Orbit (150 milioni di dollari), dietro al Regno Unito seguito dalla Germania, ma davanti a Spagna e Francia.
Eppure nel settore è la Francia ad aver sempre giocato un ruolo di primo piano con le sue industrie (Airbus, Safran e Thales) e a dettare la linea. Ma qualcosa potrebbe cambiare. Come lamentato la scorsa estate, in un intervento sul quotidiano francese La Tribune, da David Lisnard e Jean-Luc Moudenc, sindaci rispettivamente di Cannes e di Tolosa, circa il possibile declassamento dell’industria satellitare spaziale francese a favore dell’Italia. Il nostro paese potrebbe superare Parigi per crescita del settore aerospaziale sulla scia di massicci investimenti a favore del comparto.
Tutti i dettagli.
LA RIVOLUZIONE STARLINK NELLE TLC SPAZIALI E LA SFIDA PER L’INDUSTRIA SPAZIALE EUROPEA
“Nelle telecomunicazioni spaziali c’è stata una rivoluzione. Oggi tutto si concentra in un operatore che fa il vettore, fa i satelliti, li lancia e offre i servizi alle persone”, ha spiegato al Sole 24 Ore lo scorso ottobre Giulio Ranzo, ad di Avio, la società di Colleferro che sviluppa il lanciatore europeo Vega. “Musk ha un’attività che spazia da SpaceX alla costellazione Starlink, ha fatto un’integrazione verticale della catena del valore. SpaceX ha una posizione dominante con 150 lanci l’anno, Starlink si è già mangiata il 70% del mercato della connettività. Vedremo Amazon con il progetto Kuiper, che sarà lanciato da Ariane. Si creerà un duopolio, Elon Musk e Jeff Bezos”.
Situazione confermata anche dal ministro della Difesa: in una recente intervista al Foglio, Guido Crosetto ha ricordato che “la prima volta che ho parlato di Starlink con l’amministratore delegato di Avio e del fatto che i lanciatori di Musk avrebbero messo in crisi i nostri lanciatori, è stato sette anni fa”.
LA CRISI DEI LANCIATORI EUROPEI
L’Europa ha vissuto infatti un momento delicato per l’accesso autonomo allo spazio e le strategie comuni dei Paesi nel settore.
Per la prima volta da decenni, il Vecchio Continente non ha disposto di un lanciatore per portare in orbita i suoi satelliti. Oltre il ritiro di Ariane 5 dopo l’ultimo volo del luglio 2023, Ariane 6 ha subito ritardi e con il debutto costantemente rinviato (dalla previsione iniziale del lancio nel 2020), mentre Vega è rimasto bloccato sulla rampa di lancio a seguito del fallimento il 20 dicembre 2022 del primo volo commerciale di Vega C. Inoltre, a causa della guerra in Ucraina, l’Europa ha interrotto i lanci tramite il razzo russo Soyuz da Kourou in Guyana da febbraio 2022. Negli ultimi due anni l’Europa si è dovuta quindi affidare all’americana SpaceX di Elon Musk per trasportare i satelliti in orbita.
Dopo due anni di stop, lo scorso 5 dicembre il lanciatore europeo Vega C è tornato nello spazio posizionado in orbita Sentinel-1C, il satellite di Copernicus per l’osservazione della Terra.
I RITARDI DI ARIANE
E del programma Ariane, il lanciatore pesante europeo prodotto da ArianeGroup, joint venture paritetica tra Airbus e Safran?
Il debutto di Ariane 6 avrebbe dovuto rilanciare lo spazio europeo, impantanato da due anni in una profonda crisi dei lanciatori.
Senza Ariane 6, e con il ritiro di Ariane 5, il Falcon 9 della statunitense SpaceX ha rappresentato infatti l’unica alternativa praticabile per l’Esa per trasportare in orbita satelliti compreso il lancio di 4 satelliti Galileo. L’Esa aveva pianificato di lanciare i satelliti Galileo utilizzando il razzo Ariane 6, ma quest’ultimo ha subito frequenti ritardi e il debutto è avvenuto soltanto lo scorso luglio rispetto al 2021 inizialmente previsto.
Fino a poco tempo fa, l’Europa era la forza dominante per il lancio di grandi satelliti. Per quasi 30 anni, l’Ariane 5 è stata una scelta popolare per le società di telecomunicazioni che desideravano portare i veicoli spaziali in alto sopra la Terra. Ma la posizione del veicolo è stata minata da SpaceX.
Con il suo razzo Falcon 9 dal 2010, l’azienda aerospaziale fondata da Elon Musk mette in orbita satelliti e dal 2012 fa la spola con la Iss alternandosi alla Soyuz. Senza dimenticare che SpaceX offre il lancio del Falcon 9 a prezzi inferiori rispetto ai concorrenti europei.
L’ITALIANA AVIO SI È SGANCIATA DA ARIANESPACE
Nel frattempo, c’è anche la questione della commercializzazione dei lanci spaziali europei.
Ad occuparsene è Arianespace, la società controllata dal colosso franco-tedesco ArianeGroup che gestisce i lanciatori europei Vega (prodotto da Avio, la società aerospaziale di Colleferro guidata da Giulio Ranzo) e Ariane (realizzato da Arianegroup). Dunque la Francia attraverso Arianspace ha un’esclusiva per commercializzare Vega, almeno fino a poco tempo fa.
Lo scorso 5 settembre, Vega ha lanciato con successo il satellite per l’osservazione della Terra Sentinel-2C, nell’ambito del programma Copernicus della Commissione europea. Con quest’ultimo volo si è ufficialmente congedato per lasciare il passo al più potente Vega C, che ha debuttato nel luglio 2022.L’ultimo volo di Vega segna anche l’inizio della transizione nelle responsabilità dei servizi di lancio tra Arianespace e Avio: quest’ultima potrà vendere direttamente ai clienti i servizi di lancio di satelliti con il suo razzo senza passare attraverso Arianespace, conquistando capacità commerciale autonoma.
IL PROGRAMMA BOOST DELL’ESA
Nel frattempo, lo scorso novembre l’Agenzia spaziale europea ha annunciato il programma ’Boost!’ che prevede lo stanziamento di 44,22 milioni di euro per il cofinanziamento di quattro startup per la fornitura di servizi di lancio. Le startup beneficiarie sono le tedesche HyImpulse, Isar Aerospace, Rocket Factory Augsburg (Rfa) e la britannica Orbex.
Vero è che il Vecchio Continente si è riappropriato dell’autonomia nell’accesso allo spazio con Ariane 6 e Vega C, ma con il programma Boost, l’Esa intende così supportare una nuova generazione di lanciatori e servizi di lancio commerciali.
LO STATO DI SALUTE DEI PRODUTTORI FRANCESI DEL SETTORE SPAZIALE
E dei produttori di satelliti europei?
Airbus e Thales Alenia Space (jv partecipata al 67% dalla francese Thales e al 33% dall’italiana Leonardo) sono i maggiori produttori europei di satelliti per telecomunicazioni, navigazione e sorveglianza.
Il primo trimestre del 2023 in Francia “è stato caratterizzato da diversi allarmi sullo stato dei produttori francesi del settore spaziale”, avevano avvisato i due primi cittadini francesi Lisnard e Moudenc, osservando che “tali difficoltà, incontrate dai maggiori attori nazionali, sollevano interrogativi sulla strategia francese in questo settore”.
Entrambe sono alle prese con perdite e riduzione del personale.
COME VA THALES ALENIA SPACE
Thales Alenia Space ha subito infatti perdite significative negli ultimi anni: 11 milioni nel 2022 e 35 milioni nel 2023, su ricavi di 2,18 miliardi. Sia per ragioni cicliche che strutturali, a causa di un declino duraturo del mercato dei satelliti geostazionari.
Al contrario della divisione italiana: Thales Alenia Space Italia Spa (controllata al 100% da Tas) ha registrato invece 33 milioni nel 2022 raddoppiati a 72,8 milioni nel 2023.
Da qui il ridimensionamento al ribasso dell’organico di Thales Alenia Space, con un taglio di 1.300 posti di lavoro, di cui 1.000 in Francia. Tanto che dopo la riunione del Comitato aziendale europeo di Thales Alenia Space del 7 novembre, i sindacati rendevano noto che “il management guidato dal francese Hervé Derrey ha confermato un quadro critico della situazione JV.”
“L’Italia, invece, anche nel 2024 incrementerà ulteriormente ricavi e redditività: i ricavi raggiungeranno un valore pari a quasi la metà di quello della JV, pur avendo un organico pari ad 1/3 di tutta TAS, e l’ottima redditività compenserà quella negativa delle altre entità nazionali, limitando i danni a tutta la JV” proseguiva la nota di Fim-Fiom-Uilm.
“Abbiamo, quindi, ritenuto grave il tentativo compiuto da parte del management a guida francese, nel corso del suddetto incontro, di parificare la situazione industriale ed economica italiana a quella del resto di TAS e, soprattutto, di voler prefigurare per l’Italia scenari analoghi nel futuro, non si sa su quale base, a causa di eventuali scelte sbagliate nel continuare e crescere” hanno concluso i sindacati.
E AIRBUS SPACE DEDEFENCE AND SPACE
Anche Airbus taglia il 5% della sua forza lavoro nella divisione Defence and Space.
Lo scorso dicembre la società ha annunciato poco più di 2.000 tagli di posti di lavoro nelle sue attività Difesa e Spazio, una riduzione inferiore a quella inizialmente prevista. Nel primo semestre le attività Difesa&Spazio hanno registrato ricavi per 4,985 miliardi di euro (+7%) e un risultato operativo rettificato negativo per 807 milioni. L’ammontare degli ordini del primo semestre era di circa 6 miliardi di euro, in linea con l’anno precedente. Tuttavia, Airbus è in grande difficoltà di fronte al calo della domanda, proprio come Thales.
Il colosso aerospaziale aveva già avvertito a fine giugno che avrebbe dovuto effettuare un nuovo accantonamento di “circa 900 milioni di euro” nel primo semestre legato alla revisione dei costi di sviluppo e delle prospettive commerciali previste di alcuni programmi satellitari di telecomunicazioni e navigazione. Tale importo è stato infine ridotto a 989 milioni di euro, mentre proseguiva la revisione programma per programma.
Nel 2023 Airbus aveva già registrato nei suoi conti un onere di 600 milioni di euro per questa stessa attività spaziale, che l’anno scorso rappresentava circa 2 miliardi di euro di fatturato sui 65,4 miliardi realizzati dal gruppo.
RISIKO NELL’INDUSTRIA SPAZIALE EUROPEA
Tanto che nei mesi scorsi indiscrezioni di stampa parlavano di contatti in corso tra Airbus da una parte e Thales e Leonardo dall’altra relativa a un riassetto delle attività spaziali di Airbus.
Leonardo è già alleata di Thales nel settore spaziale attraverso due joint venture della space alliance: Telespazio partecipata al 67% da Leonardo e al 33% da Thales e Thales Alenia Space con il gruppo francese al 67% e l’ex Finmeccanica al 33%.
A inizio dicembre ci ha pensato Reuters a tornare sul dossier segnalando che Airbus, Thales e Leonardo stanno valutando l’opportunità di creare una nuova società congiunta per le attività spaziali, nel tentativo di competere con Starlink di Elon Musk.
Il “Project Bromo”, che prende il nome da un vulcano indonesiano, prevede la creazione di un campione europeo dei satelliti sul modello di Mbda, il consorzio missilistico europeo fra Airbus e Bae Systems (37,5% ciascuno) con socio al 25% Leonardo.
Sulle alleanze Ue a livello europeo “i tavoli tecnici sono al lavoro, ma c’è ancora molto da fare” ha affermato Roberto Cingolani, ad di Leonardo.
“L’intento è chiaramente quello di provare a creare una massa critica in un settore che attualmente non sta andando bene e che è minato da attori come Starlink”, aveva spiegato a Reuters una fonte del settore italiano, riferendosi ai colloqui segnalati tra Airbus e Thales.
REPLICARE IL MODELLO DI MBDA NEL BUSINESS SATELLITARE
Nelle attività spaziali “vogliamo guadagnare scala e accelerare il consolidamento del business”; “Vogliamo che Airbus abbia una quota in un’azienda grande” sul modello di Mbda. È quanto ha spiegato agli analisti lo scorso 20 febbraio il ceo di Airbus Guillaume Faury in merito alle negoziazioni in corso con Leonardo e con Thales per unire le rispettive attività spaziali.
“Siamo in una situazione in cui alcuni operatori Usa stanno sconvolgendo l’ecosistema e stanno facendo scala sulle nuove tecnologie” ha detto il manager aggiungendo che in Europa “Airbus, ma anche Thales Alenia Space e Telespazio (le jv tra Leonardo e Thales)” hanno le tecnologie, “in certi casi anche migliori”, ma c’è bisogno “di essere competitivi in questo nuovo contesto”. La combinazione darebbe alla joint venture un “potere finanziario” e una “capacità di investimento” che sarebbe “positiva” per contrastare gli operatori Usa.
Il ceo di Airbus, rispondendo a una domanda in conferenza stampa, ha precisato che i colloqui con Leonardo e Thales riguardano “lo spazio, ma non vanno oltre i satelliti” e quindi “non i lanciatori o altri segmenti dello spazio”. Faury ha ribadito la natura “esplorativa” delle discussioni in corso e il focus è sul fatto che la combinazione che ne deriverà possa essere qualcosa che sia approvata dall’Antitrust e abbia successo sul mercato.
IL PROGETTO AL VAGLIO DELL’ANTITRUST UE
Secondo quanto rivelato il 28 marzo da La Tribune, Airbus, Thales e Leonardo hanno presentato il piano preliminare di consolidamento per riunire le loro risorse spaziali in un’unica società alla Commissione europea.
Di recente le tre aziende, con il sostegno dei governi, hanno presentato alla Commissione europea un progetto preliminare di consolidamento per riunire le loro attività nel settore spaziale in una società comune, ha scritto il quotidiano francese.
In base alle informazioni di La Tribune, le tre società avranno ciascuna un terzo del capitale di questa società, che potrebbe essere creata entro la fine del 2026, una volta ottenute tutte le autorizzazioni.
Sull’evoluzione del processo peserà anche la postura dell’azienda aerospaziale tedesca Ohb, già pronta a sollevare preoccupazioni presso le autorità di concorrenza dell’Ue su un potenziale legame tra i due più grandi produttori di satelliti europei.
GLI INDIRIZZI DEL GOVERNO ITALIANO
Infine, torniamo alla lotta per i lanciatori spaziali di domani, in un momento delicato per l’accesso autonomo allo spazio e le strategie comuni dei Paesi nel settore.
“Con il ministro Le Maire ho subito instaurato, sin dalla ministeriale di Parigi e poi nell’ambito del Trattato del Quirinale un rapporto di leale collaborazione e insieme al nostro collega tedesco Habeck abbiamo indicato la strada per i lanciatori spaziali europei” ha ricordato in un’intervista al Corriere della scorsa estate il ministro del Mimit Adolfo Urso, autorità per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali.
E il riferimento è alle intese siglate nel novembre 2023: Italia, Francia e Germania hanno raggiunto un accordo per sostenere i futuri lanci dei lanciatori europei Ariane 6 e Vega C. Riguardo quest’ultimo, si è aperta alla commercializzazione autonoma dei lanci che potrà essere svolta direttamente anche da parte di Avio, in condivisione con quanto già oggi fa la società francese Arianespace, come già detto in precedenza.
“Certo occorre monitorare con attenzione tali sviluppi e renderli al passo con quello che stanno facendo altri attori globali” aveva chiosato il ministro Urso.
Nel frattempo, la scorsa settimana sono stati pubblicati gli indirizzi di governo per lo spazio, a cui ha lavorato il Comint, comitato presieduto dal ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, autorità delegata per il settore.
Secondo il piano di governo bisogna “rafforzare i benefici per la competitività e la sostenibilità dell’econosistema industriale spaziale del paese nei rapporti internazionali, garantendo che le alleanze internazionali siano vantaggiose e allineate con gli obiettivi nazionali”. Non solo, “L’Italia dovrebbe mirare a rafforzare la presenza di funzionari italiani all’interno dell’Esa, considerando il volume significativo dei fondi versati e in previsione di una possibile revisione della politica del giusto ritorno.”