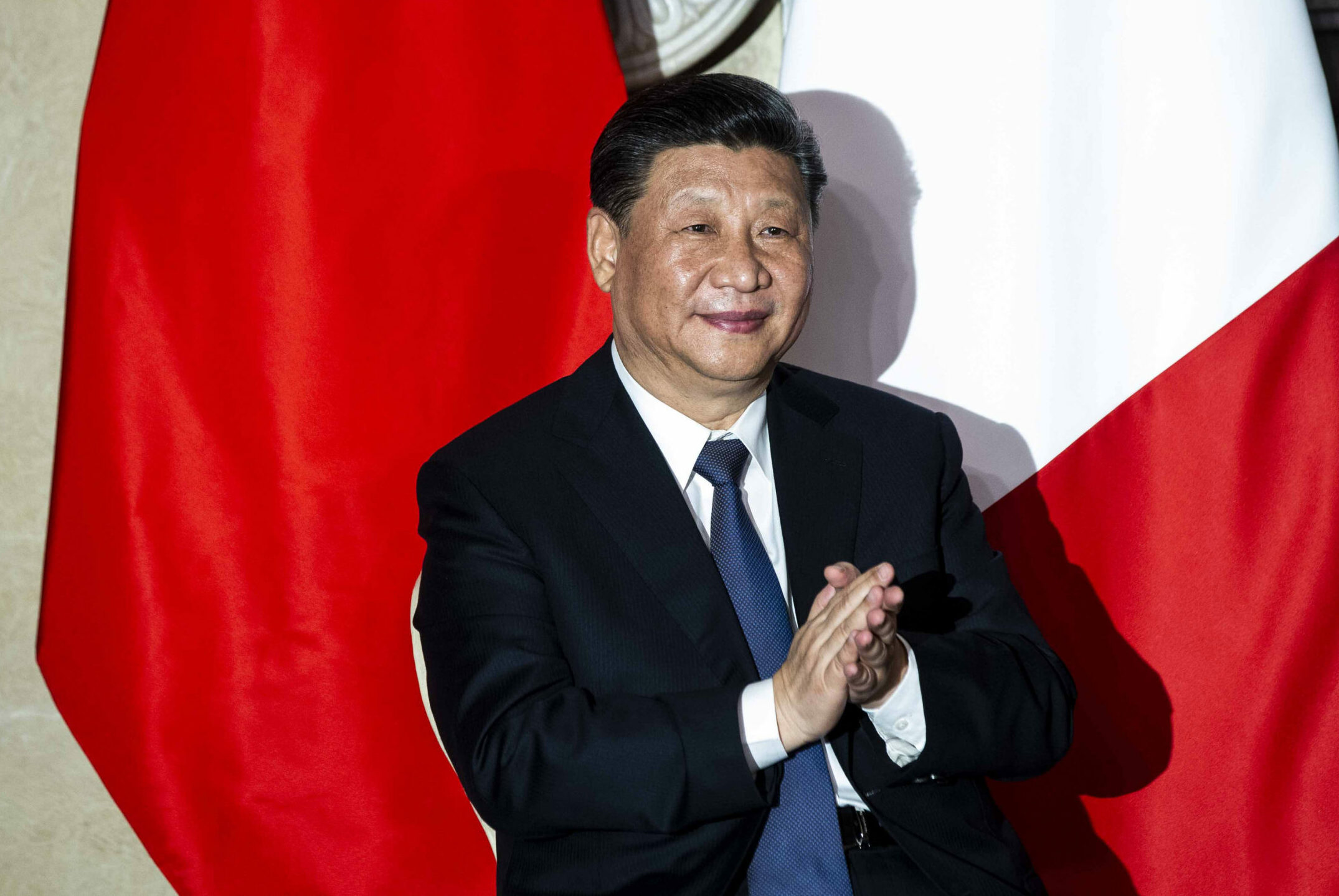Il Bloc Notes di Michele Magno
Se è vero che tutti gli italiani condividono un patrimonio comune di superstizioni, da quella sul ferro di cavallo ai fantasmi, ce n’è una esportata inconfondibilmente in tutta la penisola da Napoli. Si tratta della jettatura. Secondo l’eminente antropologo Alfonso M. Di Nola, per jettatura si deve intendere l’influenza nefasta esercitata da uomini –ma anche da oggetti e animali– su altri uomini, intenzionalmente o involontariamente. Il suo discredito è legato a un presunto potere speciale dell’occhio, capace di sprigionare un influsso distruttivo, ossia quel “gettare il male” da cui deriva il termine (“Jettatura”, in “L’identità degli italiani”, a cura di Giorgio Calcagno, Laterza, 1998).
In verità, nelle culture popolari domestiche lo jettatore non opera soltanto attraverso lo sguardo, il cosiddetto “occhio secco” dei dialetti meridionali, ma anche attraverso un insieme di segni distintivi che formano uno stereotipo da aggiungere ai celebri “Caratteri” di Jean de La Bruyère (1688): il vestire di nero, come nel lutto, il portare occhiali scuri che nascondono gli occhi, apparire magro e allampanato col volto triste e rassegnato, parlare con voce querula, fare discorsi sulle sventure personali o di persone conosciute. È il personaggio, per capirci, immortalato da uno straordinario Totò nel film “Questa è la vita” (1954).
Come osserva Di Nola, le radici storiche del fenomeno sono remote, almeno quanto la condanna dello sguardo geloso del bene altrui. Gli antichi lo chiamavano “invidia”, che etimologicamente significa “guardare contro“, proprio come il termine ebraico “qinah”. Nelle “Bucoliche”, Virgilio attesta che i pastori credevano nella fascinazione jettatoria esercitata sugli agnelli dall’occhio maligno. Una legge delle XII Tavole punisce chi ricorreva agli incantesimi jettatori per ottenere che i prodotti del campo del vicino passassero sul proprio. Nella Taberna del pescivendolo degli scavi ostiensi, un previdente commerciante, per difendersi dagli occhi calamitosi dei concorrenti, si era fatto incidere sul mosaico di una parete: “Invidioso, ti acceco!”. Assai diffusa anche nel Medioevo, nel Settecento napoletano l’angoscia da jettatura assume forme parossistiche. “Perché mai -si domandava Benedetto Croce- si parlò e si scrisse tanto della jettatura, a segno che questa parola […] diventò nota anche ai forestieri, come si vede nei libri di Dumas e Gautier?” (“Quaderni della Critica”, 1945).
In questa moda dilagante il filosofo scorgeva un intimo piacere, un gusto perverso di certa umanità nel voler trovare argomenti di conversazione poco impegnativi su cui ridere e spettegolare. Non si creda quindi – ammoniva- che la jettatura sia un tema restaurato dalla bassa plebe, ma piuttosto “dalle smorfiette delle vezzose dame, che davano o trasmettevano il tono del prescelto modo di artificiale aborrimento”. Né andava sottovalutata la forza del mito: erano state infatti due divinità femminili a spargere il seme della jettatura contro gli uomini: toccando il ventre di Venere, sedotta da Giove, Giunone maledice il nascituro Priapo, che vedrà la luce deforme. Raramente, del resto, “si è parlato al femminile nel mondo del malocchio” (Fausto Nicolini, “Infofinax”, maggio 2009).
A sostegno della sua tesi, Croce -seguace del “Non ci credo, però….”- menzionava come esempio la celebre “Cicalata” di Nicola Valletta (1787), l’illustre erudito e giureconsulto napoletano che nutriva un timore reverenziale per l’occhio perverso. Alberto Consiglio, che nel 1961 ha riedito il testo con una brillante introduzione, ricorda come lo descrive Stendhal dopo una visita nel suo alloggio: “Ho trovato nella camera uno smisurato corno che può avere dieci piedi di altezza. Spunta dal pavimento come un chiodo. Suppongo che sia fatto con tre o quattro corna di bue. È un parafulmine contro la jettatura (la malasorte che un maligno può gettare su di voi con uno sguardo)”. Come accennava di sfuggita Croce, la figura dello jettatore ispira ben quattro capitoli del “Corricolo” di Alexandre Dumas padre, una raccolta di racconti pubblicata intorno al 1841.
Il protagonista, indicato sempre e soltanto come il Principe di ***, era il più famoso menagramo del suo tempo: nacque e la madre perì di parto; provocò la rovina del padre, ambasciatore del Borbone alla corte di Toscana; fece morire di apoplessia un alfiere durante la guerra contro i francesi; agitò la bandiera borbonica al grido di “Viva il Re!” e la guerra fu persa; una sua presenza al San Carlo coincise con l’incendio del teatro. Dumas aveva saccheggiato senza scrupoli le informazioni fornitegli da Pier Angelo Fiorentino, un esule napoletano in Francia. Ma chi era l’innominato (e l’innominabile)? Si deve alle ricerche d’archivio di uno stretto collaboratore di Croce, Fausto Nicolini (di cui lo studioso omonimo citato sopra è pronipote), il disvelamento del mistero. Il Principe di *** si chiamava Cesare della Valle, duca di Ventignano, colto letterato e gran viveur, nato a Napoli nel 1766 e morto a novantaquattro anni. Si deve invece a Giuliano Capecelatro una sua biografia dal godibile stile romanzesco e dal tono ironico e scherzoso (“Le corna del duca”, il Saggiatore). Per guidarci nella vita travagliata del vituperato aristocratico, l’autore si serve di una maschera tipica del folclore napoletano, ‘o monaciello, che “tra beffe e malignità ci tiene in bilico sull’incerto confine tra razionale e irrazionale” in mille episodi gustosi.
Dal monaciello sappiamo che il duca era un secondogenito. Allora a Napoli vigeva l’istituto del maggiorasco, che assegnava titoli e ricchezze solo al primo figlio. Anche il fratello maggiore aveva un nome altisonante, Ercole. Molto meno cupo nel volto, dai tratti più aggraziati, di sentimenti elevati e valente spadaccino. Cesare era perciò destinato alla carriera ecclesiastica. Appena giovinetto, entra in seminario. E non si può dire che il suo ingresso sia passato inosservato. Non soltanto per la sagoma inquietante del nuovo allievo: alto, smilzo, le guance incavate, il colorito pallido, lo sguardo perennemente corrucciato, il naso affilato e, col trascorrere degli anni, sempre più curvo. Era il migliore della classe, ma una volta viene superato da un collega in una gara di latino. Cesare gli lancia un’occhiata, non si sa se di stima o di rammarico, e il malcapitato va a sbattere contro il gradino del podio su cui si accingeva a fregiarsi del meritato alloro. La gamba si spezza, il ragazzo rotola a terra con un urlo agghiacciante, accompgnato dal gelo tremebondo degli insegnanti. Quando Cesare, conclusi gli studi, lascia il seminario, l’intero corpo dei docenti tirerà un sospiro di sollievo.
Ora gli si spalancavano le porte di un convento. L’abito talare, però, gli andava stretto. Peccatore irredimibile, non si sarebbe mai adattato a un’esistenza piena di rinunce. Piuttosto lo attirava il mondo dell’arte. Nell’adolescenza aveva dato prova di essere un discreto versificatore. Da adulto, si immaginava intento a comporre liriche indimenticabili, tragedie strazianti, irresistibili commedie, e qualche poemetto satirico per mettere in riga i suoi simili. Inoltre, le scalmane dell’età lo assillavano. Il suo cuore viene così conquistato dalla bella Caterina, generata da lombi principeschi. Il ventenne Cesare le declamava interi brani del Romeo e Giulietta di Shakespeare. Ben presto un gonfiore inequivocabile della sedicenne mette le rispettive famiglie al corrente della tresca peccaminosa. La loro collera impone le classiche nozze riparatrici. Cesare evita il convento, ma Caterina spira durante le doglie.
Era di nuovo libero, ma al prezzo di una fama ancora più sinistra di quella di cui già godeva presso i suoi concittadini. Il padre non lo aveva comunque perdonato, e più tardi lo costringe a rinchiudersi nel convento di Camaldoli per espiare le sue colpe. Cesare aveva trentatrè primavere quando evita nuovamente i voti, questa volta proprio grazie all’odiata “accolta di intellettuali depravati e di donne prive di pudore” che avevano instaurato la Repubblica Napoletana. Prima di fuggire a Palermo, infatti, il re Ferdinando IV aveva emesso un’ordinanza che aboliva le comunità religiose. I monaci camaldolesi, restituiti bruscamente alla laicità, per pii che fossero non vedevano l’ora di separarsi da quel preoccupante compagno. Che andasse per la sua strada -pensavano- e seminasse disgrazie altrove.
Scongiurata l’epidemia giacobina, il duca era rientrato nella residenza paterna, un enorme palazzo rosso pompeiano vicino a via Chiaja. Durante una passeggiata, aveva assistito all’arresto di Eleonora Pimentel Fonseca. Le era apparsa all’improvviso sul portone della sua abitazione, ubicata nei pressi dei Quartieri spagnoli. Scossa, nella selva delle divise che la circondavano, ma altera. Era nel suo appartamento che si stampava il “Monitore Napoletano”. Per il duca, un veicolo di farneticazioni sovversive, un covo di atei diabolici. Eleonora era stata amica di Maria Carolina, la sposa di Ferdinando IV. Con la regina aveva frequentato gli ambienti in cui trionfava l’Illuminismo. Cesare la considerava una nemica pericolosa, mosso da una diffidenza istintiva per un’intelligenza troppo vivace e versatile. E anche una rivale detestabile, poiché le sue raffinate poesie avevano sempre riscosso maggiori consensi dei suoi scolastici componimenti.
Nel frattempo Ercole, come tutto il milieu dorato a cui apparteneva, frequentava i caffè della centralissima via Toledo. In uno di questi, un giorno sente bollare il fratello da un bellimbusto come un “fottutissimo jettatore”. Due fulminei manrovesci risuonano nella sala intorpidita da interminabili partite a scacchi e da distratte letture di giornali. Il duello è inevitabile. La scelta cade su un prato di Agnano, dove i due si sfideranno col fioretto. Ercole aveva incrociato la sua lama con i migliori schemidori europei. Nessuno avrebbe scommesso un soldo sul suo avversario. Cesare insiste per essere al fianco del fratello, che a malincuore acconsente. Accade così l’imprevedibile. Forse troppo sicuro di sé, Ercole viene trafitto mortalmente alla gola. La salma, sollevata dal medico e dai padrini, viene adagiata nella carrozza tra il pianto dirotto del duca e le mani degli astanti strettesulle parti intime. Con la scomparsa del fratello, in compenso, agli albori dell’Ottocento Cesare diventa l’unico erede di un nobile casato e di proprietà del valore di due milioni di ducati: una cifra da far girare la testa ai sudditi di Ferdinando II.
Sotto il suo regno (1830-1859), Napoli esibiva una luccicante modernità. Dalla Riviera a Toledo, il gas aveva preso il posto dell’ormai antiquato sistema a olio. Quattrocento lampioni. Il sovrano adorava questi primati, che i “pennaruli” del Borbone sbandieravano come prova tangibile della sua lungimiranza. Il 3 ottobre 1839 un corteo di nastrini svolazzanti, galloni, cappellini e vaporose toilette ordinate per l’occasione a Parigi, aveva scortato il re delle Due Sicilie lungo i sette chilometri e mezzo di strada ferrata che congiungevano la capitale a Portici. Ma fin dall’inizio del nuovo secolo il cuore blasonato della città aveva ripreso a pulsare, nei salotti e nelle serate mondane ravvivate da tornei di danza e puntate ai tavoli di baccarat. La marchesa Ottavia del Pero ne era un’animatrice infaticabile.
La nobildonna amava considerarsi uno spirito volterriano. Disquisiva di Rousseau e Montesquieu, di spirito delle leggi e diritti dell’uomo. Non le dispiacevano i massoni, anche se sua maestà non li sopportava. Non conosceva il duca di Ventignano di persona, ma le dicerie sul suo conto le avevano sempre strappato un sorriso di sufficienza. Si era quindi ripromessa di inserire in una lista di invitati il “fenicottero zoppo”, come veniva soprannominato per la sua andatura goffa. Carattere beffardo, la marchesa aveva accettato una scommessa. Se un qualsiasi incidente avesse turbato la festa, di cui l’ospite fosse stato con ogni evidenza il responsabile, la cancellata della villa sarebbe stata adornata con un corno bronzeo ben visibile anche da lontano. Con una punta di perfidia intellettuale, aveva però preteso in cambio, se tutto fosse filato liscio, che i denigratori del Ventignano leggessero e commentassero con lei il “Dizionario filosofico” di Voltaire.
Nel giorno tanto atteso, un valletto annuncia l’entrata del duca nel salone tra il brusio dei presenti. I ballerini si ritirano di corsa nel giardino. Cesare aveva appena mosso due passi, quando un domestico, che con profondi inchini porgeva sorbetti, coviglie, biancomangiare (un dolce di pasta molle spolverata di cacao), inciampa nel lembo di un tappeto e sparpaglia sul pavimento le meraviglie della pasticceria del regno. La marchesa non si scompone, e con un cenno del capo chiama il duca e gli presenta suo padre. Dopo aver scambiato due parole di circostanza, il vecchio gentiluomo viene assalito da una tosse improvvisa e violenta. Temendo di soffocare, si accascia pesantemente su una poltrona mentre borbottava alla figlia: “Quello lì davvero non mi piace”. La padrona di casa non si lascia scoraggiare dall’accaduto, che riteneva affatto fortuito.
Decide di riagganciare il “fenicottero zoppo”. Lo trova nel parco, alle prese con l’ultimo boccone di biancomangiare. Con voce vellutata gli sussurra: “Non vorrei che vi steste annoiando”. Ventignano replica serafico: “Per nulla, signora marchesa. È una festa magnifica e la notte è incantevole”. Fu un attimo. Dal mare comincia a spirare un vento gelido. Scoppia un tuono terrificante. Tonnellate di pioggia si abbattono sugli ospiti che sostavano tra i boschetti colmi di fontane, pagode, chioschi per i musicanti, statue di satiri, ninfe e pescioni mitologici. I potenziali naufraghi riescono a mettersi in salvo nel salone. La marchesa adesso è sconcertata, ma i “philosophes” l‘avevano educata a non curarsi dei pregiudizi del volgo. Purtroppo per lei, Cesare stava ammirando il monumentale lampadario che rischiarava ogni angolo del salone. Era stato ordinato in Inghilterra, ed era tanto pregiato che perfino il re di Prussia ne aveva commissionato uno gemello. “Oh marchesa – esclama Cesare rivolgendosi alla del Pero, che intanto si era ricomposta in uno splendido abito color verde ramarro– questo lampadario è qualcosa di unico”. Non aveva ancora terminato di pronunciare la frase che si ode un fragore assordante, seguito da grida di panico e da un fuggi fuggi generale. La preziosissima lumiera era piombata a terra in una raffica di cristalli che schizzavano da ogni parte come proiettili, perforando mobili e vestiti.
Mentre una schiera di domestici provvedeva a ripulire il salone, svuotandolo delle pregiate macerie, Cesare gironzolava cercando di rendersi utile, anche se non si spiegava il motivo di quel pandemonio. Per lui la festa poteva tranquillamente continuare. Come un segugio, si mette a caccia della marchesa per offrirle i suoi servigi. Ma la dama si era eclissata. Il duca abbandona la villa sconsolato, mentre rifletteva sul suo rapporto con il gentil sesso. Era certamente attratto dalle sue forme, secondo i cliché dell’epoca: bocche sensuali, vite sottili, seni ubertosi. Nelle donne, però, percepiva una vitalità ambigua e misteriosa, che si opponeva alla brama predatoria del maschio. Nel frattempo, la marchesa era uscita dalla sua volontaria prigione. Si guardava attorno, con il viso ancora impiastrato di lacrime, cipria, creme. L’indomani in un battibaleno un artigiano forgia un mirabile corno di bronzo, saldato alla cancellata della villa in una cornice di foglie d’alloro dello stesso metallo. Il busto di Voltaire sparisce tra le cianfrusaglie di un rigattiere. Alla prima uscita dopo la sciagurata serata, Ottavia del Pero sfoggiava al collo un vermiglio corno di corallo.
Un anno molto turbolento, il 1848; anche a Napoli. A gennaio Ferdinando II era stato costretto a concedere una Costituzione redatta da un liberale moderato, Francesco Paolo Bozzelli. In pochi mesi la città si era riempita di comitati rivoluzionari. I radicali propagandavano il verbo repubblicano di Giuseppe Mazzini. Il clima era sempre più teso, sovreccitato. Il 14 maggio la carrozza del duca viene fermata all’altezza di Santa Brigida da un gruppo di energumeni. Cesare esige una spiegazione. “Eccellenza, noi stiamo qui a difendere ‘a costituzzione”, gli rispondono. Mentre il cocchiere recuperava le redini dei cavalli, viene assalito da cupi presagi. Qualcuno lo riconosce e balbetta il suo nome. Subito decine di bocche formulano gli scongiuri di rito e decine di mani prendono la forma delle corna.
Un popolano, che si dava l’aria di uno che la sapeva lunga, profetizza: “È passato il beccamorto. Siamo fottuti”. Il 15 maggio le barricate dei rivoltosi vengono spazzate via dalle cannonate delle artiglierie regie e dalla furia delle milizie mercenarie svizzere. Nelle loro scorribande,i lazzaroni depredavano e scannavano i “signori”. Non meno feroci erano i “luciani”, gli abitanti del borgo di Santa Lucia la cui devozione al re non conosceva limiti. Capecelatro sottolinea che Dumas non attribuisce alla vittima predestinata -l’immaginario principe e vero duca- la reponsabilità del bagno di sangue di quel giorno luttuoso. Ma –chiosa– dove non arriva la penna, arriva lingua. Quella del popolo, affilata, pungente, velenosa. E, mormorava la lingua, era il duca ad aver scatenato l’inferno che aveva devastato la città. Lui, con la sua sola presenza sulla scena del delitto.
Ovviamente Cesare, il quale invece quel giorno si era nascosto prudentemente nel suo studio, aveva appreso con gioia la notizia della repressione della “peste comunista”, che da Parigi voleva infettare l’Europa. Ancora una volta l’ordine naturale delle cose non era stato stravolto. In effetti, la vita a Napoli riprende presto come se niente fosse successo. Sui tavoli da gioco si dilapidavanosomme enormi. Andava a gonfie vele il mestiere più antico del mondo, in passato portato agli onori della cronaca dalla leggendaria Concetta “‘a cagnacavallo”. Affari d’oro realizzavano i malandrini che tiravano le fila del lotto clandestino. Tutti sfidavano la sorte, nobili e plebei. Insomma, per almeno un decennio tutto -o quasi- sembrò tornare come prima.