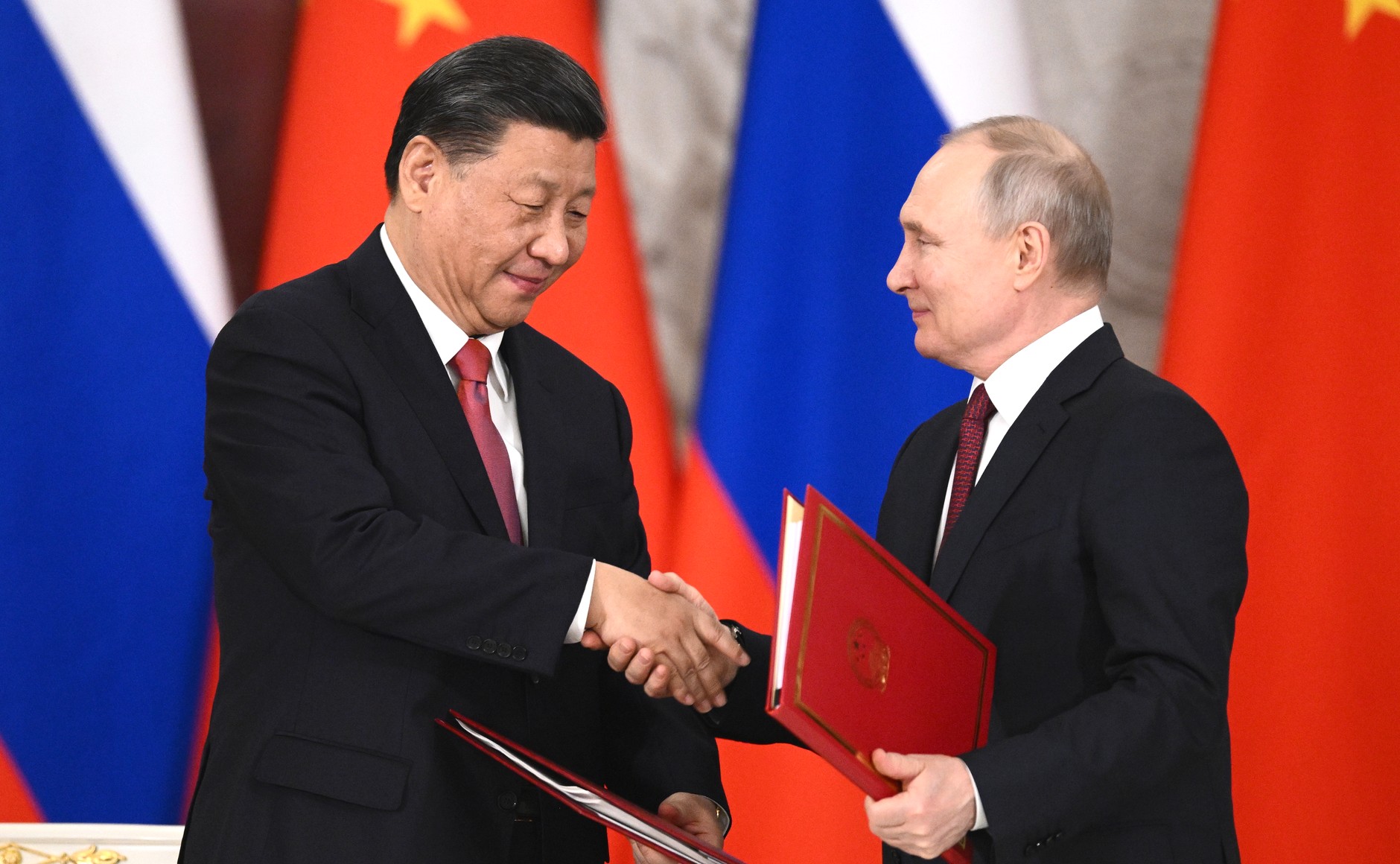Quando si legge di prestigiosi think tank che esclamano: “la guerra ha cambiato tutto!”, può venire in mente il francese “plus ça change, plus c’est la même chose”. Mi riferisco esclusivamente alla retorica del discorso pubblico prodotta dal clima di chiamata alle armi, senza permettermi di toccare gli aspetti politici strategici o militari di una cosa seria come una guerra, di cui nulla so, di cui poco credo di poter apprendere dai mezzi d’informazione di massa e di cui l’aspetto che considero qui è certamente marginale.
Da un certo punto di vista la guerra funziona come il bagno di sviluppo in fotografia, che rende visibili le immagini depositate sul supporto fotosensibile. Non procura nessuna sorpresa ma elimina eventuali dubbi. Per esempio, dopo due mesi di guerra guerreggiata in Ucràina chi può ancora dubitare della “inclinazione ad anticipare (ancor più che assecondare) i desiderata del princeps” che Luciano Canfora (per dirne uno) attribuisce al giornalismo italiano? Di più. Nel clima bellicista diventa difficile anche distinguere giornalismo e giornalismo: le differenze tra un Corriere della Sera, una Repubblica, e una Neue Zürcher Zeitung, si possono ancora percepire a livello di stile, di attenzione alle parole, di senso della misura, ma la sostanza è uguale: c’è la guerra, c’è il nemico e ci sono i nostri, e in questo caso non c’è neppure lo sforzo di “anticipare i desiderata” perché l’identificazione con i “nostri” è totale, automatica e pervasiva ben oltre il circoscritto mondo dei media.
In queste circostanze il giornalismo migliore è impegnato nella raccolta e nel racconto degli aspetti più evocatori dei punti forti della narrazione della propria parte: l’eroismo della resistenza ucraìna, le stragi di civili dei missili russi, la dissennata crudeltà della “guerra di Putin” (a scelta “criminale”, “assassino”, “macellaio” e da ultimo “genocida”) di cui l’intera Russia non sarebbe che un’estensione: e certamente, di aspetti efferati, atroci e quant’altro, la guerra di Putin non sarà avara, come non lo è nessuna guerra, nemmeno quelle dove gli ammazzamenti dei civili si usano definire “danni collaterali”. Fin qui siamo nella norma di campagne mediatiche non solo legittime ma sacrosante, che oltre a comportare anche un rischioso lavoro sul terreno, soddisfano una domanda effettiva.
Sotto questo aspetto non si può dire che il giornalismo nostrano primeggi, non perché i giornalisti italiani siano meno bravi o meno coraggiosi degli altri, ma perché gli editori italiani da molto tempo hanno deciso che non vale la pena di investire sui reportage, le inchieste e gli inviati (quello di “inviato” è ormai più un titolo maturato per anzianità che una qualificazione professionale, fatte naturalmente le debite eccezioni). Nell’insieme in Italia si tende a “vivere di rendita” sugli efficaci interventi di Volodymyr Zelensky nei Parlamenti dei paesi occidentali e sul lavoro sul terreno di testate di altri paesi, oltre che sugli “esperti” sempre pronti a offrire il loro vaticinio.
Dove il giornalismo italiano si distingue è nella incessante compilazione di graduatorie che comprendono chiunque pretenda di dar voce a dei distinguo nella corale esecrazione, senza se e senza ma, del tiranno di Mosca, un po’ come si è fatto negli ultimi due anni per i “no vax”, categoria nella quale sono stati inclusi anche intellettuali pur provvisti di tutte le vaccinazioni disponibili, che però credevano, sbagliando, di poter esprimere pubblicamente riserve sul modo di funzionare del green pass e sull’efficacia di altre misure adottate per contrastare la pandemia (con candore invidiabile il “corrierista” di lungo corso Beppe Severgnini avrebbe spiegato a uno scienziato, sul piccolo schermo, che certe cose non importa che siano vere: non si dicono sui mezzi di comunicazione di massa: non l’ho sentito con le mie orecchie ma “se non è vera è ben trovata”).
Questa volta nel mirino è entrato perfino Lucio Caracciolo, che per mestiere fa da parecchi decenni lo studioso di geopolitica, è pagato proprio per analizzare con il massimo distacco professionale i temi della geopolitica che non di rado sono guerre e non ha mai dato nessun motivo per essere sospettato, neppure lontanamente, di sovranismo e/o di populismo; ma nel clima fervido di queste settimane per guadagnarsi lo stigma del “Putinversteher” basta un’impronta vocale non sufficientemente alterata dallo sdegno, e bisogna ammettere che Caracciolo si esprime con un self control oggi inaccettabile, a quanto pare.
Da qualche settimana, per darsi un tono taluni usano il termine Putinversteher (quelli che comprendono Putin) rispolverando otto anni dopo la parola usata da Mathias Brücker e Paul Schreyer con trasparente ironia nel libro Wir sind die Guten – Ansichten eines Putinverstehers oder wie uns die Medien manipulieren (Noi siamo i buoni – Opinioni di un Putinversteher ovvero come i media ci manipolano). Da Putinversteher è stato trattato anche il presidente dell’Anpi perché il pacifismo, che in altre occasioni ha ricoperto l’Italia con i colori dell’arcobaleno, tra gli applausi dei media e delle autorità tutte, oggi è diventato una forma di intelligenza col nemico. Raffinati periodici di sinistra che si ricevono solo per abbonamento e normalmente offrono contenuti di prim’ordine, scrivono della resistenza opposta dagli ucraìni all’invasione della “superpotenza fascista” di Putin (“autocratica” o “dittatoriale” è troppo poco) mentre la guerra è in corso e probabilmente non solo noi del pubblico non siamo nelle condizioni migliori per capire che cosa sta accadendo, di là del fatto che è in corso un’invasione.
Non sarà “codardo oltraggio” quello dei media ma è obiettivamente qualcosa che ricorda scritte fino a pochi anni fa visibili sui muri di case diroccate: “credere, obbedire e combattere” o, se si preferisce, “chi non è con noi è contro di noi”. Altro che pacifismo. Chi non prende posizione è almeno “oggettivamente” alleato del nemico. Per dirla tutta, e qui il riferimento non è ai media ma al nostro presidente del Consiglio, anche enunciare l’alternativa tra libertà e climatizzatore (per esortare il popolo a accettare la prospettiva di un razionamento e/o maggior costo dell’energia elettrica) non suona molto diverso da quel “senza il grasso il cannone non spara” tristemente noto a chi avesse avuto figli o nipoti che scrivevano dal fronte, durante la Grande Guerra.
Anche se in materia vantiamo un discreto know-how, con ciò non si vuol dire che simili atteggiamenti siano un’esclusiva nostrana. Boris Johnson, meritatamente noto per la sua simpatica faccia di bronzo, ha superato sé stesso accusando la Chiesa d’Inghilterra di aver criticato il piano del governo di Sua Maestà (trasportare in Rwanda i migranti illegali) con più clamore di quello riservato alla condanna della Russia (con maggiore pertinenza, Johnson avrebbe potuto lamentare come non avesse sollevato nessuna critica la Danimarca quando, meno di un anno fa, aveva stipulato un accordo con il Kosovo che si era offerto di “ospitare” nelle proprie carceri un certo numero di stranieri già detenuti in Danimarca e destinati a una possibile espulsione, ma evidentemente la Chiesa d’Inghilterra nel Regno Unito fa più audience della Danimarca o del Kosovo).
Non che la campagna di sacrosanto odio nei confronti di Putin sia circoscritta al nostro Paese, per fare un solo esempio giorni fa lo Spectator, venerabile e venerando periodico conservatore inglese ha pubblicato una caricatura di Putin col volto deformato e, al posto dell’epidermide uno strato di piccoli teschi: un modo piuttosto macabro di prendere parte al linciaggio mediatico dell’autocrate moscovita che resta tale (rimane cioè un linciaggio) quali che siano le responsabilità e le colpe di Putin stesso e comunque ciascuno ritenga di qualificarle.
Le campagne di odio fanno naturalmente parte della guerra, ma il punto è che nessun paese occidentale, ad oggi, è parte di questa guerra. Come ha osservato, con tutto il peso della propria autorità, The Economist, “Giving Ukraine heavy weapons does not mean NATO is at war with Russia”. A parte il sapore leggermente tartufesco, da azzeccagarbugli, dell’argomento usato dal settimanale, sembra che proprio questa circostanza di non partecipare alla guerra guerreggiata induca nell’opinione pubblica occidentale (sia di chi la produce, sia di chi la assume) un senso di colpa che si può alleviare solo con la reiterata manifestazione di odio all’indirizzo del colpevole. L’ipotesi alternativa è che l’odio trovi terreno fertile nel risentimento e nella preoccupazione per il rincaro del costo della vita, che viene imputato a Putin e alla sua guerra, anche se è iniziato molti mesi prima ed è ovviamente moltiplicato dalla guerra economica e mediatica con cui il vero antagonista di Mosca, l’attuale amministrazione di Washington, ha spinto gli alleati occidentali, soprattutto europei, a reagire all’iniziativa bellica di Putin: quale delle due ipotesi sia “preferibile” dal punto di vista della psicologia collettiva, lo ignoro. Resta il fatto che questa caccia al putiniano anche malgré lui, per esporlo al pubblico dileggio, tradisce un lontano ma non lontanissimo costume nazionale, quello della delazione di massa (cfr. Eros e Priapo di Carlo Emilio Gadda, Garzanti, 1990).
Neppure può considerarsi una sorpresa il fatto che ancora una volta l’Unione europea si sia appalesata per ciò che sostanzialmente è, gamba economica e sociale che, insieme alla gamba militare della Nato, costituisce quella coalizione euro-atlantica che fa capo a Washington anche se entrambe le organizzazioni hanno “sede legale” a Bruxelles.
Alla finzione della Ue intesa come materializzazione del “sogno unitario” del popolo europeo nessuna persona assennata ha mai potuto credere, almeno negli ultimi 30-35 anni, ma l’effetto “rivelatore” della guerra da questo punto di vista è stato particolarmente efficace: se da un lato Zelensky ha malamente sbattuto la porta di Kiev in faccia al capo di stato del più popoloso stato-membro dell’unione, la Germania, volendo rinfacciare a Frank-Walter Steinmeier, già ministro degli Esteri, una pregressa politica filorussa o non sufficientemente antirussa della Germania, dall’altro la presidente della Commissione Ue, parlando di Ucràina ha detto: “C’è un sentimento di appartenenza, fanno parte dei nostri e vogliamo che ci raggiungano”, sorvolando sul dettaglio che l’ammissione di nuovi stati membri richiede il consenso unanime del Consiglio europeo al quale ciascuno stato membro partecipa con un voto.
Ma la circostanza degna di nota, anche se non inedita, è che nessuno si è permesso di ricondurre Ursula von der Leyen al rispetto delle proprie competenze. Si è già avuta ripetuta occasione di notare come, fedele al proprio ruolo di “gamba economico-sociale” del dispositivo euroatlantico, la Commissione europea si orienti preferibilmente secondo il vento che spira da Washington: lo si era già visto icasticamente quando, dopo il referendum “sudamericano” di Alexis Tsipras che rischiava di portare la Grecia fuori dall’Euro nel luglio 2015, il lungo tiramolla tra il ministro delle Finanze di Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, che proponeva un periodo di “congelamento” dell’economia greca fuori dalla moneta comune e Jack Lew, ministro del Tesoro di Barack Obama determinato a impedire l’uscita della Grecia dall’Euro, invitato (o più probabilmente autoinvitato) a seguire in diretta la trattativa della Grecia con Merkel, François Hollande, la Commissione e la Bce, si concluse con la totale sconfitta di Schäuble.
Last but not least, il clima bellico impoverisce, privandole della loro storia e di conseguenza della loro carica emotiva specifica anche parole molto importanti, e così accade che Joe Biden dica che quelli delle armate di Putin non sono crimini di guerra ma anche “genocidio”, che un suo funzionario lo corregga osservando che “Il genocidio include l’obiettivo di distruggere un gruppo etnico o una nazione, e finora non è quello che stiamo vedendo” e quindi si passi a altri argomenti. Parlare di genocidio così, en passant, è un segno del tempo febbrile che stiamo vivendo, che non consente di pesare le parole, nemmeno quella, “genocidio”, che l’America si è rifiutata di usare per un secolo a proposito dello sterminio di un milione e mezzo di armeni sudditi del sultano di Costantinopoli, e con Biden si è “rassegnata” a usare in una dichiarazione del 24 aprile 2021 che si conclude con una frase inequivocabile (“il popolo Americano onora tutti gli Armeni periti nel genocidio iniziato 106 anni fa”) ma puntualizza che non si vuole dare colpe ma assicurare che quanto accaduto non si ripeterà mai e in ogni caso si evita attentamente di menzionare quella che è stata l’erede universale dell’impero ottomano negli anni Venti del secolo scorso, cioè la Turchia. È ovvio, se posso esprimere un’opinione personale, che il capo della nazione di gran lunga più potente del pianeta (così come ogni capo di stato) dovrebbe esprimersi sempre e solo con questa attenzione, ma temo che oramai lo Statement by President Joe Biden on Armenian Remembrance Day, meditato per oltre un secolo e quindi formulato pesando ogni parola e ogni virgola, sia un’eccezione meritevole di entrare nelle antologie.
Della retorica alla quale ci si deve ormai abituare riporto qui di seguito uno scampolo che trovo particolarmente rappresentativo, un brano di un editoriale di Christian Rocca su Linkiesta:
“Prima Joe Biden, ora Emmanuel Macron, è proprio una bella festa di Liberazione dal fascismo populista quella che si celebra oggi.
Due ampie vittorie popolari con cui finalmente la democrazia liberale ha ripreso in mano il suo destino e, almeno temporaneamente, respinto le più devastanti bordate globali dei nemici della società aperta.
Dopo gli anni delle tenebre, cominciati con la Brexit e continuati con Trump e poi con la sconfitta del referendum renziano e l’ascesa dei movimenti eversivi di destra e di sinistra in particolare nell’Italia del bipopulismo perfetto, il fronte repubblicano e costituzionale dell’Occidente ha ripreso la guida del mondo libero, minacciato da Vladimir Putin e dall’alleanza dei regimi autoritari prima con gli hacker, gli aiuti ai partiti antisistema e la manipolazione dell’opinione pubblica, grazie al bug digitale offerto dal modello di business dei social network, ma ora anche con i carri armati, il genocidio e le minacce imperialiste e nucleari all’Ucraina e all’Europa”.
C’è tutto, in queste righe, dopo l’incipit gioioso per l’affermazione di Emmanuel Macron, c’è anche il “mondo libero”, il “fronte repubblicano e costituzionale dell’Occidente”, uno scoop, la notizia (implicita, certo) che il “referendum renziano” sarebbe stato sconfitto dall’onda nera del Brexit e di Trump: mi pareva di ricordare che in realtà quel referendum andò a scontrarsi contro il muro eretto dalle migliori menti del progressismo nazionale, che accusavano Renzi, e non per modo di dire, di voler introdurre in Italia un regime peggiore di quello fascista, ma forse mi confondo.
È il clima della nuova guerra (non tanto) fredda che anche prestigiosi studiosi americani preconizzano, a cominciare da Robert Kagan: molti ma non tutti. Anche in una sede che più establishment non si può, come Foreign Affairs, c’è chi solleva argomentate obiezioni, respinge l’idea di “cavalcare” la guerra di Putin per regolare i conti col regime putiniano e la Russia stessa, altri che scrivono addirittura della “Fantasia del mondo libero”. Senza che nessuno rischi di sentirsi dare del Putinversteher.
Nel cuore del mondo egemonizzato dall’America il dibattito è ancora consentito, e soprattutto viene praticato. Anche mentre è in corso una guerra che lo riguarda (il cuore) molto da vicino. Nelle periferie è diverso. Bisogna sapersi accontentare.