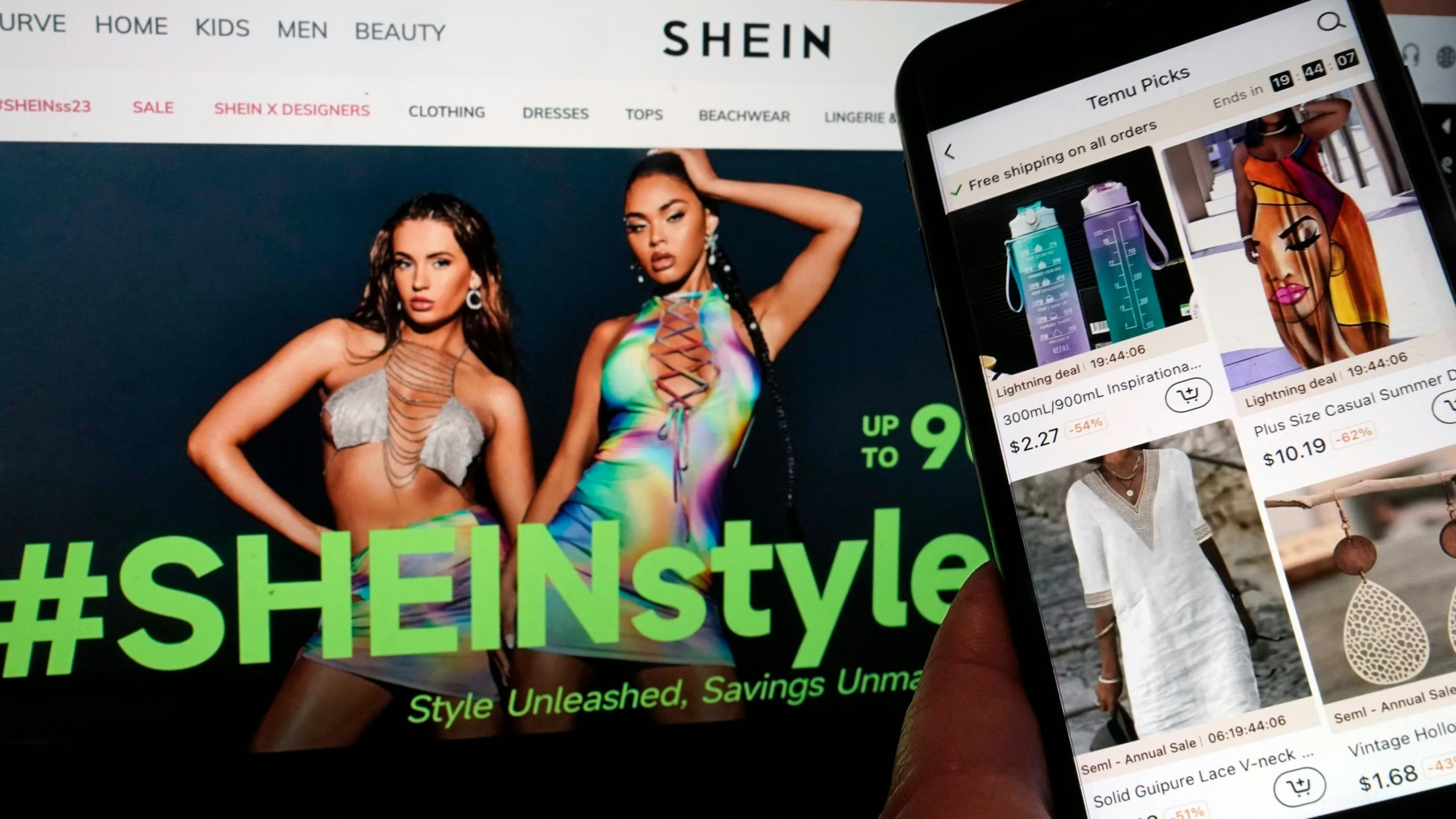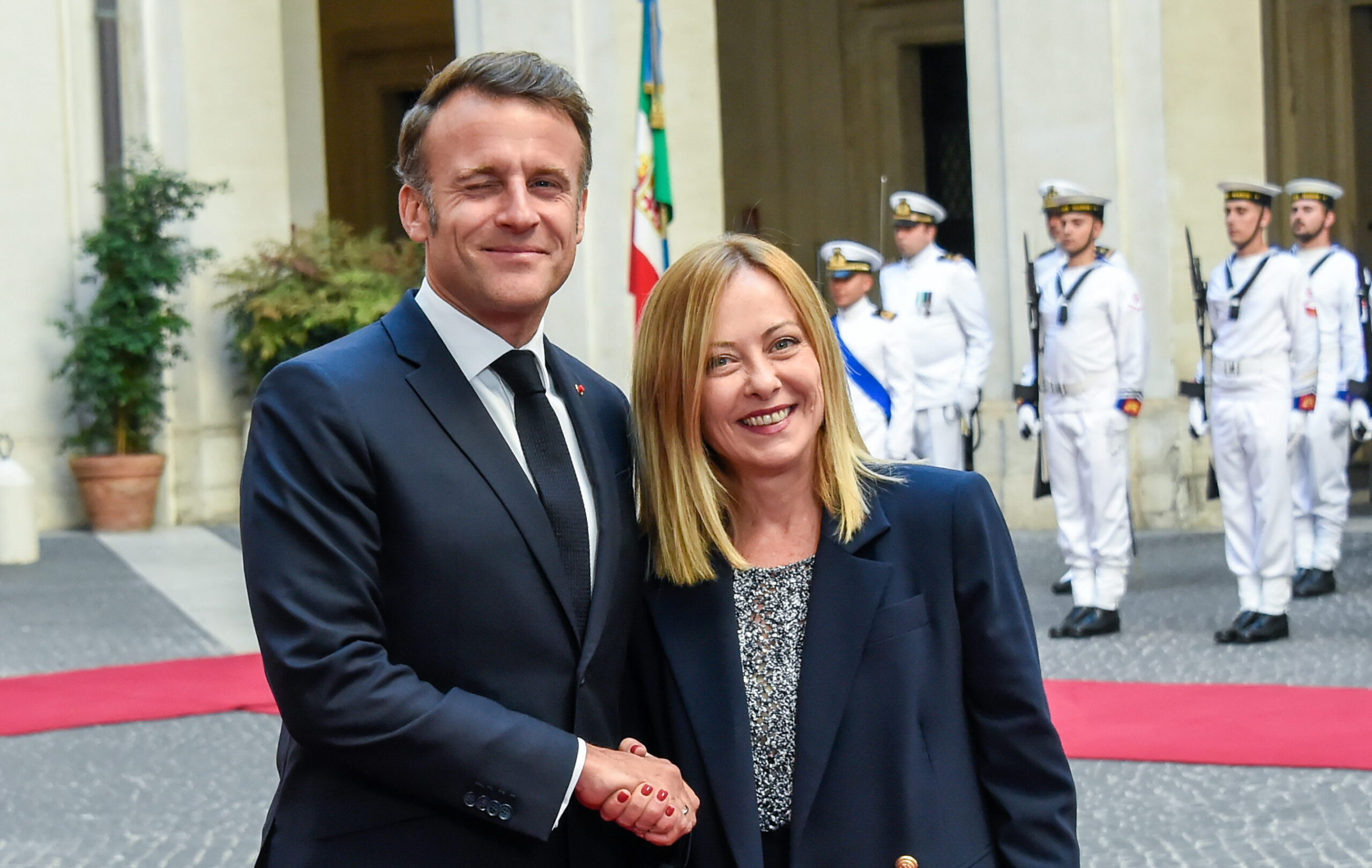Se le cose non vanno come dovrebbero andare, è colpa di “quel che rimane della cosiddetta borghesia produttiva”? Ferruccio de Bortoli, dalle colonne de Il Corriere, non ha dubbi. Le “manca qualcosa”, al di là dei meriti indubbi. Le “manca l’assunzione di un progetto per il Paese. Sulle proprie spalle, non su quello dello Stato di cui si teme, giustamente, un eccessivo allargamento proprietario ed assistenziale o a carico di una politica accusata di incompetenza ed avventurismo”. Per la verità non è la prima volta che intellettuali critici scendono in campo contro le élites produttive del Paese. Anche se, in passato, imputato numero uno era soprattutto la piccola e media borghesia. Quelle persone troppo “legate alle proprie occupazioni e professioni”. Completamente “immerse nelle proprie attività economiche e commerciali, troppo prese dal proprio privato”. Come sosteneva Ernesto Galli della Loggia, in un vecchio editoriale, sempre sul Corriere della sera (24 aprile 2014).
Che le responsabilità siano, invece, più che diffuse, è fuori discussione. Che vi sia un sintomo di risveglio, ai piani alti dell’industria italiana, pure. E’ in qualche modo dimostrato dalle vicende più recenti di Confindustria. Le prime mosse del neo presidente Carlo Bonomi lasciano intravedere che forse qualcosa sta cambiando in quel mammut carico di storia, ma soprattutto di affanni. Fosse così, l’invito di de Bortoli non sarebbe altro che il generoso tentativo di accelerare i tempi. Del resto lo stesso neo presidente aveva annunciato ch’era sua intenzione predisporre, entro l’estate, un grande piano per l’Italia. Avendo come orizzonte gli anni 2030-2050. Il che la dice lunga sulla complessità dell’opera. Nella speranza, sempre, di poterci arrivare.
Siamo in ritardo. Non questa o quell’organizzazione. Ma il Paese tutto. Nelle cose che abbiamo avuto modo di leggere in questi giorni, vi sono esortazioni, linee generali, desideri. Ma quanto a concretezza, quasi nulla. Lo stesso centro studi di Confindustria, nell’assenza di qualsiasi indicazione governativa, si limita a semplici previsioni, per così dire, a “politiche invariate”. Ossia in assenza di un’impostazione programmatica volta prefigurare possibili alternative. Esercizio comunque lodevole: dimostra che sotto i piedi dell’economia italiana si sta spalancando un baratro. E che le inevitabili forti perdite del 2020 non saranno che minimamente compensate dal rimbalzo dell’anno successivo. In un bilancio che vedrà una decrescita netta di altri 4 punti di Pil, che si sommeranno ai ritardi maturati dal 2008 in poi.
Il “che fare?” diventa, quindi, un drammatico imperativo. Ed è su questo aspetto che dovrebbe concentrarsi l’attenzione generale. E non solo di “quel che rimane della borghesia produttiva”. Non si dimentichi che nell’immediato dopoguerra furono uomini come Ugo La Malfa e Carlo Sforza a guidare il processo di liberalizzazione degli scambi, che fu l’antefatto del “miracolo economico”. Allora il mondo degli industriali era spaccato come una mela: tra protezionisti e liberisti. Oggi, per fortuna, non è più così. L’Italia è stabilmente inserita nelle grandi catene del valore. Un assetto stabile, se non interverranno fatti di natura traumatica.
E’ tutto il resto che non va. Al quale occorrerà rimediare. Operazione non semplice, che richiederà un vasto programma di intervento. Ed allora individuare il tragitto e le tappe intermedie diventa assolutamente necessario. Il primo obiettivo intermedio non può che essere una politica che punti al pieno utilizzo delle risorse esistenti. Operazione tanto più generale se si considera che tutte le previsioni indicano un forte aumento della disoccupazione, destinata a superare l’11 per cento, nel 2021. Occorre pertanto ridurre lo scarto che dal 2012 in poi si è manifestato tra risparmi (molti superiori) ed investimenti. Scarto misurato dalle poste attive del conto finanziario: in generale pari a circa 50 miliardi all’anno.
Basterà per questo rilanciare i soli investimenti pubblici? Ne dubitiamo. Essi sono pari a poco più del 2 per cento del Pil. Quindi per quanto si possa sburocratizzare, i risultati saranno sempre modesti. Anche immaginando ch’essi possano aumentare del 50 per cento, il loro contributo in termini di crescita complessiva non sarà superiore all’1 per cento, al netto degli effetti moltiplicativi. E’ allora evidente che bisognerà agire su altre variabili. Come il complesso degli investimenti privati che ammontano ad oltre il 15 per cento del Pil. Quello è il comparto su cui intervenire per avere risultati significativi, anche nel breve periodo.
Tuttavia, le difficoltà nel rimettere in moto una macchina così potente sono molte. Non solo burocratiche amministrative. Gli investimenti possono riprendere solo se c’è mercato. Vale a dire se c’è una domanda da soddisfare. Non è un caso se, in tutti questi anni, essi si sono concentrati soprattutto in quei settori legati all’esportazione. Mentre Il ristagno della domanda interna è stato una delle cause principali del loro calo progressivo: 3 punti di Pil dal 2008 al 2019. Una volta e mezza gli investimenti pubblici. Ecco, allora, dov’è necessario intervenire. Ma farlo in modo strutturale. Quindi niente bonus, elargizioni del principe, mance varie che producono piccoli rimbalzi e grandi illusioni.
Occorre, invece, mettere mano, seppur con la necessaria gradualità, ad una grande riforma fiscale, che segni il passaggio dal secondo al terzo millennio. Dovrà essere business oriented per spingere al massimo l’acceleratore degli investimenti, facendo leva sul mutamento delle aspettative imprenditoriali. Che sono poi le bussole che consentono di superare le colonne d’Ercole. Troppo asimmetrica, nei confronti di quel welfare che molti vorrebbero potenziato? In un primo momento, inevitabilmente. La ricostruzione, nell’immediato dopo guerra, non fu una passeggiata. Al contrario, fu caratterizzata da grandi sacrifici imposti alla stragrande popolazione italiana. Gettò, tuttavia, le basi che ci hanno consentito di vivere nei decenni successivi. Cosa che non va dimenticata.