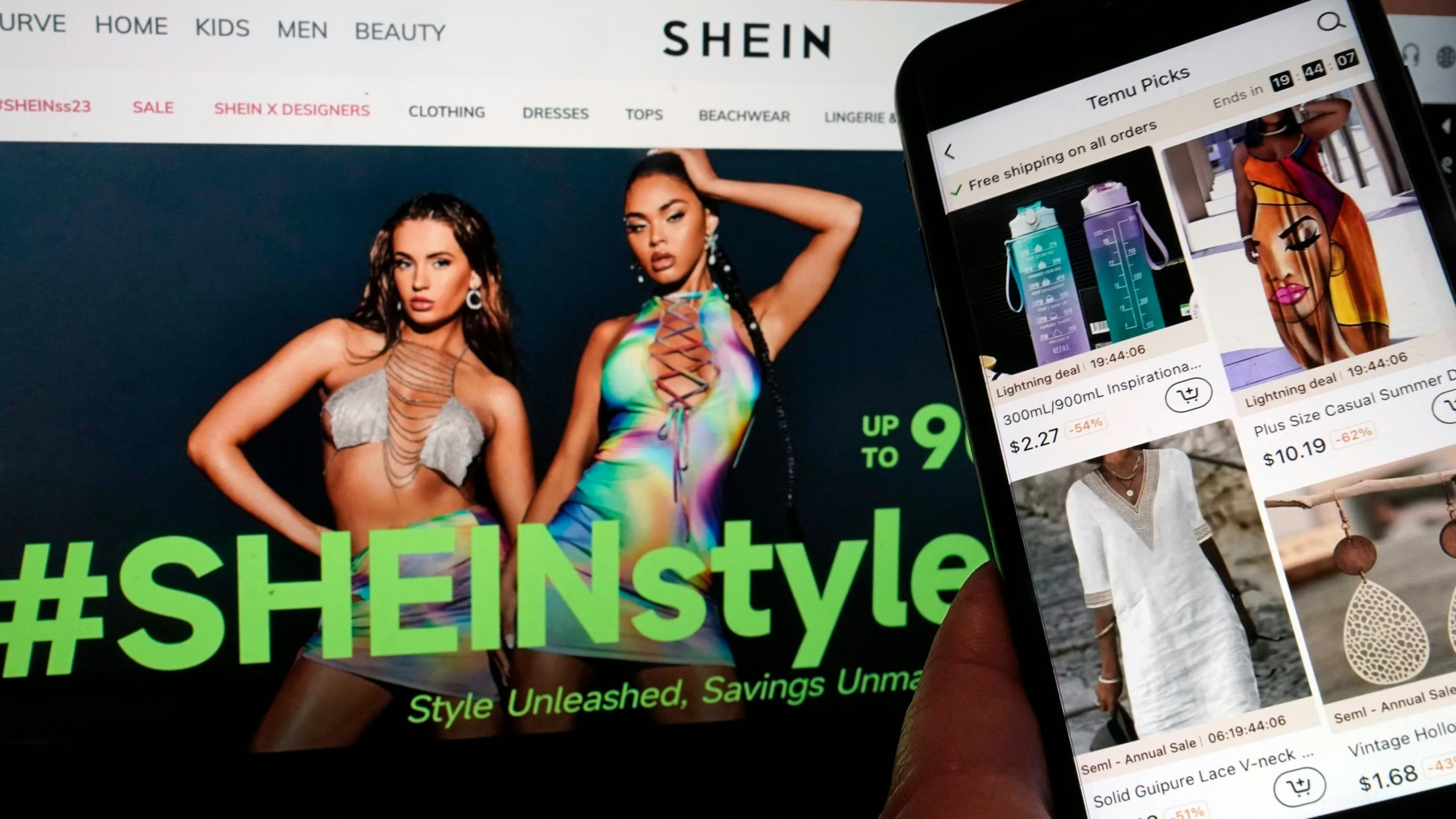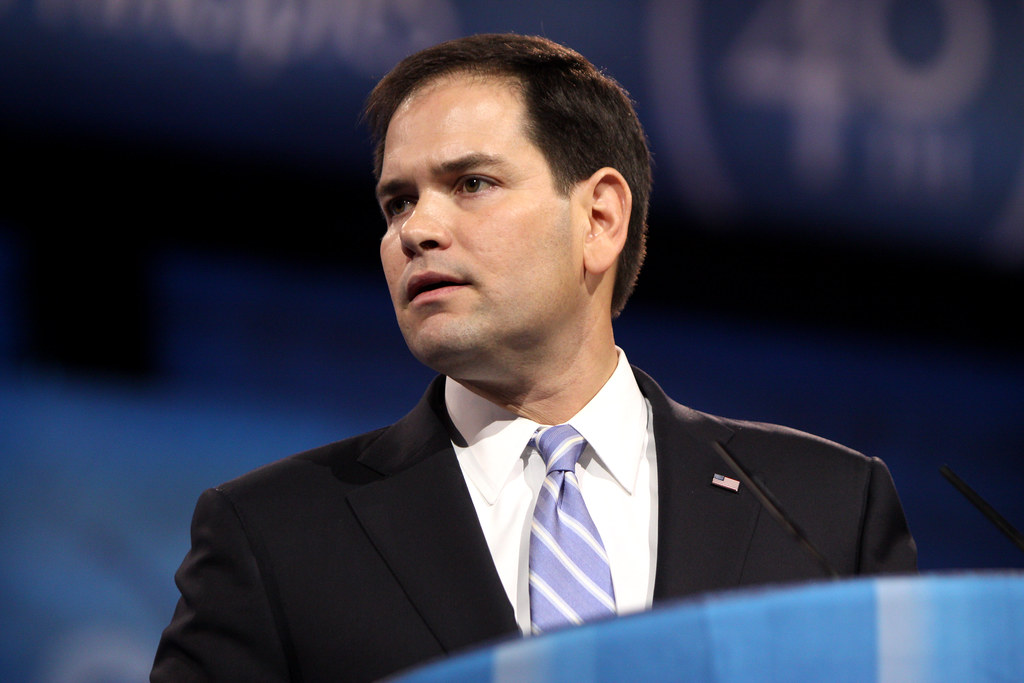Questa volta è vietato sbagliare. Non sono ammissibili tentennamenti o viaggi della speranza, come quello di Romano Prodi in terra di Spagna, per convincere José Aznar a ritardare di un anno l’ingresso nell’euro. Con tutto il seguito di polemiche che accompagnò quel tentativo. Questa volta, il Governo deve prendere il diavolo per le corna ed elaborare una propria proposta per la riforma del Patto di stabilità e crescita (PSC). Discussione che, nella sede della Commissione europea, è già cominciata. E non certo sotto i migliori auspici.
Ci sono le condizioni per farlo? Certo che si. Il Governo Draghi ha, al tempo stesso, la massima rappresentanza politica e, nei posti chiave, quanto di meglio possa offrire la società italiana. Il che comporta un duplice vantaggio. Da un lato un gruppo dirigente in grado di misurarsi con la complessità dei problemi, senza cedere alle esigenze immediate della bottega elettorale. Dall’altro una rappresentanza delle forze politiche italiane, che più vasta non si può. Per cui nessuno potrà tirarsi indietro, con la scusa di non aver fatto parte della compagine governativa. E quindi di essere mondo da colpe eventuali.
Per capire il da farsi occorre partire dalla legislazione europea. Senza limitarsi al solo Patto di stabilità e crescita (PSC). Tanto meno al Fiscal compact, il cui inserimento nell’ordinamento giuridica europeo fu bloccato da un voto contrario del Parlamento. A dimostrazione, se non altro, della sua scarsa popolarità. È tutta la legislazione che va riconsiderata: soprattutto quella parte meno nota al grande pubblico, perché eccentrica rispetto al pensiero unico dell’austerity for ever.
Si deve, quindi, partire dall’articolo 120 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE). Che anche da un punto della sua collocazione testuale, viene prima delle regole del PSC (art. 126). Si tratta di un complesso di norme che riguarda gli andamenti della politica economica, considerata “una questione di interesse comune” (art. 121 (1)) per l’intera UE. Il relativo controllo, secondo quanto previsto dal regolamento 1176/2011, è affidato ad una procedura che è più o meno identica a quella, più nota, del PSC. Naturalmente i parametri sono diversi: una batteria di indicatori che riguarda i principali aspetti della congiuntura, economica e finanziaria. Che trovano la loro sintesi nell’alert mechanism: un campanello d’allarme, che suona al primo insorgere di eventuali squilibri macroeconomici.
L’esame, tuttavia, questo il paradosso, non solo non è congiunto con quello relativo al PSC, ma le due due procedure marciano in parallelo senza incontrarsi mai. Ed i relativi giudizi non si relazionano né si sovrappongono. Come se gli aspetti di finanza pubblica fossero indipendenti dalla performance dell’economia reale. E viceversa. E quindi come se il sistema economico non fosse un tutt’uno. Ma costituito da due strati indipendenti e separati. Potenza di un’ortodossia, che non ha mai digerito Keynes e le sue possibili ricette.
La cosa più sorprendente è che questa asimmetria si ricompone solo nel momento in cui si tratta di intervenire con il Mes (European Stability Mechanism). Quando si devono finanziare Paesi in crisi. È allora che scatta quella “condizionalità rafforzata” (Enhanced Conditions Credit Line, ECCL), che può portare al commissariamento del Paese debitore, imponendogli una politica economica rivolta, appunto a sanare quegli squilibri macroeconomici, che sono all’origine della crisi. Con tutto il rispetto: logica da banchieri, più che da economisti. Altrimenti l’analisi dei fondamentali sarebbe una costante. Nella buona e nella cattiva sorte.
Nel momento in cui la Commissione dovrà discutere della riforma del PSC, i rapporti tra questi diversi schemi interpretativi dovranno essere riconsiderati, al fine di una diagnosi non più scissa, ma sistemica. Gli aspetti di natura finanziaria (deficit, debito, spesa pubblica, ecc.) dovranno essere messi in relazione con le altre variabili economiche: tasso di crescita, disoccupazione, rapporti con l’estero e via dicendo. Al fine di giungere ad una diagnosi veritiera e, quindi, ad una terapia adeguata.
L’esistenza di uno squilibrio macroeconomico, ad esempio un forte deficit della bilancia dei pagamenti, legittima politiche di bilancio più severe, per ridurre l’eccesso di domanda interna, rispetto al potenziale di sviluppo. Al fine di assorbire il relativo gap. Ma se la bilancia dei pagamenti è in attivo, come in Italia, allora, dovrebbe essere possibile creare un deficit pubblico maggiore, al fine di evitare eccessi di risparmio, che non hanno contropartita nei livelli di investimento e prendono, pertanto, la via dell’estero. Sarebbe la via per avere un ritmo di sviluppo maggiore, una maggiore inflazione e, quindi, una riduzione del rapporto debito/Pil.
Come si vede, la prospettiva può cambiare rapidamente e legittimare politiche opposte, che un semplice algoritmo (il 3 per cento di deficit o il rapporto debito/Pil al 60 per cento) difficilmente riesce a catturare. Naturalmente l’Italia avrebbe tutto da guadagnare nella formulazione di un giudizio più articolato e meno manicheo. Per fortuna il neo ministro dell’Economia, Daniele Franco, conosce molto bene i problemi di finanza pubblica. Gli basterà quindi un niente per collegare le varie tessere di un puzzle, che, come insegna l’esperienza, ha nell’economia reale il suo effettivo baricentro.
(2. fine: la prima parte dell’analisi si può leggere qui)