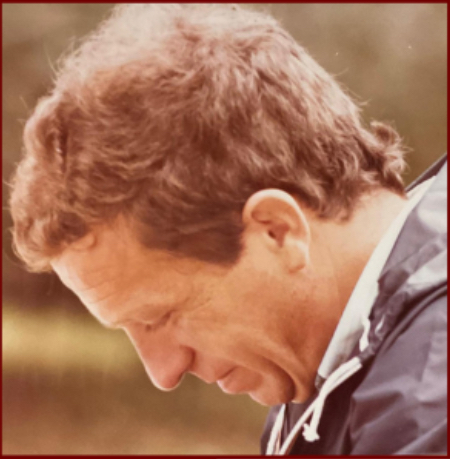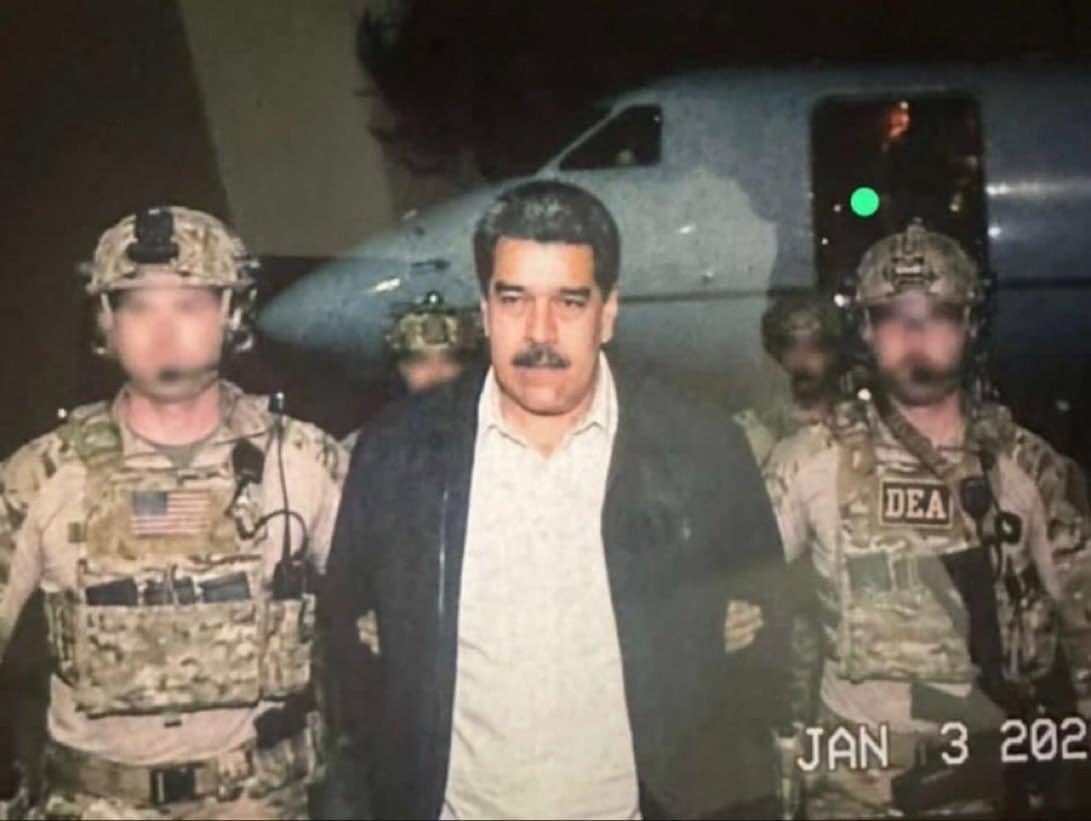Caro direttore,
chiedo venia a lei e ai lettori se mi vedo costretto a citare nuovamente una celebre quanto abusata battuta di Ennio Flaiano: “La situazione politica in Italia è grave, ma non è seria”. Essa infatti calza a pennello ogni volta che il Parlamento è chiamato a discutere gli impegni del governo nel Consiglio europeo. E puntualmente, anche mercoledì scorso, le Camere hanno ospitato uno spettacolo tragicomico.
Atto I: Giorgia Meloni fa votare la maggioranza a favore delle parti del documento di Azione più indigeste a Matteo Salvini: sostegno militare all’Ucraina, contrasto alla guerra ibrida di Mosca, lotta al contrabbando di petrolio russo, adesione dell’Ucraina all’Ue.
Atto II: la Lega si adegua e il “campo largo” si spacca. Pd e Iv si astengono per non indispettire M5S e Avs. Conte e Fratoianni-Bonelli se ne infischiano, e votano contro lo stesso. Tutti contro tutti, e nessuno con Carlo Calenda.
Intervallo: il presidente del Consiglio lascia a verbale, nel foyer delle sue repliche, che di modificare la regola dell’unanimità non se ne parla, e che sul progetto di Difesa europea è bene che ciascuno decida per sé, perché la Difesa è una competenza esclusiva degli Stati nazionali. L’internazionale sovranista, insomma, contrapposta all’Europa come “comunità di destino”.
Atto III: mentre le Camere discutevano della questione ucraina, scorrevano le immagini dell’asilo colpito da un drone russo a Kharkiv, e di Kyiv sotto una pioggia di missili. Giuseppe Conte, con una coerenza che gli fa (dis)onore, ribadisce il suo no all’invio di altre armi. Ma, da buon cattolico (ecco la novità), sollecita nel contempo “misure di sostegno umanitario e aiuti alla popolazione civile”. Come a dire: lascio che ti distruggano casa, ma in cambio ti dò una minestra calda.
Nelle stesse ore, gli europarlamentari pentastellati si astenevano sulla mozione che definiva Aleksandr Lukashenko un dittatore, mentre Bruxelles consegnava il premio Sacharov a due giornalisti dissidenti attualmente in carcere, il bielorusso Andrzej Poczobut e la georgiana Mzia Amaglobeli.
Atto IV: visto il cafarnao di posizioni sull’Ucraina, i partiti del campo largo si ricompattano sul riconoscimento della Palestina “quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 e con Gerusalemme quale capitale condivisa, che conviva in pace, sicurezza e prosperità accanto allo Stato di Israele…”.
È il degno epilogo del dramma o, se si preferisce, della farsa andata in scena a Palazzo Madama e a Palazzo Montecitorio. Perché chi invoca il ritorno ai “confini del 1967” per risolvere il conflitto israelo-palestinese non sa di cosa parla. Quei confini, infatti, non sono altro che le linee del cessate il fuoco stabilite nel 1949, al termine della guerra d’indipendenza israeliana. Non sono mai stati riconosciuti come frontiere ufficiali da nessuno, tant’è che la stessa Risoluzione 242 dell’ONU (1967) parla di “confini sicuri e riconosciuti”, senza mai menzionare un ritorno alle linee pre-1967.
Nel 1967, Giudea e Samaria erano sotto occupazione giordana, mentre Gaza era sotto occupazione egiziana. Come osservò Golda Meir: “Se queste linee erano così inviolabili, perché gli arabi le attraversarono nel 1948 e nel 1967 per cercare di distruggere Israele?”.
La Guerra dei Sei Giorni scoppiò proprio perché Egitto, Giordania e Siria minacciarono apertamente Israele, chiudendo lo Stretto di Tiran (e il canale di Suez) e schierando eserciti offensivi ai confini. Dalla vittoria di Tel Aviv nacque un nuovo scenario geopolitico, in cui Israele si ritrovò a controllare territori che nessun altro Stato aveva mai rivendicato.
A differenza della Giordania, Israele non ha mai formalmente annesso quei territori, mantenendone lo status come “disputati” -cioè soggetti a futuri negoziati. Questo spiega perché il termine “occupazione” è fuorviante: un’occupazione presuppone un sovrano precedente legittimo, ma nessuno Stato palestinese è mai esistito su quei territori.
Chi insiste sul ritorno ai “confini del 1967” ignora non solo la storia, ma anche il diritto internazionale (Risoluzione 242 dell’Onu) e le ripetute opportunità di pace rifiutate dagli arabi palestinesi. La vera questione non è dove tracciare i confini, ma se esista davvero la volontà politica di riconoscere Israele come Stato ebraico, e porre fine al conflitto.
Caro direttore, la tregua imposta ad Hamas dal piano di Trump è ancora appesa a un filo sottile, ma può costituire il primo passo di un processo che veda, in prospettiva, la coesistenza pacifica di due popoli e due Stati. A condizione, però, che si rispetti la verità dei fatti.