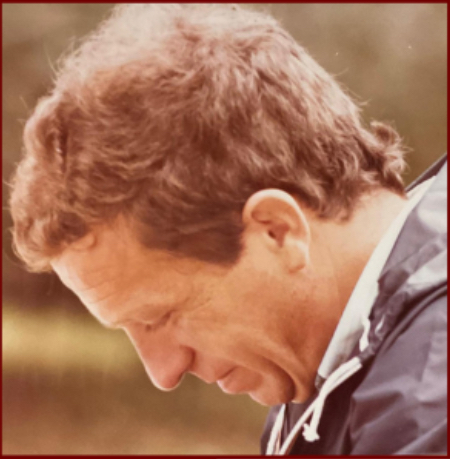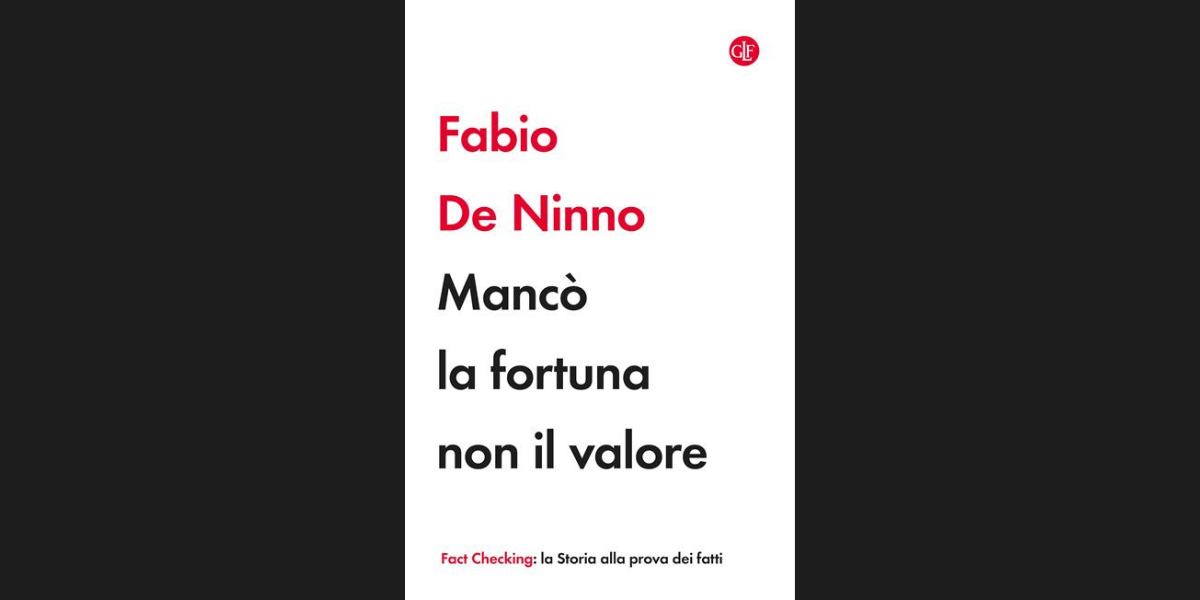Caro direttore,
“Non ci sono fatti, ma solo interpretazioni”, recita una famosa frase di Nietzsche. Essa è tuttora spesso fraintesa. Infatti, non intende affermare che la realtà non esiste (in questo caso, sarebbe insensata). La polemica si riduce a zero ammettendo che quando discutiamo usiamo perlopiù descrizioni “interessate” di fatti. Abbiamo cioè degli “interessi”, e questi interessi giocano un ruolo importante nelle nostre ricostruzioni dei fatti, soprattutto quando ci confrontiamo con altri che hanno interessi diversi dai nostri.
L’affermazione di Nietzsche, pertanto, va a sua volta interpretata. Era espressione del nichilismo tardo-ottocentesco, avverso alla cultura europea di quell’epoca, segnata da uno sviluppo esplosivo delle scienze. Sviluppo che implicava una forte specializzazione dei saperi e la conseguente impossibilità di padroneggiare con una lettura unitaria la realtà e la conoscenza. La frase del filosofo tedesco significa quindi che non è più possibile una visione unica, diretta, semplice e chiara della realtà, ma siamo costretti a fare i conti con una pluralità di prospettive, punti di vista, saperi diversi e contrastanti fra loro.
Questa idea di Nietzsche venne poi ripresa in Italia da Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti, che lanciarono nel 1983 il cosiddetto “pensiero debole”. Una posizione anch’essa a lungo fraintesa come un presunto anti-realismo, mentre era una variante del “falsificazionismo” di Karl Popper. Semplificando molto, sostiene che, quando discutiamo e ragioniamo, dobbiamo presupporre che le nostre verità possono sempre essere riviste.
Il guaio, caro direttore, è che viviamo in un tempo in cui le verità possono modificarsi, ma le menzogne sembrano inscalfibili. Mi consenta di fare un esempio.
“Alcuni mesi fa [quando?], il capo negoziatore ucraino a Istanbul, David Arakhamia, aveva detto [dove, in che occasione?] che il governo Zelensky aveva deciso di abbandonare i negoziati per varie regioni, tra cui le pressioni dell’allora premier britannico Boris Johnson”.
Il brano di questo articolo non firmato, apparso sul Fatto Quotidiano il 17 maggio 2024, si riferisce ai colloqui svoltisi nella metropoli turca tra febbraio e aprile 2022. È la storiella che Marco Travaglio ama ripetere da quasi tre anni nei suoi editoriali e nelle sue comparsate televisive.
Il problema, come ha ricordato Marco Setaccioli, un opinionista che conosce come le sue tasche l’Ucraina e la sua lingua, è che in un’intervista rilasciata alla giornalista ucraina Natalia Moseichuk, andata in onda il 24 novembre 2023 sulla rete televisiva 1+1, Arakahmia dichiara esattamente il contrario di quanto sostiene Travaglio. Non ci fu nessuna bozza di accordo, tanto meno un accordo sottoscritto (Putin dixit), e Johnson visitò Kyiv dopo la rottura delle trattative (poiché Mosca si riservava un potere di veto su eventuali interventi a difesa della sicurezza di Kyiv).
Questi i fatti (appunto), confermati dalle ricostruzioni (appunto) di Foreign Affairs e del New York Times. Travaglio che, con l’onestà intellettuale che lo contraddistingue, una volta ha confessato di non cavarsela molto con l’inglese, probabilmente non le ha lette. E forse per questo non è in grado di contestarle rendendole “deboli”.