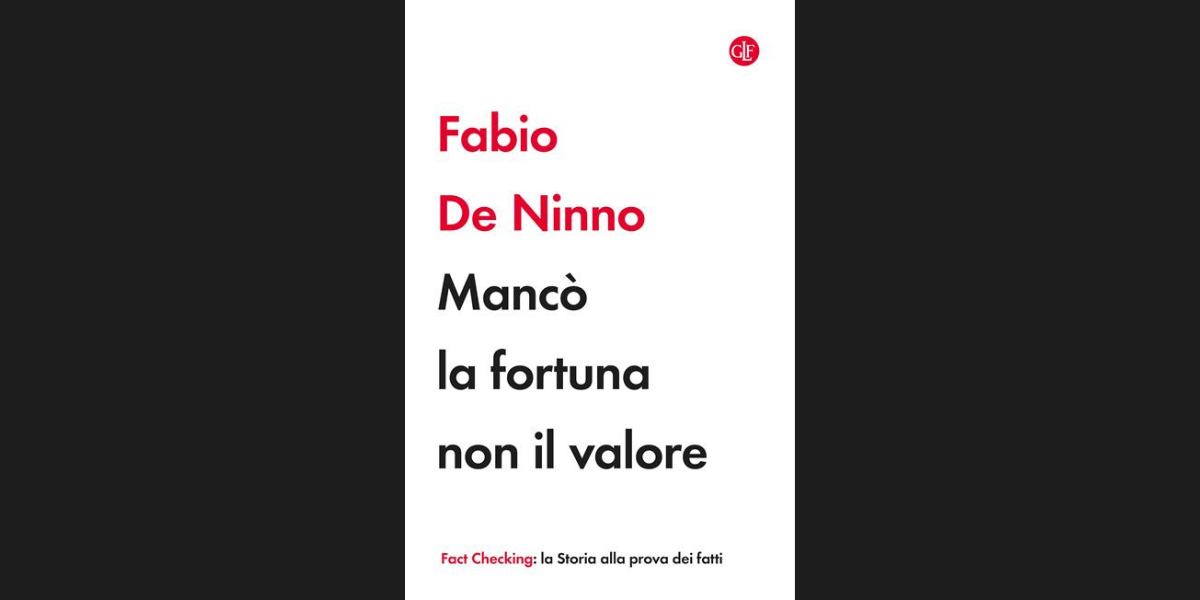Il caso del generale Roberto Vannacci si distingue dai precedenti analoghi, numerosissimi, per la coralità e l’immediatezza della condanna. Il ministro Guido Crosetto, in particolare, ha subito catalogato come “farneticazioni” alcune frasi che i media hanno estrapolato dal libro dell’ormai ex direttore dell’Istituto geografico militare e altrettanto celermente comminato la pena cautelativa, consistente per l’appunto nella sostituzione dal prestigioso incarico.
Incarico che si lega all’unico punto senz’altro condivisibile del trasversale colpevolismo: l’inammissibilità della mancata autorizzazione. Chi riveste certi ruoli non può pubblicare il proprio pensiero “a titolo personale” senza chiedere prima il permesso di farlo. In questo, si richiama il precedente di Marcello De Angelis, del quale si è sindacato il contenuto delle affermazioni, cioè la perplessità (per usare un eufemismo) verso le sentenze sulla strage di Bologna, mentre ci sarebbe stato da insistere sulla disinvoltura con la quale Marcello De Angelis ha pubblicato tali affermazioni sui social media, senza preoccuparsi del proprio incarico di responsabile della comunicazione della Regione Lazio.
Per il resto, i due casi sono diametralmente opposti. Il generale Vannacci ha rivendicato le proprie espressioni, se n’è attribuito la responsabilità e ha subito in silenzio le conseguenze, per ora, riservandosi di ricorrere nelle sedi opportune. De Angelis ha chiuso la vicenda con una maldestra marcia indietro, dopo avere preventivamente evocato il proprio martirio al quale, però, non si è sottoposto fino in fondo.
Entrambe le situazioni, come accennavamo, rientrano in una lunghissima serie di esponenti di enti pubblici, manager delle società partecipate, ministri, sottosegretari e alte cariche dello Stato (il presidente del Senato) finiti nel mirino dei media per gaffe di vario genere. Una scia alla quale si oppone l’atteggiamento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rimproverata invece di “non parlare”, ad esempio di non aver esplicitato la “matrice fascista” nel suo messaggio sull’anniversario della strada di Bologna del 2 agosto, dopo che il presidente della Repubblica l’aveva evidenziata nel proprio.
Lo scenario nel quale ci muoviamo è quello della cosiddetta ideologia woke, un politicamente corretto integralista che richiede sempre nuove e più convinte adesioni. Lascia perplesso come i personaggi pubblici che così frequentemente finiscono in tale mirino si meraviglino delle conseguenze delle proprie frasi e si difendano, sin dalle prime reazioni, dietro il velo del fraintendimento o dell’equanimità: “Perché non posso ripetere quello che altri hanno già detto?”. Non si capisce se sia in corso una epidemia di ingenuità, davanti a certe scuse. Il generale Vannacci lo ha detto in modo semplice e chiaro: esiste una “dittatura delle minoranze” per cui chi non detiene il potere effettivo persegue quello ideale.
C’è da chiedersi semmai perché le opposizioni di sinistra e 5 Stelle sposino tale assioma “gramsciano”, insistano in una strategia che assai improbabilmente porterà loro un significativo aumento di consenso. Basterebbe ricordare i radicali, che con le storiche battaglie vinte sui diritti civili hanno culturalmente rivoluzionato l’Italia senza però guadagnare granché in voti. Questa distrazione di massa, le schermaglie retoriche, la logomachia sono comprensibili da parte dei governi, casomai, mentre chi li contesta dovrebbe mettere a fuoco questioni e addurre prove ben più sostanziali.
La spiegazione è probabilmente che siamo tutti irrimediabilmente coinvolti da questa cortina di fumo, dalla generale simpatia verso le non notizie, i bluff che permettono di tranciare immediati giudizi con pretesa di assoluto. Si tratti del match tra Musk e Zuckerberg o delle corna rimproverate in pubblico a Torino. Si tratti dell’aumento del benzinaio varesotto dovuto a una lite di carattere privato, come ha subito spiegato lo stesso esercente, ma assunto a paradigma del generalizzato e però più contenuto rincaro dei carburanti. O del conto pagato dall’ambasciata a Tirana, con soldi di Meloni, ai nostri connazionali portoghesi. O degli altri conti in cui sono stati inseriti la voce taglio del tost e del piattino per le trofie, quest’ultimo sollevato come scandalo da un’influencer che però aveva ordinato appena un primo e un secondo in tre persone (bimbo incluso).
Il conformismo e la confusione informativa imperano nelle società contemporanee in nome di una malintesa democrazia. Pandemia e guerra in Ucraina hanno sicuramente aggravato tali atteggiamenti che, però, rappresentano la comprensibile reazione alla complessità della globalizzazione, per cui siamo tutti soggetti a un sovraccarico informativo senza disporre di strumenti di orientamento e comprensione. Pensiamo soltanto alle estenuanti diatribe sui migranti: se, al di là degli aspetti umanitari, siano da considerare una risorsa per il nostro sistema economico oppure gli attori di un depauperamento del lavoro che rasenta la schiavitù.
Un altro elemento che connota questi scenari informativi è la polarizzazione. Sposare tesi preconcette e preordinate determina il posizionamento su punti molto distanti dello scacchiere opinionistico. Al conformismo si abbina così la faziosità, mentre i temi richiederebbero un paziente esercizio di articolazione del pensiero: si tratti del clima, del disagio nelle carceri, si tratti della querelle Spalletti-De Laurentiis.