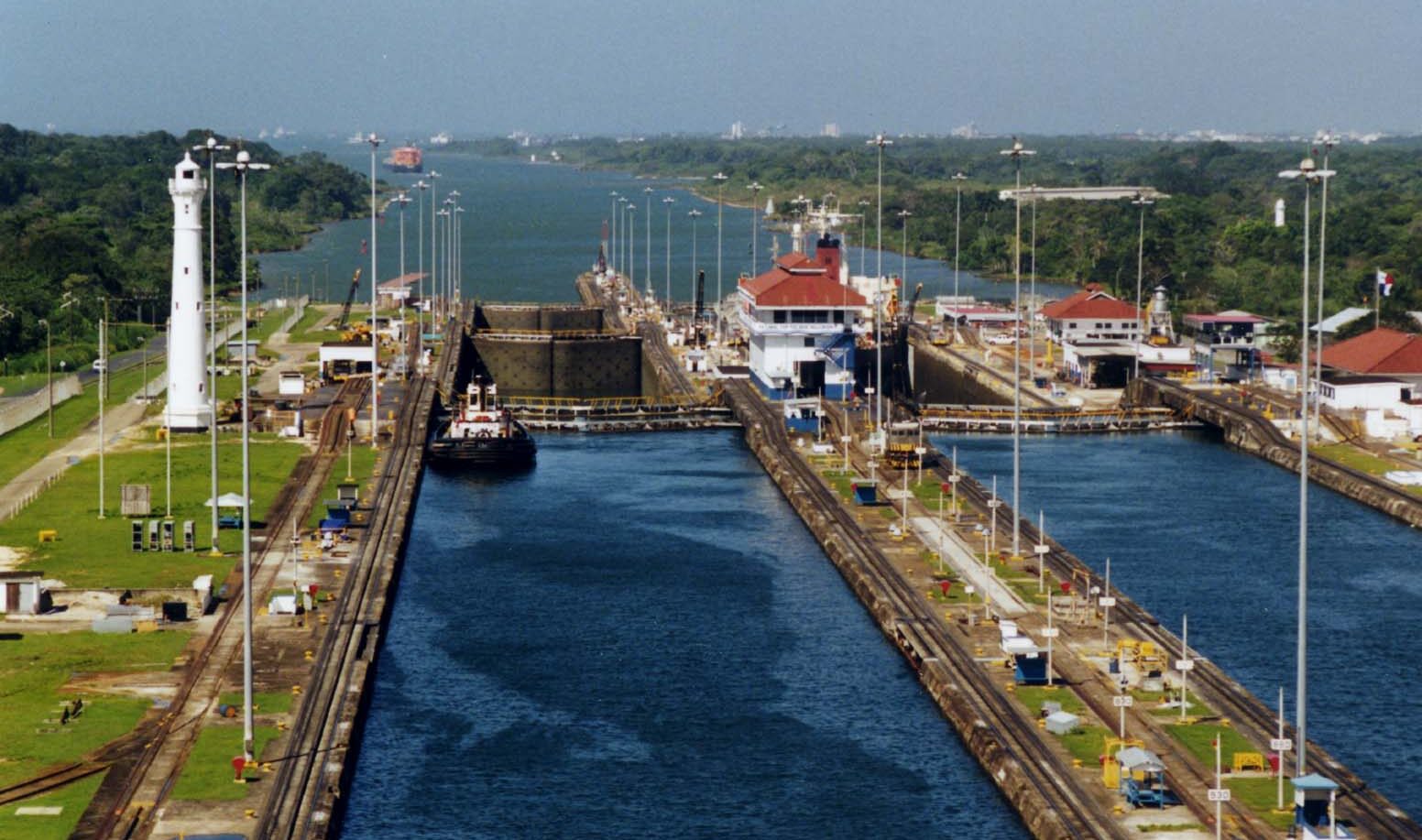“Il futuro dei rapporti atlantici – ha fatto notare Angelo Panebianco, dalle colonne del Corriere della sera – “va al di là di Trump. Si illudono quelli che pensano che, dopo di lui, le relazioni fra Stati Uniti e Europa saranno di nuovo quelle di un tempo. Quel tempo non tornerà più. Plausibilmente, ciò non significherà la fine del rapporto euro-atlantico. Tuttavia, Trump o non Trump, anche se gli Usa non romperanno con l’Europa non le assicureranno più né protezione militare incondizionata né condizioni economiche di favore”. Difficile, purtroppo, non essere d’accordo con queste valutazioni.
La spiegazione del nuovo contesto geopolitico va ricercata nei mutamenti che sono intervenuti tra la grande potenza d’oltre Atlantico ed il Resto del mondo. Washington non ha più le risorse di un tempo per continuare a svolgere un ruolo che era diventato sempre più oneroso. Non ha le risorse umane, a causa del crescente rifiuto da parte del popolo americano di continuare a morire per difendere gli interessi più diversi, nei quattro angoli del Pianeta. Da questo punto di vista il ritiro dall’Afganistan, con la sua relativa drammaticità, è stata l’ultima goccia che ha fatto tracimare un vaso già pieno di dolore e di sconcerto.
Ma non ha più nemmeno le necessarie risorse finanziarie, indispensabili per sostenere una presenza bellica così dilatata dal punto di vista geopolitico. Il relativo impegno economico – finanziario è divenuto talmente costoso, da competere con gli altri obiettivi della politica nazionale: dal taglio delle tasse, al finanziamento di un welfare sempre più impoverito. In passato il signoraggio del dollaro aveva garantito margini maggiori, ma oggi quegli stessi vantaggi, di fronte alla crescita di un debito pubblico, possibile preda della grande speculazione internazionale, si sono fortemente ridotti: visto che il relativo costo di mantenimento – interessi pagati sui titoli emessi – è divenuto debordante.
Il declino, come sempre è avvenuto nella storia, non è stato istantaneo, ma conseguenza di un progressivo slittamento, segnato dalla crescita maggiore dei Paesi concorrenti. I dati in materia non sono univoci nel dettaglio. Per il FMI il sorpasso della Cina, considerata la correzione per il diverso potere d’acquisto, sugli Stati Uniti era già avvenuto nel 2016. Per Stephen Miran, un economista molto vicino a Donald Trump, il peso degli Stati Uniti, negli equilibri mondiali, si era quasi dimezzato: passando dal 40% degli anni ‘60 al 21% del 2012. Meno pessimista Paolo Savona, secondo il quale, lo scorso anno, il peso degli Stati Uniti (Pil non corretto per il diverso potere d’acquisto) era pari al 26%, contro il 17% della Cina.
A chi attribuire l’eventuale responsabilità? Non si dimentichi la lezione del ‘29. Non si trattò soltanto di una crisi senza precedenti, ma di un vero giro di boa, che segnò la progressiva ascesa del nazismo e l’inizio di una tragica storia complessiva. Qualcosa di simile, anche senza giungere ad analoghe conseguenze (almeno così si spera) è avvenuto con la crisi del 2008: causata dagli eccessi della finanza americana. Costretta a rivolgere le principali attenzioni al mercato interno, essendo venuta parzialmente meno la spinta della globalizzazione.
La grande liquidità che, negli anni precedenti, ne aveva sorretto lo sviluppo economico e finanziario fu incanalata verso il mercato interno. Soprattutto in quello immobiliare. L’obiettivo era quello di spingere al massimo il mercato, per far lievitare il prezzo delle abitazioni, facendo salire la rendita fondiaria. Puntando, in tal modo, sull’“effetto ricchezza” (maggior valore del patrimonio posseduto). Per farlo era necessario offrire mutui a basso prezzo anche a favore di coloro che non potevano permetterselo. Per ridurre il rischio sistemico, che tali operazioni comportavano, le banche non fecero altro che cartolarizzare i propri crediti, creando nuovi strumenti finanziari da vendere sul mercato. Al tempo stesso le eventuali insolvenze del debitore erano garantite da un valore dell’immobile, che nel frattempo grazie alle facilità creditizie, era enormemente cresciuto.
Come si vede una sorta di catena di Sant’Antonio o di Ponzi schema, se si preferisce. Sta di fatto che, lo scoppio della relativa bolla non poteva non determinare un cataclisma destinato ad andare oltre ogni immaginazione. E così fu con la Global Financial Crise: destinata ad incidere sull’intera situazione internazionale. Avendo, tuttavia, come epicentro gli stessi Stati Uniti. La relativa gestione comportò un enorme sforzo sia in termini di governance che sul piano finanziario. Si trattava, infatti di salvare soggetti economici coinvolti in operazioni speculative di dimensioni inusitate. Che richiese l’intervento diretto della FED, fino al punto di snaturarne la tradizionale funzione, e dello stesso Governo degli Stati Uniti.
In pochi mesi Ben Bernanke, che ne era il Governatore, sarà costretto ad accrescere il bilancio della banca oltre ogni limite. Acquistando, tra il dicembre 2007 e il settembre 2009, più di 1000 miliardi di dollari in titoli: di cui 430 miliardi in mutui, 370 in attività relative alla Term Auction Facility (prestiti concessi alle banche affinché sostenessero le aziende private) e 140 in carta commerciale. Il Governo centrale degli Stati Uniti, a sua volta, interverrà con una politica di bilancio particolarmente espansiva: una prima volta (sotto l’Amministrazione Bush) con una fiche pari a 787 miliardi di dollari. Ed una seconda volta (Presidente Barack Obama) con un ulteriore intervento di 800 miliardi.
Risorse spese per aiutare, ed in molti casi, salvare le banche dal default e venire incontro agli altri settori in difficoltà, a cominciare da quello automobilistico di Detroit. Interventi destinati ad aumentare di 9 punti percentuali (dal 3% al 12% del PIL) il deficit pubblico del governo degli Stati Uniti. Una misura che voleva essere provvisoria. Nella speranza era che, passata la tempesta, salvato il salvabile, lasciate affondare quelle banche, come la Lehman Brother, ormai troppo compromesse, si sarebbe potuto tornare alla normalità di una sana gestione economica – finanziaria, quale era stata quella degli anni precedenti.
Una grande illusione. Il 2009 chiuse con un deficit di bilancio pari al 13,2 per cento del Pil, secondo i dati del Fondo monetario. Negli anni successivi si cercò di arrestare l’emorragia. Ma cinque anni dopo il deficit era ancora al 3,5%. E subito dopo, nuovamente, il baratro. Un deficit del 14,1%, raggiunto nel 2020: l’anno della pandemia di Covid. E da allora un andamento medio superiore al 6% del Pil destinato a trascinarsi, secondo le previsioni del CBO (il Congressional Budget Office del Parlamento) per i prossimi 15 anni, in assenza di improbabili, basti vedere il Big Beautiful Bill di Trump, misure correttive.
Nel 2001, mentre l’euro faceva la sua apparizione sui mercati europei, il debito pubblico americano era pari al 53,3% del Pil. Ben al di sotto di quel 60% che gli accordi di Maastricht aveva imposto ai Paesi aderenti alla moneta unica. Vincolo che alcuni Paesi, tra cui l’Italia e la Grecia, non avevano mai rispettato. Era il segno tangibile della stabilità finanziaria del Paese a stelle e strisce, dovuto, soprattutto, ad un modello di sviluppo centrato sul libero mercato. Restio alle lusinghe di un welfare alimentato dalle politiche di assistenza. Sennonché in pochi anni, nel 2010, quella percentuale era salita al 95,3%. Quasi raddoppiata. Per poi raggiungere, lo scorso anno, il 122% del Pil. Una sindrome italiana.
Ed ecco allora il perché di quella triste previsione di Angelo Panebianco. Per gli Stati Uniti, come del resto per molti altri Paesi, sarà difficile tornare indietro. Quel deficit previsto stabilmente ad oltre il 6% del Pil si compone soprattutto di due voci di quasi identico importo: le spese militari e gli interessi maturati su un debito che, per oltre il 60% è collocato sui mercati internazionali. Ben poco disponibili a concedere sconti, come è facile vedere dall’andamento del prezzo dell’oro (acquistato vendendo dollari). Il che contribuisce a spiegare l’atteggiamento di Donald Trump. I suoi aspetti caratteriali sono fin troppo evidenti ed altrettanto censurabili. Ma non è a questi che bisogna guardare. Per non illudersi che, terminato il suo mandato, possa ritornare il bel tempo antico.