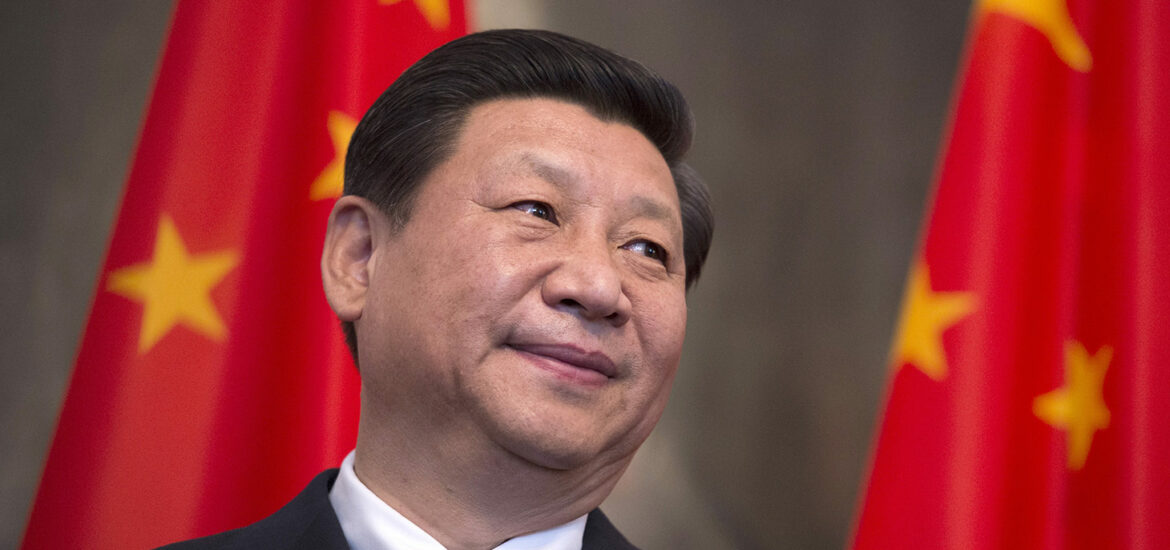Gli animal spirits del capitalismo cinese stanno ricevendo duri colpi dal governo di Pechino di questi tempi. Dopo quarant’anni di esperimento capitalista, che hanno consentito all’ex Celeste Impero di scalare le vette del gotha economico mondiale, il Partito Comunista Cinese sembra essere tentato dal rioccupare il centro della scena economica, a tutto svantaggio delle aziende private e a beneficio dei già floridi colossi di Stato. Nel Paese, inoltre, si moltiplicano le voci che invocano il ritorno ai tradizionali sentieri del socialismo, mentre la preoccupazione degli imprenditori privati per una possibile involuzione di matrice statalista soffre della consueta sordina, frutto del timore di incorrere nell’ira del governo, notoriamente insofferente verso ogni forma di dissenso.
A raccogliere segnali di una torsione in senso contrario alla rotta mercatista, e in direzione di una fiera avanzata del capitalismo di Stato, ci ha pensato ieri un documentato articolo del New York Times. La prima prova fornita dal quotidiano newyorchese riguarda la crescita asimmetrica dei profitti nel settore industriale. Secondo i dati del governo, nei primi sette mesi del 2018 le aziende manifatturiere statali hanno visto crescere i profitti tre volte tanto quanto quelli delle aziende private. Una tendenza che contraddice decenni di sforzo di ridirezionamento delle forze economiche in direzione del settore privato, confermando invece la voracità dello Stato e la sua tendenza ad essere protagonista incontrastato dello sviluppo.
Che la china sia questa lo conferma, anche, la dichiarata intenzione dello Stato di assumere il controllo dei colossi nazionali di internet. Conferendo, come ventilato, ai comitati del Partito Comunista un ruolo chiave nel management dei big della rete, il governo si procurerebbe anche il beneficio collaterale di mantenere uno sguardo occhiuto sulle dinamiche di un settore strategico che è sottoposto, tra le altre cose, alla scure della censura.
Nel nuovo clima che si sta creando, suonano naturali trend che, in altri contesti, sarebbero denunciati come allarmanti. Tra questi, il crescente numero di imprese private che decidono di vendere allo Stato. Solo quest’anno, sono state 46 le aziende che hanno venduto quote delle proprie azioni ad imprese statali; secondo il giornale Shangai Securities, metà di esse ha ceduto il pacchetto di maggioranza. Tra queste c’è la compagnia energetica Changchung Sinoenergy Corporation: i suoi azionisti hanno ceduto le proprie quote ad una azienda gestita dal governo della provincia di Hunan, che conta ora di investirvi 150 milioni di dollari. Sia pur a fronte di numeri per il momento ancora contenuti, si tratta in ogni caso dell’inversione di una tendenza storica che non depone bene per il futuro del capitalismo privato cinese.
A palesare le intenzioni del governo di riprendere saldamente in mano le redini dell’economia ci sono, poi, le nuove e stringenti regolamentazioni varate per il settore immobiliare, l’e-commerce e l’industria dei videogame. Norme che hanno subito affossato di un terzo il valore di mercato di Tencent, colosso cinese dei videogame e una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo. Quanto all’e-commerce, la nuova legislazione obbliga i gestori degli store on line a effettuare una registrazione presso il governo e pagare ingenti tasse. Una manovra destinata ad incidere anzitutto sui profitti di Alibaba Group, la cui controllata Taobao offre ad eserciti di commercianti grandi e piccoli una piattaforma in cui aprire e gestire i propri store on line.
Nuvole nere all’orizzonte per il privato si avvistano anche dalle parti della politica fiscale. Nei piani del governo c’è infatti un aumento della pressione fiscale finalizzato a perseguire ambiziosi programmi pubblici come la copertura sanitaria universale, una maggiore protezione sociale dei lavoratori e la lotta all’inquinamento. Secondo il calcolo di Lu Ting, economista della Nomura Securities di Hong Kong, la sola maggiorazione dei contributi sociali dovuti dalle aziende dreneranno risorse pari al 2,5% dei profitti d’impresa.
Tutti questi segnali si accompagnano ad un dibattito pubblico in cui si moltiplicano pericolosamente le voci a sostegno dell’espansione del controllo pubblico dell’economia. Non si contano più gli studiosi, i funzionari governativi e i blogger che sfornano dichiarazioni in stile maoista. A gennaio, per esempio, Zhou Xincheng, docente di marxismo alla Renmin University di Pechino, ha dichiarato niente meno che la proprietà privata dovrebbe essere eliminata. Il mese scorso, uno sconosciuto blogger ha scritto che bisognerebbe porre fine al settore privato, avendo questo già conseguito la sua missione storica di favorire la crescita economica: il suo post è diventato virale in un batter di ciglia. E il mese scorso un big del Pcc come Qiu Xiaoping, viceministro delle risorse umane e della sicurezza sociale, ha invocato un “management democratico” per le imprese private, eufemismo che evoca lo spettro fosco della statalizzazione.
In una simile atmosfera, appaiono quanto meno coraggiose le esternazioni di una figura non di second’ordine come l’ex ministro Hu Depin. “Il settore privato sta sperimentando in questo momento grosse difficoltà”, ha ammesso Hu, per il quale bisognerebbe “fare del nostro meglio per non replicare la nazionalizzazione delle imprese private degli anni ’50 e il capitalismo di Stato”. Voce fuori dal coro, o resistenza interna al pachiderma statale che si appresta a fagocitare le migliori energie della seconda economia del pianeta?