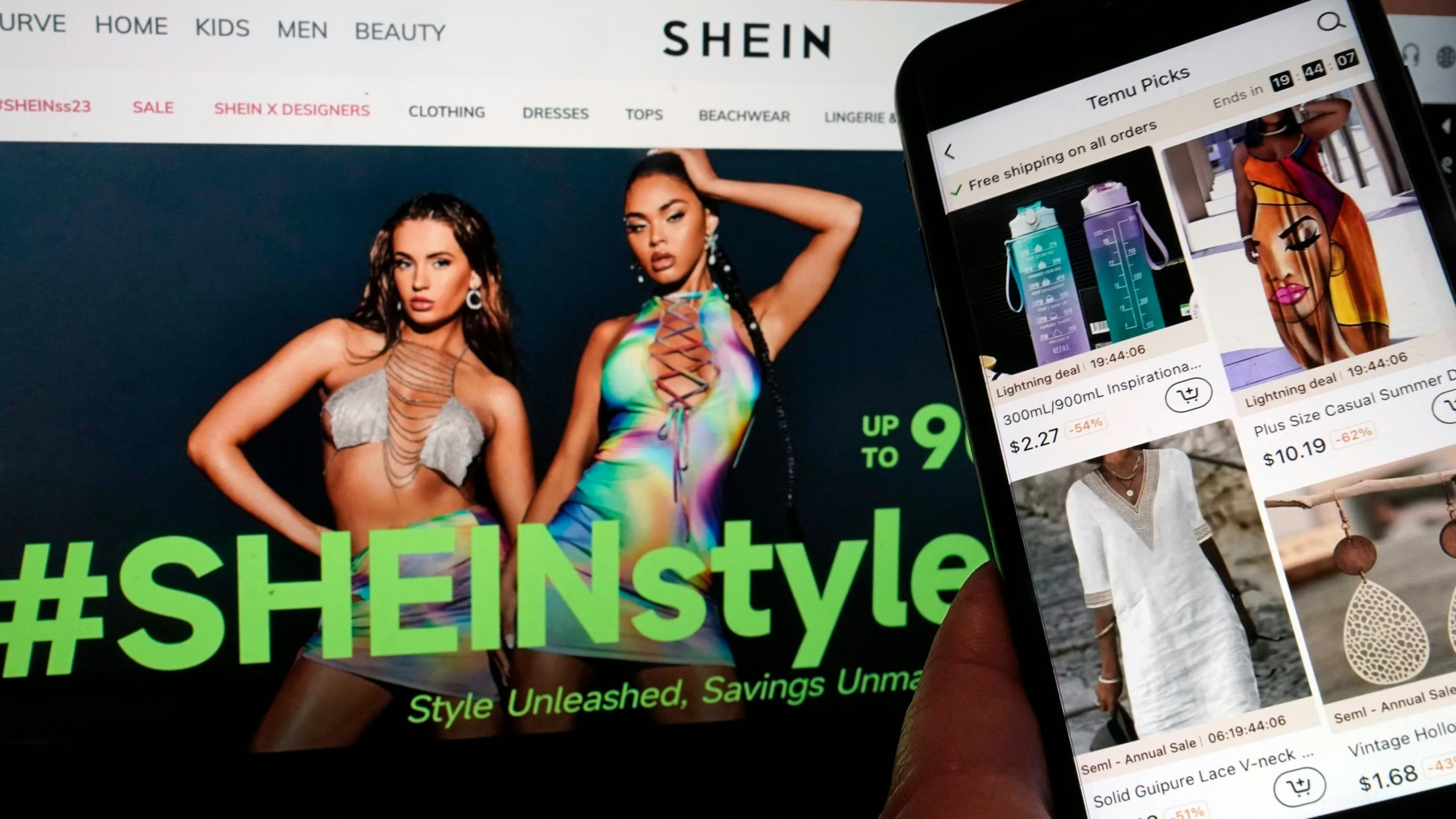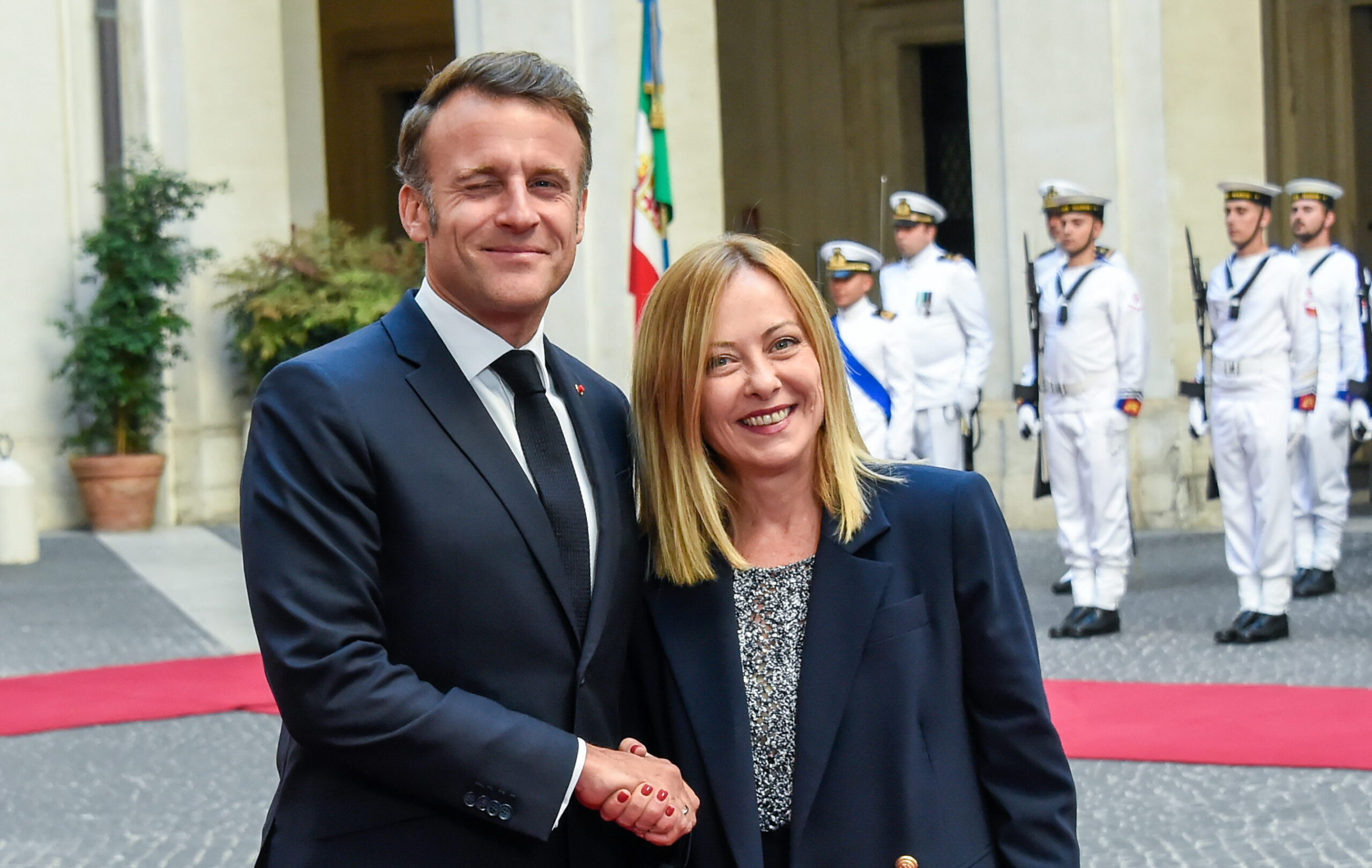Tutto l’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Parlamento, si è fondato su un presupposto: il principio di precauzione. Richiamato in modo esplicito, nei suoi fondamenti non solo etici ma giuridici. Considerato ch’esso fa parte del bagaglio normativo della stessa Unione europea. Vale la pena, allora, esaminare più da vicino quale ne sia l’effettiva portata. E fino a che punto esso possa essere considerato il miglior criterio per là gestioni degli affari correnti, in un momento così difficile per la vita del Paese.
Va ricordato che quel principio è soprattutto una norma in materia di sicurezza ambientale: ove vi siano minacce di danno serio o irreversibile, l’assenza di certezze scientifiche non deve essere usata come ragione per impedire che si adottino misure di prevenzione. Nel dubbio – questa la sintesi del precetto – meglio non fare. In passato le polemiche più violente riguardarono le onde elettromagnetiche. Nessuna evidenza scientifica dimostrava l’esistenza di un possibile danno per coloro che ne erano investiti. Comunque, nel dubbio, meglio non correre rischi. Una sua generale estensione, oltre il limite della ragionevolezza, porta, tuttavia, ad atteggiamenti fobici. Lo si è visto nel caso delle biotecnologie oppure dei vaccini: da molti 5 stelle osteggiati, perché considerati lo sterco delle grandi multinazionali del farmaco.
Il presidente del Consiglio, facendo leva su questo retroterra culturale, ha scandito il suo intervento dicendo: attenzione. Se oggi siamo troppo liberali nelle misure da adottare, rischiamo di far crescere i contagi, per essere, subito dopo, costretti ad un lockdown ancora peggiore. Quindi politica dei piccoli passi e circospezione. In altre parole: agiamo poco, nonostante l’assenza di certezze scientifiche. Perché il danno potrebbe essere maggiore.
Ciò che sfugge ad un siffatto ragionamento è l’idea che una posizione minimalista non abbia un costo. Ipotesi evidentemente erronea. Ritardare l’avvio di determinate attività economiche implica un danno immediato. Costringe lo Stato ad intervenire con propri (spesso tardivi) finanziamenti. Nelle migliori delle ipotesi, questa strategia paga il prezzo se non del fallimento della sottostante attività economica, almeno della crescita esponenziale di debiti pubblici che, prima o poi, andranno ripagati. Circostanza che spiega la maggiore determinazione degli altri Paesi a fare presto: anche correndo qualche rischio in più.
Ecco allora che l’equazione corretta non è più il credo ambientalista. Ma diventa: conviene avere un costo certo ed immediato, contro uno ipotetico, che forse scatterà domani. Quando e se R0, ovvero il “numero di riproduzione di base”, tenderà verso valori maggiori di 1. Ipotesi comunque da contenere mantenendo in vita i necessari accorgimenti. Questo è il dilemma vero e non le tesi sull’ineluttabilità di un contagio di ritorno scandito da chissà quasi valori.
Naturalmente la scelta deve essere ponderata. Va fatta, cioè, osservando l’evolversi dell’epidemia, (considerando, tra l’altro ch’essa non è uniforme su tutto il territorio) ed il suo fall-out psicologico, a livello di massa. Non si può dire che oltre 50 giorni di lockdown non abbiano lasciato il segno. Nonostante il grande senso di responsabilità dimostrato da tutti gli italiani. Che poggiava, tuttavia, su basi oggettive. Da un lato la maggiore disponibilità di risorse personali: ancora non intaccate dai giorni dell’inedia. Dall’altro la forte progressione del contagio. Dal 24 febbraio al 9 marzo (data del lockdown) la sua progressione media giornaliera era stata pari al 28,5 per cento.
Queste condizioni di base sono, oggi, radicalmente cambiate. Quel po’ di risparmio familiare, specie per determinate categorie di cittadini, si è rapidamente volatizzato. La dinamica del contagio si è molto raffreddata. Proprio ieri, i positivi per la prima volta sono diminuiti del 3 per cento. Applicando una regola di borsa, si potrebbe dire che è stata “bucata” una soglia di resistenza. E quando questo si verifica nel trend che descrive l’andamento di un titolo, si è di fronte ad un preannuncio di ulteriori forti cedimenti. Naturalmente una rondine non fa primavera. Tuttavia la flessione dura da una decina di giorni, seppure intervallata da qualche piccolo rimbalzo.
Ciò deve comportare un “liberi tutti”? Sarebbe la negazione di una scelta oculata. Ci vuole invece senso della misura. Soprattutto del limite. Si deve passare dalla fase emergenziale – se la casa brucia non temo che l’acqua dei pompieri possa rovinare le tappezzerie – a dei protocolli calibrati sulle diverse situazioni. Stabilendo semmai parametri fisici per la riapertura dei singoli esercizi, in funzione della specificità della prestazione. Oppure predisponendo l’obbligo di ulteriori presidi.
C’è il rischio che tutto ciò venga disatteso? Il principio generale è che le norme non si costruiscono sulla patologia. Nel caso specifico, poi, sarà l’utente stesso a controllare, in difesa del proprio interesse, che certe regole, se non cervellotiche, siano rispettate. Alcune sfide, come nel caso del trasporto pubblico di massa, non saranno facili da affrontare. Ma il trascorrere del tempo, nell’ipotetico rinvio, cambia poco. Quel bottle neck, quella strozzatura, ce la ritroveremo anche alla fine dell’anno. Se nel frattempo, in qualche modo, non si provvede. Come è accaduto finora.
Comunque la partecipazione attiva del cittadino rimane determinante. Ma proprio per questo non deve essere stressato da inutili corvée. Rischiano solo di alimentare reazioni controproducenti, che lo portano a buttare il bambino con l’acqua sporca.