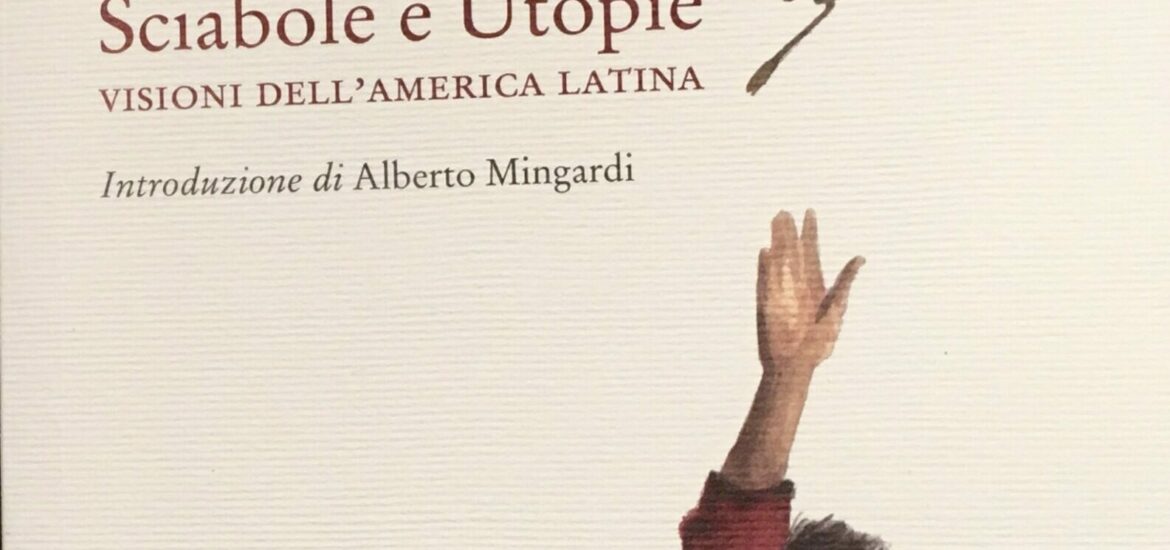“Un uomo forte come Richelieu/ci porterebbe tutti quanti in porto”, recitava la filastrocca cantata nelle bettole parigine alla vigilia del colpo di stato del brumaio (dicembre) 1799. A quel primo modello di stampo napoleonico si sarebbero poi ispirati molti dittatori dei vari totalitarismi fioriti nel Novecento, in Europa come nel continente latinoamericano. Dopo la sua rottura col castrismo all’inizio degli anni Settanta, Mario Vargas Llosa non ha cessato di far sentire la sua voce contro le autocrazie di ogni tipo, al contrario di quei maître à penser che hanno invece scelto — per codardia o convenienza — il silenzio, ovvero la massima espressione di subalternità verso chi detiene il potere.
Per questo, in tempi in cui buona parte dell’intellighenzia di sinistra ha ceduto alle sirene del populismo, tace o si rifugia in polemiche astruse contro un mitologico neoliberismo, leggere l’autore de Il richiamo della tribù (2018), in cui racconta come ha voltato le spalle alla sua gioventù tinta di rosso, è come aprire una finestra in una stanza piena di fumo. Da ultimo, lo testimonia un volume in cui sono raccolti i suoi saggi più politici (Sciabole e Utopie. Visioni dell’America Latina, Introduzione di Alberto Mingardi, Liberilibri).
Il romanziere peruviano, infatti, ha fatto della rivolta perenne contro ogni forma di dispotismo la cifra del suo impegno e della sua responsabilità come scrittore. E il ruolo dello scrittore nella società, sostiene, non è quello di dare risposte, ma quello di formulare domande, di suscitare riflessioni. Non fortuitamente i romanzi che pretendono di dare risposte spesso sono brutti, “perché organizzati così razionalmente da non lasciare spazio alla libertà, e senza libertà la vita non può germogliare in un’opera di finzione”.
Del resto, pur non narrando la storia ufficiale, i romanzi, come diceva Balzac e come appare nell’epigrafe alle Conversazioni nella cattedrale (1969), sono “la storia privata delle nazioni”. Sono la storia di ciò che non è mai accaduto e che non c’è nei documenti, ma che esiste nella fantasia, nei sogni e nelle ossessioni di un’epoca. Sono la storia non raccontata, l’intimità senza tracce alla quale si può pervenire solo attraverso l’immaginazione e l’invenzione, vale a dire attraverso quella finzione letteraria che ci avvicina alla verità attraverso la menzogna.
Celebrando la figura del poeta messicano Octavio Paz, Vargas Llosa scrive: “Trascorse splendidamente i suoi ottantaquattro lunghi anni, immerso nel vortice del suo tempo per una curiosità giovanile che lo accompagnò sino alla fine. Partecipò a tutti i grandi dibattiti storici e culturali, prendendo sempre una posizione, e spiegando le proprie preferenze in saggi spesso illuminanti per l’eccellenza della sua prosa, la lucidità di giudizio e la vastità delle sue conoscenze. Non fu mai un dilettante né un mero testimone, sempre un attore appassionato da tutto ciò che accadeva attorno a lui, e una rara avis fra la gente del suo stesso mestiere, che non temeva di andare controcorrente né di affrontare l’impopolarità” (Linguaggio della passione, 1998). In realtà, potrebbe essere benissimo il ritratto dell’ottantaquattrenne Vargas Llosa, la fotografia delle sue battaglie politiche e delle sue sfide letterarie.
Come sottolinea Alberto Mingardi nella sua magistrale monografia, l’indagine sulla natura violenta del potere è stato l’assillo di Vargas Llosa. La violenza riparatrice dei torti, la violenza ostetrica della giustizia sociale per lui non è che il velo di Maya di abusi e oppressioni ancora più brutali. Liberatosi dal marxismo nella sua variante guevarista, dopo un periodo di letture intense, da Revel a Berlin, da Popper a Hayek sino a Adam Smith, approda così a un liberalismo che “non è un’ideologia, vale a dire una religione laica e dogmatica, bensì una dottrina aperta che evolve e si spiega alla realtà”.
Nelle Confessioni di un liberale (2005), una sorta di manifesto del suo pensiero politico, riafferma con decisione la sua fiducia nelle virtù del mercato libero, il miglior meccanismo esistente per produrre ricchezza; e, se ben integrato con le istituzioni democratiche, motore dei vertiginosi cambiamenti della modernità. Tuttavia, avverte, è anche un meccanismo implacabile che, senza quella dimensione spirituale e intellettuale che la cultura rappresenta, può ridurre la vita a una lotta feroce e egoistica nella quale soltanto i più forti sopravviverebbero. In altre parole, la libertà politica e la libertà economica hanno bisogno di una cultura, perché senza non esistono. L’ideale di Ludwig von Mises, insomma, ossia una cultura planetaria segnata dal rispetto della legge e dei diritti umani: questo è il liberalismo cosmopolita di Vargas Llosa.
(Pubblicato su Il Foglio, 1 novembre 2020)