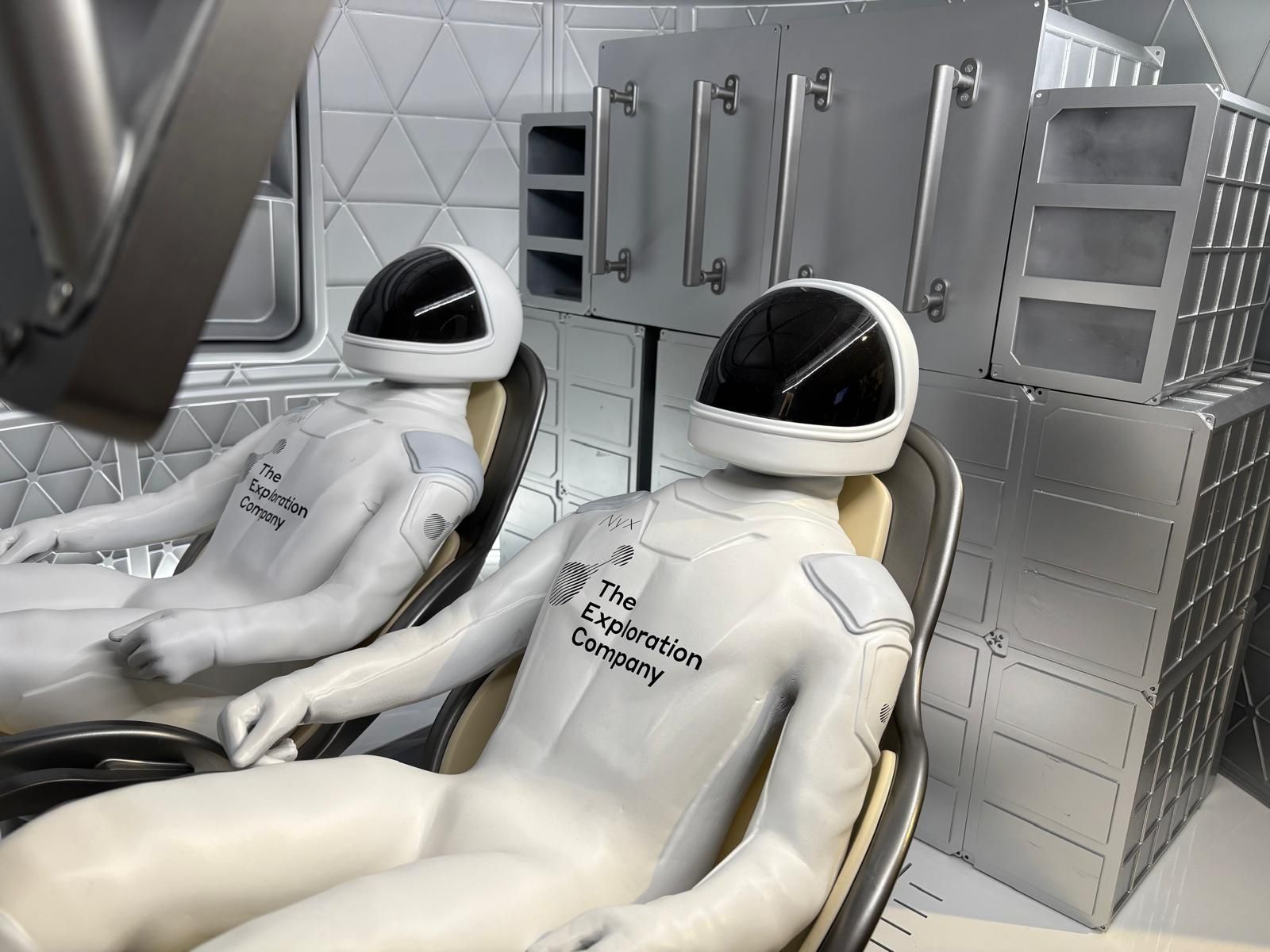Il conflitto ultradecennale tra Stato di Israele e arabi della Palestina è diventato -e non solo in Italia- una specie di porto delle nebbie, in cui i figli delle vittime della Shoah sono ritenuti responsabili del massacro di un altro popolo. La semplice comparazione è ignobile, ma la percezione è diffusa. Così almeno dal 1982 -anno dell’invasione del Libano- la memoria dello sterminio si è scontrata con difficoltà sempre più grandi. Anche perché, nell’antropologia del sacrificio, la vittima deve sempre apparire innocente. Lo Stato israeliano non è innocente, l’ebreo di Israele non è innocente, ma perché si è difeso e ha combattuto per la sua sopravvivenza. E fin qui, per fortuna, con successo. Ma oggi il suo diritto a esistere viene nuovamente messo in discussione: dai tagliagole di Hamas e dai suoi burattinai, i quali forse sperano che Gaza venga rasa al suolo per proclamare la “guerra santa” contro gli infedeli. Chi vivrà vedrà. Beninteso, chi non ha perso il senno sa che da oltre mezzo secolo la questione israelo-palestinese provoca non una critica -lecita- delle politiche dei suoi governi, bensì la sua delegittimazione come Stato.
Di più: l’identificazione di sempre più ampi settori della diaspora con Israele ha innescato un nuovo antiebraismo, non riconducibile né alla tradizione antigiudaica cristiana né all’antisemitismo razziale, ormai ridotto a un culto esoterico. Gli ebrei della diaspora vengono pertanto considerati gli emissari, i complici, i rappresentanti di un avamposto militare dell’impero americano, come recita la propaganda islamista e quella a ovest di Allah. Le conseguenze sono state disastrose: sul terreno della memoria, le sofferenze dei palestinesi sono state equiparate al genocidio nazista, fino a renderlo equivalente con la repressione israeliana nella Terra di Abramo. Tuttavia, le aberrazioni e distorsioni della realtà che spadroneggiano nei social, nei talk show televisivi e nei cortei studenteschi non possono essere contrastate facilmente. Infatti, spesso non basta l’esibizione dei fatti e delle prove. Quelle aberrazioni e distorsioni sono effetti di un analfabetismo politico e culturale che riduce la memoria della Shoah a un’invenzione e a un indebito ricatto morale dei discendenti di sei milioni di morti.
Anche per questo c’è bisogno di libri come quello di Alessandra Tarquini, che ricostruiscono “sine ira ac studio” la storia della “questione ebraica” (“La sinistra italiana e gli ebrei. Socialismo, sionismo e antisemitismo 1892-1992”, il Mulino, 2019). Come scrive l’allieva di Renzo De Felice nell’Introduzione citando un pensiero del filosofo tedesco Karl Löwith, pur fra esperienze politiche molto diverse, tutti i socialisti hanno immaginato di liberare il genere umano dalla sofferenza e dalla schiavitù; e, come eredi della cultura ebraico-cristiana e dell’illuminismo, hanno prodotto una visione del mondo universalistica e finalistica per cui l’emancipazione degli esseri umani è il significato e lo scopo ultimo della storia e dell’azione politica.
Partendo da questa riflessione, è possibile interrogarsi sul rapporto intercorso fra la sinistra di tradizione marxista e la minoranza religiosa più antica del mondo, chiedendosi chi siano stati e chi siano gli ebrei per i socialisti: sono oppressi, e quindi insieme a tutti gli sfruttati del mondo partecipano alla lotta per l’avvento di una nuova civiltà, oppure ostacolano la realizzazione del socialismo perché rivendicano la loro identità in nome di una religione? Si tratta di una questione a cui i più importanti teorici del socialismo, a cominciare da Karl Marx, hanno dedicato la loro attenzione. Furono loro, all’inizio del XIX secolo, i primi a chiedersi se gli ebrei fossero un popolo, una classe o una nazione e dove si collocassero rispetto al progetto universale di liberazione dell’umanità promosso dal movimento operaio. E loro a parlare per primi dell’esistenza una “questione ebraica”.
Di seguito propongo al lettore alcuni brani tratti dal secondo capitolo del saggio di Tarquini (“L’inadeguatezza della sinistra”).
Mi.Ma
[…] Consultando i periodici della sinistra, fra il 1943 e il 1946, l’aspetto che colpisce non è l’assenza di notizie sui Lager, ma la mancata riflessione sull’antisemitismo. Nel maggio del 1945 l’Unità raccontò in prima pagina cosa era accaduto nel campo di Auschwitz, dove la commissione sovietica aveva accertato che “Per fame, avvelenamento, fucilazione e mostruose torture, i tedeschi sterminarono nel campo di Oswecin più di quattro milioni di cittadini dell’Urss, della Polonia, della Francia, del Belgio, dell’Olanda, della Cecoslovacchia, della Romania, dell’Ungheria, dell’Italia e di altri paesi […] Professori e medici tedeschi eseguirono nel campo degli ‘esperimenti’ sul corpo vivo di uomini, donne e bambini. […] Vi erano cinque forni crematori, ciascuno con tredici stufe […]nelle quali si potevano cremare dai tre ai sei cadaveri. Nel lungo articolo, basato su un rapporto pubblicato dalla Pravda e dedicato a quello che sarebbe diventato uno dei luoghi simbolo della Shoah, non vi fu una parola sul fatto che le vittime erano ebrei. […] Di fatto l’esperienza dei Lager venne descritta come un aspetto della politica hitleriana, frutto della lotta fra i fascismi e i loro nemici, non legata all’antisemitismo.
Come i comunisti italiani, anche i socialisti descrissero la realtà dei campi di concentramento e, anzi, inviarono propri corrispondenti in Austria e in Polonia e si mostrarono più attenti all’antisemitismo. Da Vienna, nei primi del 1946, Riccardo Luzzatto constatò il vuoto lasciato dalla comunità ebraica, che per secoli aveva animato la vita artistica, scientifica, professionale della città austriaca. Qualche giorno dopo il quotidiano socialista raccontò che ad Auschwitz i neonati ebrei venivano annegati in un secchio di acqua davanti alle loro madri[…].
Dunque, […] non è possibile parlare di un vero e proprio silenzio sulla Shoah. Come si accennava, non è l’assenza di notizie il dato rilevante ma il tipo di analisi proposta dalla sinistra italiana. Da questo punto di vista gli scritti degli intellettuali e degli artisti confermano quanto appare sulla stampa di partito. Nel 1946 Natalia Ginzburg pubblicò sul quotidiano del Pci, “Il figlio dell’uomo”, un articolo in cui descriveva l’impossibilità di tornare alla normalità, di riaversi da una minaccia incombente, di emanciparsi dalla paura della violenza. Malgrado la persecuzione subita in quanto ebrea e antifascista, e la vicenda di suo marito Leone torturato a morte in carcere a Roma nel 1944, la Ginzburg eliminò qualsiasi riferimento all’antisemitismo. Inaugurando un filone che avrebbe avuto grande fortuna, l’autrice non menzionò gli ebrei e descrisse la più grande carneficina della storia moderna come un fatto che riguardava l’umanità intera. Allo stesso modo, Alberto Moravia, nel 1946 ne “L’uomo come fine” presentò i campi di concentramento come il simbolo di un’avvenuta disumanizzazione, l’illustrazione di una “perversa o assurda forma di modernità: un fine perfettamente razionale e inumano, perseguito attraverso il mezzo di milioni di uomini, con violenza estrema e ragione pura unite a produrre immense sofferenze”.
Come ha sottolineato Robert Gordon, si trattò di una tendenza presente anche nelle arti figurative, ben rappresentate dal comunista Renato Guttuso che intitolò i suoi disegni sull’eccidio delle fosse ardeatine “Gott mit uns, Dio è con noi”. Ed in effetti, la figura del Cristo sofferente mostrava l’idea che la Shoah riguardava tutti perché era il simbolo del male, della morte di Dio, della degenerazione del genere umano. Come mai i militanti della sinistra non si chiesero perché proprio gli ebrei erano stati oggetti di sterminio? Oltre alle ragioni che abbiamo indicato nelle pagine precedenti, relative all’interpretazione generale del totalitarismo e dell’antisemitismo, considerati come una forma di barbarie e di regressione, non meritevole di analisi e di riflessione, vi sono altre due motivazioni.
La prima riguarda gli ebrei italiani e la memoria della Shoah. Negli anni del dopoguerra, accanto ai testi di letterati come Curzio Malaparte e Giacomo Debenedetti, autori rispettivamente di “Kaputt” e “16 ottobre 1943”, che passarono decisamente inosservati, vennero pubblicati una cinquantina di pamphlet a firma di ebrei, nella forma di resoconti in prima persona. I loro autori descrissero la propria deportazione come un momento della Resistenza, presentarono se stessi come antifascisti, tralasciando la specificità della persecuzione antiebraica e inserendola in un più ampio discorso sulla violenza dei regimi nazifascisti. Dunque, gli stessi ebrei scelsero di contribuire alla costruzione del mito nazionale della Repubblica, nata dalla lotta contro il fascismo, con la celebrazione del sacrificio di molti di loro nella battaglia antifascista e con la ricostruzione di una Resistenza movimento unitario e di massa, evitando di ricordare l’adesione della maggioranza di loro al fascismo. […]
La seconda ragione è di natura politica e può essere sintetizzata notando l’incompatibilità della riflessione sull’antisemitismo con la proposta dei principali protagonisti dell’antifascismo. Nei primi anni del dopoguerra, ampi settori della cultura e della politica italiana di sinistra non mostrarono interesse per i problemi posti dalla condizione degli ebrei. In molti minimizzarono la rilevanza del razzismo contribuendo a costruire il mito del buon italiano, in continuità con l’analisi che avevano proposto negli anni Trenta. Impegnati nella diffusione del mito nazionale, rivendicarono il ruolo che avevano svolto nella lotta antifascista, identificando la costruzione della democrazia con l’antifascismo e presentando se stessi come gli unici capaci di assicurare le istituzioni democratiche in Italia e di riportare il paese sulla via della modernità interrotta dal fascismo. […]
Si chiudeva così una possibilità: di comprendere fenomeni come il fascismo e l’antisemitismo che modificarono il corso del XX secolo non perché barbari, disumani e regressivi, ma perché moderni e capaci di trascinare milioni di persone. In quegli anni, e per almeno un decennio, la sinistra guardò il genocidio degli ebrei senza vederlo.