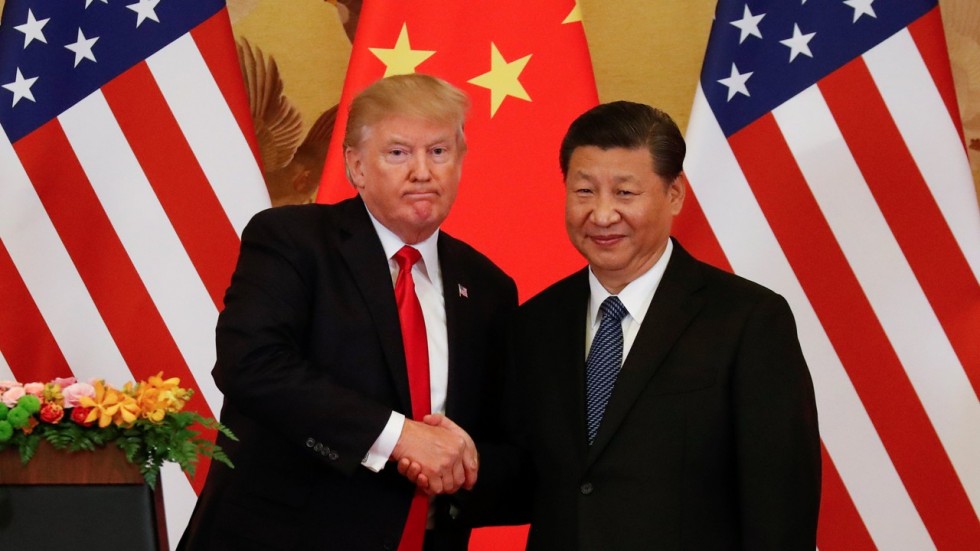Ci sarebbe, secondo le fonti de Il Foglio e del Corriere della Sera, anche la firma dell’Italia in calce alla lettera che 22 ambasciatori hanno trasmesso la settimana scorsa al presidente del Consiglio Onu per i Diritti Umani Coly Seck e all’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, per condannare la Cina per quelli che sono universalmente noti come “campi di concentramento” per musulmani costruiti nella provincia occidentale a maggioranza islamica dello Xinjiang.
Un’iniziativa diplomatica che la Reuters ha definito “senza precedenti” ma che Pechino non ha incassato inerte. C’è infatti la più che probabile impronta cinese nella controlettera siglata e inviata il giorno dopo da 37 ambasciatori di Paesi dell’Asia, Medio Oriente, Africa e America Latina nella quale quei campi sono definiti, sulla scia di quanto fa la Cina, “vocational training centers”: ossia, innocui centri di formazione professionale dove ai musulmani sarebbe offerto, come alternativa all’ideologia islamica radicale, il know how per svolgere un lavoro onesto.
Pur non avendo fatto breccia – ma guarda un po’ – nella grande stampa italiana, la singolare guerra delle lettere andata in scena la settimana scorsa al Palazzo di Vetro ha attirato l’attenzione di vari media internazionali, lesti a battere la notizia della missiva dei 22 come a rendere nota la replica a tamburo battente dei 37:
More than 20 ambassadors condemn China's treatment of Uighurs in Xinjiang https://t.co/zdHDaGMjUb
— The Guardian (@guardian) July 11, 2019
UN ambassadors urge #China to end detention of Uygurs in #Xinjiang camps https://t.co/v571oUc1X7
— SCMP News (@SCMPNews) July 11, 2019
The United Nations ambassadors of 37 countries, mostly developing countries, released a letter on Friday defending China's policy in #Xinjiang. It is in striking contrast with the text signed by envoys from some developed countries denouncing China's actions in the border region.
— China Daily (@ChinaDaily) July 14, 2019
Nella prima lettera, gli ambasciatori di Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Giappone, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera – e, se Foglio e Corriere hanno ragione, anche Italia – esprimono preoccupazione per “i credibili rapporti” che denunciano le “detenzioni arbitrarie” degli “Uiguri e di altre minoranze nello Xinjiang” nonché “la diffusa sorveglianze e le restrizioni” che colpiscono queste popolazioni.
Dinanzi a simili nequizie, i 22 si sono sentiti obbligati ad invitare la Cina ad “astenersi dalle detenzioni arbitrarie e dalle restrizioni della libertà di movimento degli Uiguri e degli altri musulmani e delle comunità di minoranza nello Xinjiang” e a “rispettare nello Xinjiang e in tutto il Paese le proprie leggi nazionali e gli obblighi internazionali e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, inclusa la libertà di professare la propria religione o credo”.
La lettera – che, come espressamente richiesto nel testo, dovrebbe essere pubblicata tra i documenti della 41esima sessione del Consiglio dei Diritti umani chiusasi lo scorso venerdì – chiede inoltre a Pechino di acconsentire all’ingresso nello Xinjiang di Bachelet e di osservatori internazionali indipendenti affinché compiano le necessarie indagini.
L’iniziativa ha ovviamente del clamoroso, non ultimo per il numero delle adesioni che – come ha notato Human Rights Watch – superano abbondantemente le dodici registrate l’ultima volta in cui, correva l’anno 2016, la Cina finì nel banco degli imputati presso il Consiglio dei Diritti Umani Onu.
L’arma scelta dai diplomatici – la lettera – appare però spuntata, visto che – come ha osservato Reuters – “non è stata presentata alcuna dichiarazione formale al Consiglio né è stata proposta una risoluzione da mettere ai voti” come invece avrebbero preferito gli attivisti per i diritti umani. Difficile d’altronde, rileva Deutsche Welle, superare il fuoco di sbarramento dei vari Paesi che avrebbero votato contro per risparmiare alla Cina l’umiliazione di una censura formale. E quand’anche un voto fosse stato indetto, il “timore (…) di una reazione politica ed economica da parte della Cina”, scrive ancora Reuters, avrebbe fatto pensare due volte chi avesse meditato di sottoscrivere un’eventuale mozione di condanna.
Eppure, nonostante si siano mossi con i piedi di piombo, gli estensori della lettera non sono riusciti ad evitare che la Cina facesse la sua contromossa. Che arriva, come dicevamo, il giorno dopo sotto la forma di un documento siglato dagli inviati di Algeria, Angola, Arabia Saudita, Bahrein, Bielorussia, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Isole Comore, Repubblica del Congo, Corea del Nord, Cuba, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Filippine, Gabon, Kuwait, Laos, Myanmar, Nigeria, Oman, Pakistan, Russia, Siria, Somalia, Sud Sudan, Tagikistan, Togo, Turkmenistan, Venezuela, Zimbabwe.
Ebbene, per i 37 ambasciatori la Cina, “davanti alla grave sfida del terrorismo e dell’estremismo, ha intrapreso una serie di misure di contro-terrorismo e deradicalizzazione nello Xinjang, incluso mettere in piedi” quelli che, come abbiamo già detto, sono chiamati “vocational training centers”. Misure necessarie, si sostiene, ad affrontare una situazione in cui “terrorismo, separatismo ed estremismo religioso hanno causato enormi danni ai popoli di tutti i gruppi etnici dello Xinjiang”.
Negano, i diplomatici, qualsiasi emergenza nella provincia occidentale cinese, dove sarebbero salvaguardati i diritti umani fondamentali di tutti i gruppi etnici e – giurano – la gente vive in stato di “happiness”. A conferma della bontà delle politiche cinesi, nella regione è inoltre tornata anche la sicurezza, come dimostra l’assenza di episodi terroristici negli ultimi tre anni.
Non paghi, gli ambasciatori si spingono a lodare Pechino per i “notevoli risultati nel campo dei diritti umani”, apprezzandone in particolare le azioni di “protezione e promozione dei diritti umani attraverso lo sviluppo”.
Nella missiva c’è spazio anche – e da Paesi come Cuba, Arabia Saudita, Corea del Nord e Venezuela c’era da attenderselo – per un attacco alle nazioni che indulgono nella pratica di “nominare, additare ed esercitare pressione sugli altri Paesi” per presunte o effettive violazioni dei diritti umani.
Dalla tragedia alla farsa, come sappiamo, il passo è spesso breve. E ad essere convinto che la lettera dei 37 contenga insieme i registri del tragico e del farsesco è una persona che, con le organizzazioni di cui fa parte, Nessuno Tocchi Caino e Global Committee for the Rule of Law, monitora attentamente la questione dello Xinjiang: l’ex ministro degli Esteri del governo Monti, Giulio Terzi.
Esprime anzitutto soddisfazione, Terzi, per il risultato incassato, con la lettera dei 22, dalla causa globale per i diritti umani. È la prima volta infatti che l’inquietante caso dello Xinjiang guadagna una simile ribalta. Un’attenzione più che meritata, visti i presupposti che Terzi non manca di sottolineare.
“Non si hanno cifre esatte” sui campi dello Xinjiang, osserva l’ex ministro, “ma le organizzazioni internazionali e dei diritti umani che se ne sono occupate – dal Segretariato delle Nazioni Unite, all’Alto Commissario Onu per i diritti umani, a Amnesty International, Human Rights Watch, fino alle organizzazioni di cui faccio parte anch’io – parlano di un numero compreso tra uno e tre milioni di cittadini dello Xinjang reclusi in campi di concentramento cosiddetti di rieducazione”.
Esterna tutta la propria indignazione, Terzi, per una situazione che sta venendo piano piano a galla “grazie anche a reportage investigativi come quello agghiacciante della CNN di qualche giorno fa sulle prigioni per bambini. Ci sono infatti decine di migliaia di minori uiguri che sono stati strappati alle famiglie che vengono internate dietro muraglie altissime e senza diritto di uscire. È tutto documentato, quindi non ci sono storie o balle da raccontare”.
Non ha paura, l’ex ministro, di chiamarli con il proprio nome – “lager” – quei campi che la Cina e i Paesi che ne appoggiano la linea considerano alla stregua di agenzie per l’impiego. “Qual è infatti la definizione di lager?”, si domanda Terzi. “Lager è un luogo nel quale si entra in modo arbitrario, senza alcun processo e senza alcuna possibilità di difesa, e dal quale non si esce. E vi si entra solo perché si appartiene ad una etnia, minoranza, fede politica o religiosa. Che è esattamente quello che succede agli uiguri e ai membri delle altre minoranze musulmane dello Xinjiang”.
Non è comunque sorpreso il nostro interlocutore della successiva iniziativa dei 37 ambasciatori, che a suo giudizio “o sono stati minacciati oppure sono stati sollecitati, con la prospettiva di evidenti vantaggi personali per sé per i loro Paesi, ad aderire a questa totale falsità che pretende di convincerci della inesistenza di questi campi di concentramento e di queste atrocità”. Siamo di fronte, secondo l’ambasciatore, a “quelle tecniche che conosciamo dalla Russia sovietica degli anni ’50, quelle dell’arcipelago Gulag per intenderci, o dalla Rivoluzione culturale o anche dai fatti di piazza Tienanmen, che non a caso secondo i cinesi non sono mai accaduti”.
Terzi si dice in ogni caso molto preoccupato per quanto verificatosi in seno al Consiglio dei Diritti Umani. Che è uno di quegli organismi internazionali su cui la Cina nutre “obiettivi di dominio” e dove, grazie alle tecniche di cui sopra, “non ha difficoltà a bloccare quel che vuole bloccare”. Nel Consiglio, denuncia Terzi, Pechino “è riuscita a creare una massa di stati che controlla e domina con forme di ricatto o sotto la minaccia di ritorsioni economiche”.
L’orizzonte dell’Onu scrutato da Terzi è dunque nero. “La Cina – spiega – sta creando una nuova realtà all’Onu. Una realtà che non è più basata sulle convenzioni internazionali che ha firmato e sottoscritto o sui principi e le norme universali. Una realtà che piega ai suoi fini specifici utilizzando qualsiasi terreno di condizionamento nei confronti dei paesi che esprimono posizioni diverse dalle sue. Io temo”, è la sua conclusione, “che quello che è successo sullo Xinjiang sia un certificato di morte”.