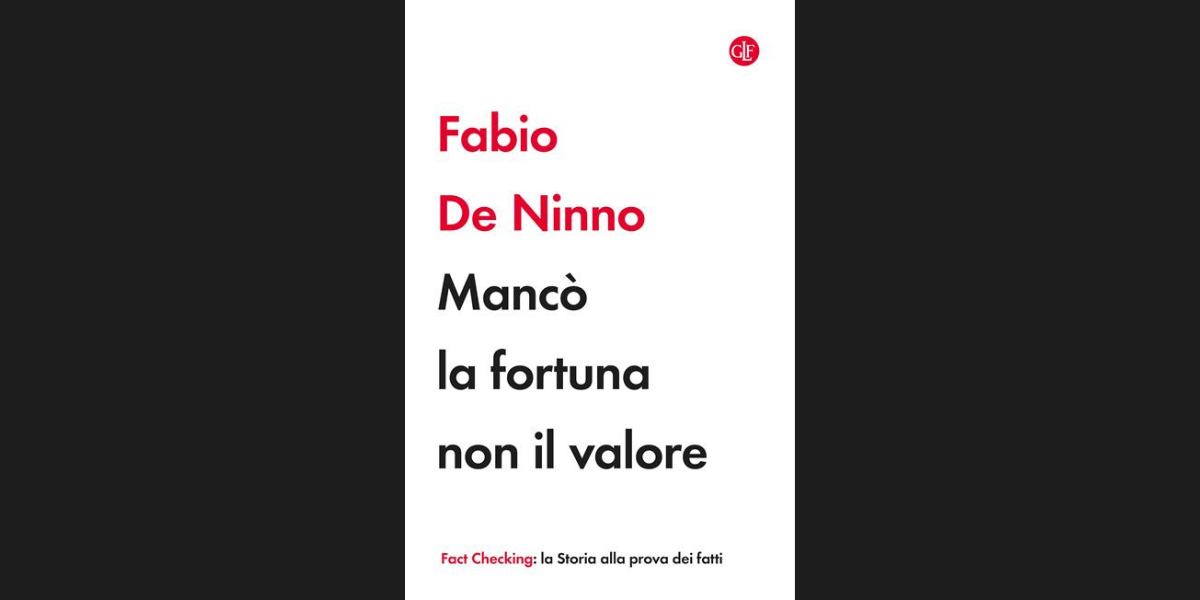“La falsità spicca il volo e la verità la segue zoppicando”, recita un aforisma dello scrittore irlandese Jonathan Swift (1667-1745). Tre secoli fa questa affermazione era un’iperbole, oggi invece descrive bene i social media. Tutte le piattaforme che amplificano contenuti provocatori rischiano di fare da cassa di risonanza alle notizie false. E, come è noto, una storia falsa ha molte più probabilità di diventare virale rispetto a una vera. Ciò vale in tutti i campi -economia, terrorismo e guerra, scienza e tecnologia, intrattenimento e politica.
In Rete ci sono quasi due miliardi di siti web e più della metà della popolazione mondiale naviga in Internet: ogni secondo nel mondo vengono inviati oltre due milioni e mezzo di messaggi di posta elettronica e vengono effettuate 70mila ricerche su Google. Le fake news sono parte integrante della Rete, invadono le pagine Internet, si diffondono come virus nel web, tengono testa ai grandi quotidiani e riescono a creare un impatto mediatico a livello globale. Le fake news hanno la prerogativa di distorcere la realtà dei fatti e occultare la verità, ingannando il lettore. Complice la libertà che contraddistingue la natura del web, la disinformazione trova un terreno fertile nella Rete, dove riesce a diffondersi a macchia d’olio e entrare nel senso comune dell’utente lettore. Il web rappresenta un vero e proprio oceano di contenuti in cui i confini tra notizia vera, distorta o completamente inventata diventano labili, a volte quasi inesistenti.
Dunque, ha ragione il partito dell’Internet bugiardo? Vexata quaestio. Beninteso, la lotta politica e, adesso, la lotta contro la scienza condotta a suon di fandonie sul palcoscenico nazionale e internazionale sono avvantaggiate da tre fattori: la possibilità dell’anonimato; la possibilità di raggiungere rapidamente un vastissimo numero di persone: il fenomeno delle “cascate” informative (la bufala che diventa virale). Siamo quindi ben lontani dalla “cyberdemocracy” immaginata da Nicholas Negroponte e Gianroberto Casaleggio. Come si può sconfiggere, allora, la facile menzogna dei professionisti del clic? Chi è favorevole a provvedimenti restrittivi della libertà di comunicazione, con il nobile scopo di arginare il falso, dovrebbe sapere che così si rischia di mettere a tacere anche il vero. È il meccanismo che Cass Sunstein ha definito “chilling effect”, effetto gelante.
Secondo la filosofa Franca D’Agostini (Menzogna, Bollati Boringhieri, 2012), si può invece adottare il vecchio principio del “lasciar crescere la gramigna” perché con essa cresca anche il grano. La verità infatti non deve temere nulla la diffusione della menzogna, visto che quest’ultima ha comunque bisogno di lei per vivere e prosperare. Lo spiega molto bene la tradizione, descrivendo il mentitore prigioniero dei suoi inganni. Se infatti ci sono molti modi di mentire, mentre la verità è una sola, ciascuno di quei modi contiene in sé il vero che può distruggerlo dall’interno. Ed è quanto normalmente dovrebbe fare uno spirito critico ben allenato da una buona istruzione, a patto che abbia voglia e tempo di mettere a tacere quelli che sono in definitiva le sue scimmie, o i suoi giullari: i mentitori.
****
Il 6 dicembre 1864 John Ruskin, un esteta affascinato dai preraffaelliti inglesi e disgustato dalle miserie della società industriale, tiene una conferenza alla Rusholme Town Hall, presso Manchester. Di fronte ai genitori che gli chiedono quale educazione sia più utile dare ai figli, egli rivendica il valore autonomo dell’istruzione. Perché solo l’istruzione realizza uno spazio utopico di eguaglianza, dove le gerarchie sociali si possono invertire. Nasce da qui l’appello a una politica che sostituisca le armi con i libri. Una settimana dopo, sempre a Manchester, Ruskin tiene una seconda conferenza. Al centro c’è proprio il ruolo della donna e l’idea che, grazie alla lettura, essa può conquistare un “potere regale”.
Il critico d’arte britannico troverà un ammiratore e un traduttore d’eccezione in Marcel Proust. Nel 1900, alla morte di Ruskin, gli dedica due necrologi; tra il 1904 e il 1906 traduce i due discorsi manchesteriani. Nell’introduzione al primo (Sesamo. I tesori del re), respinge la concezione utilitaristica e pedagogica -lì teorizzata- della lettura come dialogo con libri-amici. Infatti, questa concezione è per lui in conflitto con “quel meraviglioso miracolo della lettura che è la comunicazione nel cuore della solitudine”.
Ciononostante, dopo aver criticato il paragone fra il libro e l’amico, Proust lo riprende e lo sviluppa a modo suo: “Probabilmente l’amicizia, l’amicizia verso gli individui, è cosa frivola; e la lettura è una forma di amicizia. Ma almeno è un’amicizia sincera, e il fatto che si rivolga a un morto, a un assente, le dà qualcosa di disinteressato, quasi di toccante […]. Nella lettura, l’amicizia è subito riportata alla sua primitiva purezza. Verso i libri, nessuna cortesia. Con questo genere di amici, se passiamo la serata insieme, è perché ne abbiamo davvero voglia. Sul serio, il più delle volte, li lasciamo solo a malincuore […]. Tutte le inquietudini dell’amicizia vengono meno sulla soglia di quell’amicizia pura e serena che è la lettura”.
Il tema cruciale del silenzio viene quindi riproposto in una originale versione del rapporto con il libro-amico, che deve garantire il massimo di trasparenza e di libertà: “L’atmosfera di questa pura amicizia è il silenzio, più puro della parola. Infatti si parla per gli altri, ma si tace con se stessi. Inoltre nel silenzio non c’è traccia, come nella parola, dei nostri difetti, delle nostre moine […]. Lo stesso linguaggio del libro è puro (se il libro merita questo nome), reso trasparente dal pensiero dell’autore che l’ha emendato da tutto ciò che non coincideva con esso, fino a farne la sua immagine fedele”. Secondo Proust, quindi, il libro è una specie di “specchio dell’anima”; e la lettura è un’esperienza del tutto intima e personale, un cammino in cui, incontrando l’altro, si riconosce -e si modifica- il proprio io. Un percorso ai limiti del tempo e dello spazio, là dove si delineano infiniti mondi virtuali e la realtà si apre all’orizzonte del possibile.
Del resto, fin dall’antichità esiste però un farmaco efficace contro l’ansia o, meglio, contro il tumulto delle passioni che ci assale e rischia di travolgerci nelle ore più buie della nostra esistenza. Non è certamente l’unico e non garantisce prodigiose guarigioni, ma, diversamente dagli antidepressivi, non causa danni collaterali: è la lettura, appunto, di un buon libro.