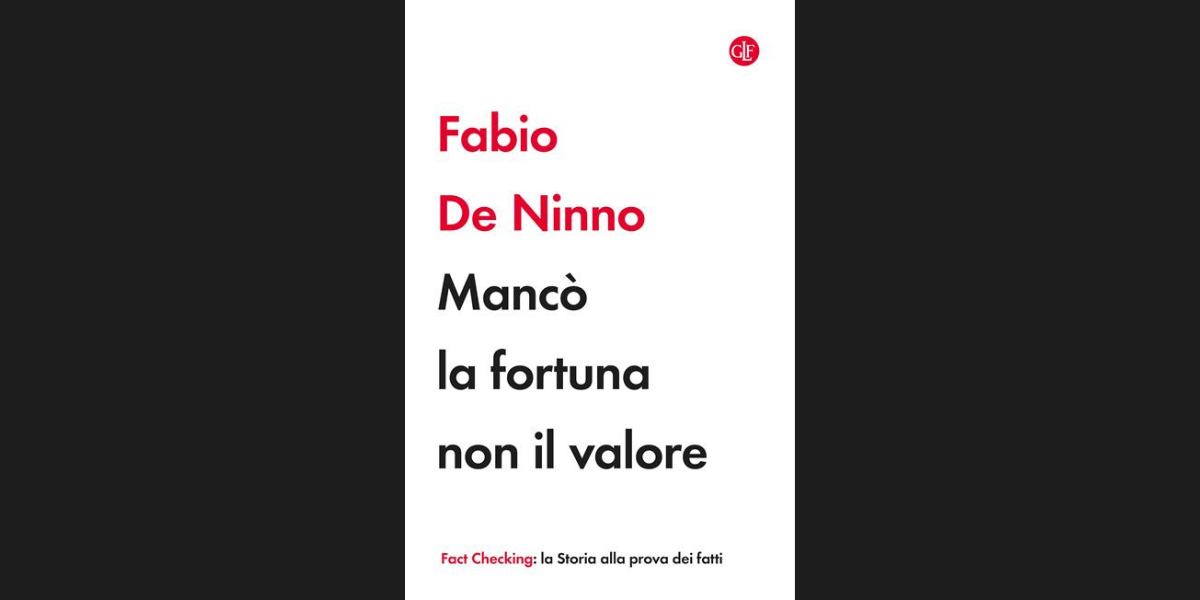Il 29-30 marzo di quest’anno si è tenuto a Rimini il XIV congresso nazionale dell’Uarr (Unione degli atei e degli agnostici razionalisti). Fondata nel 1991, l’associazione ha avuto il suo quarto d’ora di celebrità nel 2020, quando la Cassazione, richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale relativa alla libertà di culto, ha stabilito che “deve essere garantita la pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, e anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente”. Secondo una successiva indagine della Doxa, l’Italia è divisa quasi perfettamente in tre: cattolici praticanti, cattolici non praticanti, altri. Atei e agnostici, da soli, sono quasi la metà degli “altri”. Ora, se il termine “agnosticismo” viene coniato nel 1869 dal biologo britannico Thomas Henry Huxley per denotare la sospensione del giudizio sull’esistenza di Dio, è già intorno alla metà del Cinquecento che il termine “ateismo” -nella sua accezione generale di negazione dell’esistenza di Dio- comincia a circolare in Europa, in latino e nelle lingue volgari.
Non deve però sorprendere la tolleranza mostrata dai vertici della Chiesa nei confronti di alcuni atei illustri del mondo dell’arte e della cultura (Geoges Minois, “Storia dell’ateismo”, Editori Riuniti, 2003). Protetti dalle gerarchie ecclesiastiche, avevano libero accesso alle residenze vescovili, cardinalizie e vaticane; al contrario degli eretici che, da Pietro Valdo (1140?-1217) in poi, venivano inesorabilmente destinati alla tortura e al rogo. Pietro Aretino, ad esempio, non era certo in odore di santità. La sua poesia erotica, i suoi continui attacchi al clero, passavano inosservati grazie a influenti protezioni di re e papi. Poteva perciò concedersi affermazioni estremamente audaci su Cristo e sull’immortalità dell’anima. Le sue commedie -“La Cortigiana” (1535), “La Talanta” (1542), “Il filosofo” (1546)- avevano infatti un accento apertamente antireligioso e materialista.
Lo stesso vale per le opere teatrali di Machiavelli. Nella “Mandragola” (1524), apprezzata persino da Leone X, viene ridicolizzato l’inferno e si incita all’aborto. Il segretario fiorentino è ancora più diretto nel poemetto, rimasto incompiuto, “L’Asino” (1517). È la rappresentazione cruda e impietosa di un mondo in cui gli animali sono più forti, più dotati e più felici degli uomini, tormentati invece dagli affanni quotidiani, dalla paura della morte, dalla sete di ricchezza. Restava una sola scelta: godersi la vita senza stare troppo a riflettere. “Ché ‘n questo fango più felice vivo, dove senza pensier mi bagno e volto”, fa dire al giudizioso ciuco. Per Machiavelli, inoltre, la storia umana non l’epifania della Provvidenza divina ma il regno della Fortuna, e la religione è “istrumentum regni”. Lo sapevano bene tutti i grandi legislatori come Solone, Licurgo, Numa: “Perché, dove manca il timore di Dio, conviene […] che quel regno rovini” (“Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio”, pubblicati postumi nel 1531).
Diversamente da Aretino e Machiavelli, Girolamo Cardano (1501-1576) fu perseguitato dall’Inquisizione. Matematico geniale e inventore prolifico (a lui si deve la serratura a combinazione e il giunto ancora usato nelle nostre autovetture), nel De subtilitate (1550) attribuisce le differenze tra idolatri, cristiani, ebrei e maomettani agli influssi astrali. Fu perseguitato anche il senese Bernardino Ochino, autore di “Dialogi” (1563) tra un ebreo e un cristiano che mettevano in discussione la divinità di Gesù. È allora che le autorità cattoliche e calviniste cominciano a stabilire un rapporto causale tra sodomia e ateismo. L’elenco dei sospettati del vizio contro natura e sottoposti a interrogatori brutali è lungo. Include, tra gli altri, Michele Serveto, Giordano Bruno, Jacques Gruet, Étienne Dolet. La tesi degli inquisitori era perentoria: la depravazione morale di chi rifiuta la verità di Dio è scontata, poiché toglie ogni freno agli abusi sessuali.
Il secolo di Martin Lutero e del Concilio di Trento è contraddistinto, più che da un ateismo dottrinario e speculativo, da un ateismo “pratico”, cioè di colui che agisce e si comporta “etsi deus non daretur”. Un ateismo pratico diffuso negli ambienti più disparati. Il re di Francia Enrico III (1551-1589) ostentava un religiosità profonda, ma non ostacolava i costumi licenziosi dei suoi cortigiani. Gli italiani, venuti in gran numero al seguito di Caterina de’ Medici, sono presto accusati di esere responsabili della dissolutezza dominante a corte. Dal canto suo, la borghesia finanziaria e mercantile, interessata solo agli affari e a accumulare ricchezze, sembrava curarsi molto poco del Padreterno. La stessa influente corporazione dei medici entra nel mirino dei puritani per lo zelo eccessivo posto nello studio del corpo, trascurando così le malattie dell’anima.
[…]Gli storici hanno prestato raramente attenzione agli atei “a loro insaputa” appartenenti agli strati più infimi della società. Uno scritto del 1617, la “Mémoire concernant les pauvres”, descrive il sottoproletariato parigino -formato da circa diecimila disperati- come empio e completamente ignorante: “Molti hanno ammesso di non sapere nulla della comunione e della confessione, altri di non assistere a una messa da almeno cinque anni. Essi rubano, si accoppiano illecitamente, insultano le autorità, si prendono gioco del clero e dei sacramenti, spesso uccidono”. Lo confermano testimonianze provenienti da tutte le città europee: lo sterminato proletariato urbano non credeva nell’aldilà e non aveva alcuna idea della resurrezione di Gesù. Ciononostante, era immerso in una realtà fatta di croci, cimiteri, calvari, campane, chiese, cappelle, processioni, monasteri, chierici, feste comandate. Una realtà talora ossequiata esteriormente dai ceti più umili, ma impermeabile a una superstizione che affondava le sue radici nel Medioevo.
Stesso discorso si può fare per i soldati e i mercenari che attraversavano ogni latitudine del Vecchio continente. La loro reputazione era pessima: “Gente vagabonda, debosciata, dannata, perversa, scellerata, dedita a tutti i vizi, rapitori e stupratori di donne e ragazze, bestemmiatori e negatori di Dio, caduti nell’abisso del male, si comportano peggio dei turchi o degli infedeli”. Era questa l’opinione del re di Francia Francesco I (1494-1547) sulle sue truppe (v. G. Minois, op. cit.). Opinione probabilmente condivisa dal suo acerrimo nemico Carlo V (1500-1558). Quando il 6 maggio del 1527 i lanzichenecchi al soldo del cattolico imperatore del Sacro Romano Impero e re di Spagna entrano a Roma, si abbandonano a inenarribili violenze, stupri, massacri di civili e preti inermi. Si accaniscono contro le opere d’arte, sfigurarono dipinti, decapitarono sculture, rubano l’oro e l’argento conservato nelle chiese e nei palazzi patrizi. Iconoclasti per indole, erano avidi di ogni oggetto che capitava a tiro e smaniosi di sfogare i loro istinti più bassi.
Classificarli come protestanti non sarebbe però preciso. Le milizie mercenarie erano costituite dalla feccia delle società, ossia da individui privi di ogni senso morale e di istruzione religiosa. La maggior parte ignorava di essere luterana, e nemmeno sapeva chi fosse Lutero. Non basta. Era assai difficile disfarsene. Un improvviso periodo di pace dopo decenni di guerre avrebbe causato problemi enormi di ordine pubblico e di sicurezza nei territori in cui erano stanziate le milizie mercenarie, o costi insopportabili per quei principi e sovrani costretti ad aumentare la pressione fiscale per pagare eserciti inattivi. Paradossalmente, la guerra era meno cara della pace, perché gli eserciti in parte venivano compensati con il bottino delle rapine e dei saccheggi. Una volta formate, le milizie non si potevano sciogliere senza gravi ripercussioni sulla stabilità delle monarchie.
[…]Le proteste delle popolazioni, i dipinti di Brueghel, i disegni di Dürer, non lasciano dubbi sulle gesta efferate degli eserciti dei Valois e degli Asburgo. Le stesse frequenti ordinanze reali volte a reprimere gli atti più sconci dei militari (come la defecazione nelle acquasantiere) si rivelano del tutto inefficaci. Le armate somigliano sempre più a bande di malfattori e di miscredenti. Il fenomeno assumerà dimensioni ancora più rilevanti all’inizio del Seicento, con l’impiego massiccio di truppe mercenarie nella guerra dei Trent’anni (1618-1648).
Un saggio di Franco Cardini racconta minuziosamente come, accogliendo nelle proprie file emarginati, vagabondi, criminali, squilibrati, sadici, gli eserciti si trasformino in prigioni e ospedali ambulanti, ciascuno comprendente da trentamila a cinquantamila “ospiti” (“Quell’antica festa crudele. Guerra e cultura della guerra dal Medioevo alla Rivoluzione francese”, il Mulino, 2020). Ospiti a cui comunque occorreva garantire il soldo pattuito pena sedizioni cruente, in quanto non sempre era sufficiente il ricavato delle razzie nei villaggi e nei campi coltivati dei contadini. Le gloriose armate di Wallenstein e di Condé, dunque, erano composte dalla futura popolazione penitenziaria, quella dei bagni penali, delle galere, degli ospizi, che ora si aggirava per le campagne. È stato questo il conto saldato per ottenere precarie tregue sociali.
[…]L’ateismo cinquecentesco, dunque, si presenta in innumerevoli forme e lambisce tutti gli ambienti sociali. C’è chi per questo ha proposto, come Minois, di chiamarlo il “secolo degli increduli”, raggruppando con questa espressione tutti coloro che non riconoscono l’esistenza di un dio personale e che si cura del mondo. Non solo atei, quindi, ma agnostici, panteisti, scettici, indifferenti e anche deisti, considerate le infinite sfumature che caratterizzano tali posizioni. Ma si trattava spesso di un’incredulità manifestata con discrezione anche in privato, che solo pochi spiriti coraggiosi esibivano alla luce del sole. Malgrado ciò, i teologi non di rado venivano spiazzati dalle domande di questa specie di franchi tiratori del libero pensiero sulle gandi questioni della grazia, del libero arbitrio, dell’eucarestia, della predestinazione, del potere papale.
[…]*Il Foglio