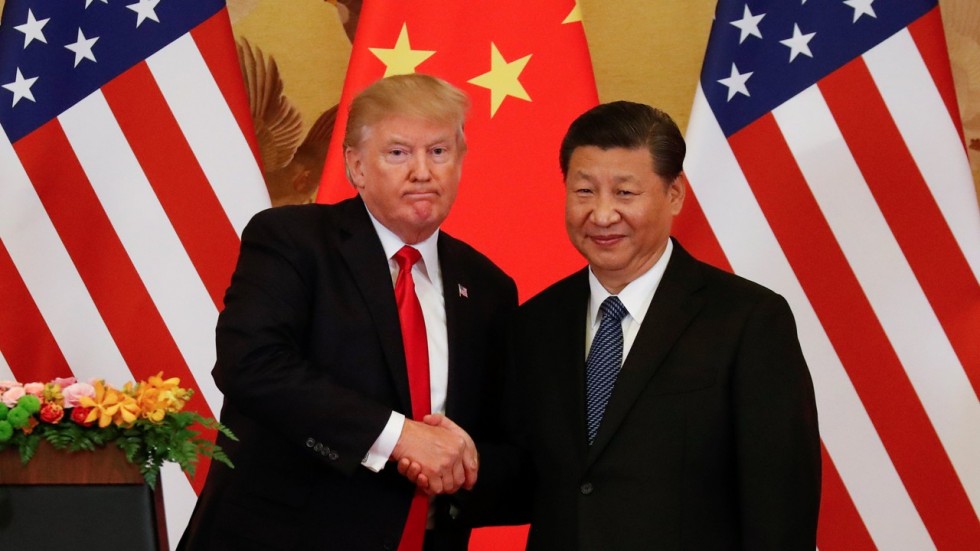Se il primo non sembra opinabile, il secondo mestiere più antico del mondo è quello del mercenario. Per Anthony Mockler, suo autorevole studioso, è più di un’ipotesi (“Storia dei mercenari”, Odoya, 2012). Già nel secondo millennio avanti Cristo, infatti, mercenari erano i sardhana, predoni sardi al servizio del faraone Ramses II. Gli Hittiti arruolavano i pirati lici e gli Assiri i montanari dello Zagros mesopotamico. Di mercenari si servivano il tiranno ateniese Pisistrato e il tiranno di Samo Policrate. Mercenari erano i diecimila greci al soldo del satrapo persiano Ciro il Giovane, le cui gesta sono narrate da Senofonte nella “Anabasi”. Mercenari erano anche i celti, i numidi e gli iberici impiegati da Cartagine nelle tre guerre puniche contro Roma. Le stesse legioni romane erano affiancate da frombolieri delle Baleari a da arcieri cretesi. Prima dell’anno Mille, gli imperatori bizantini utilizzavano guerrieri longobardi e dalmati, alamanni germanici e variaghi scandinavi, come guardia personale o per scortare i catafratti, cavalieri muniti di pesanti corazze.
È però nel Medioevo che il fenomeno del mercenariato si diffonde e si afferma in tutta Europa. Nel sistema feudale, il servizio militare obbligatorio del vassallo non oltrepassava di norma i quaranta giorni annui. Una durata che ostacolava la formazione di eserciti permanenti, necessari per sostenere le mire espansionistiche e le conquiste dei sovrani. Per aggirare questo inconveniente, nel 1159 il re d’Inghilterra Enrico II introduce lo “scutagium”, una tassa attraverso cui finanziare il mantenimento di milizie stabili, costituite in prevalenza dagli stessi nobili più bellicosi. Nel 1337, quando Edoardo III decide di sospendere il tributo che -come duca d’Aquitania- doveva versare al sovrano di Francia (dando così inizio alla guerra dei Cent’anni), il Parlamento di Westminster istituisce per i combattenti la “paga del re”. Una decisione che accelera il superamento del vincolo di lealtà di tipo feudale.
Dopo il trattato di Brétigny (1361), che sancisce la vittoria degli inglesi nella prima fase del conflitto, molti uomini d’arme scelgono di organizzarsi in “libere compagnie”. Il timore di un declassamento sociale ed economico li spinge a offrire i propri servigi al miglior offerente. Del resto, sir Robert Knollys, Perrot le Béarnais, Bertrand de la Salle, sir James Piper, Geoffroy Tête-Noire e tutti i più arditi capitani di ventura del tempo sapevano che avrebbero sempre trovato un castello da espugnare, un borgo da saccheggiare, un riscatto da esigere. Molte compagnie, inoltre, traevano ingenti guadagni dalla “protezione” di villaggi e città: una specie di “pizzo” ante litteram, della cui riscossione si incaricava un ufficiale, il “clerc de patis”. Tuttavia, pur avendo minato due bastioni dell’ordinamento feudale, ossia il rapporto indissolubile tra sangue e valore militare e la proprietà della terra come fonte del potere, solo in Italia esse riusciranno a diventare politicamente influenti.
Nel corso del Trecento diverse grandi compagnie -tutte straniere- scenderanno nella penisola. Dopo un ventennio di scontri sanguinosi, all’inizio del secolo il trattato di Caltabellotta (1302) aveva ratificato la fine delle ostilità tra Carlo d’Angiò e Pietro III d’Aragona per il controllo del Reame di Napoli. Gli angioini si installano nella capitale partenopea, gli aragonesi in Sicilia. All’inatteso successo dei secondi avevano in buona misura contribuito gli almogaveri, una fanteria di mercenari navarri. Privi di armatura, portavano abiti di seta e calzavano sandali. Il loro nome derivava dall’arabo “al-mughawir” (incursore). Ormai disoccupati e indesiderati per la loro efferatezza, sotto la guida di Roger de Flor si riorganizzano nella Compagnia Catalana, che l’imperatore bizantino Andronico II chiamerà a Costantinopoli per fermare l’avanzata dei turchi.
Roger de Flor era un condottiero, cioè un capitano mercenario che aveva firmato una “condotta”, documento in cui erano specificate dettagliatamente le clausole contrattuali per l’ingaggio dei soldati venturieri (la parola soldato viene da soldo). È in questo periodo che fanno la loro apparizione le “libere lance”. Il termine lancia designava sia l’arma sia l’unità di base della compagnia, composta da un cavaliere, uno scudiero e tre valletti. L’espressione “free-lance” (coniata da Walter Scott nel romanzo “Ivanhoe”), nel suo significato di lavoro indipendente, occasionale e temporaneo, ne è la traduzione inglese.
Nel 1362 il marchese di Monferrato recluta la Compagnia Bianca di sir John Hawkwood, un cavaliere condiderato allora imbattibile. Nominato da Riccardo II d’Inghilterra suo ambasciatore presso la Santa Sede, Giovanni Acuto -come verrà ribattezzato da Niccolò Machiavelli- per diciotto anni rivestirà la carica di “capitano del popolo” di Firenze, ossia comandante della milizia cittadina. Sotto il suo ritratto, dipinto da Paolo Uccello nel Duomo della città gigliata, si può leggere: “Joannes Acutus, eques britannicus, dux aetatis suae cautissimus et rei militaris peritissimus”.
L’astuto diplomatico e consumato stratega militare, in effetti, era riuscito a surclassare i suoi più agguerriti concorrenti dell’epoca: la Compagnia del Cappellotto di Hartmann von Wartenstein, la Compagnia del Fiore di Hugo von Melchingen, la Compagnia della Stella di Hans von Bongard. Tutte utilizzate da Pisa, Siena, Perugia e Lucca in cruente lotte intestine. Papa Urbano V, che mal tollerava la loro ingerenza nel controllo dello Stato pontificio, nel 1365 dalla residenza avignonese sollecita le compagnie a impegnarsi in una nuova crociata. Perfino Caterina da Siena si rivolgerà al suo “carissimo e amatissimo fratello in Gesù Cristo, messer Giovanni [Hawkwood]”, incitando lui e i suoi seguaci a “divenire una compagnia di Cristo e marciare contro i cani di infedeli che posseggono i nostri luoghi santi”. L’appello cadrà nel vuoto, e con una bolla papale le compagnie verranno scomunicate. Dieci anni più tardi Gregorio XI la annullerà, cambiando radicalmente la linea della Chiesa nei loro confronti.
Il 1378 è l’anno del “grande scisma” cattolico, che segna uno spartiacque nella storia dei mercenari in Italia. Spodestato dal collegio cardinalizio, che lo aveva sostituito con Roberto di Ginevra (Clemente VII), Bartolomeo Prignano (Urbano VI) chiede aiuto ad Alberico da Barbiano, un pupillo di Giovanni Acuto. Alberico non ci pensa due volte, e schiera la sua “Societas Italicorum Sancti Giorgii” contro le orde bretoni di Silvester Bude e Bertrand de la Salle al servizio dell’antipapa. Dopo una battaglia durissima, il 30 aprile 1379 le sbaraglia a Marino, a dodici miglia da Roma. Ricevuto a piedi nudi da Urbano VI, gli viene promessa vita eterna da santa Caterina e gli viene donata una bandiera bianca con una croce rossa su cui campeggiava il motto: “Italia liberata dai barbari”.
Terminava così l’epopea dei condottieri d’oltralpe e d’oltremanica, e cominciava quella dei condottieri italici. Ben presto entreranno nella leggenda figure come quelle di Bartolomeo Colleoni, Muzio Attendolo, Facino Cane, Francesco Bussone detto il Carmagnola, Braccio da Montone, Niccolò Piccinino, Erasmo da Narni detto il Gattamelata (per la gatta color miele scolpita sul suo cimiero). Un elenco in cui l’Umbria di san Francesco spicca come la regione più prolifica di capitani di ventura. Certamente per la sua vicinanza al Soglio di Pietro, ormai tra i loro maggiori committenti. Ma anche perché -come ha osservato l’erudito ternano Ansano Fabbi- “sia il mistico sia il guerriero umbro mostravano sempre uno spirito forte e ribelle ai compromessi e alla ricchezza smodata”.
Alla fine del Quattrocento, il panorama del mercenariato italiano muta profondamente. Molti condottieri diventano duchi e molti duchi condottieri. L’ultimo Visconti, il duca Filippo Maria, sposa la vedova di Facino Cane, mercenario di umili origini. Francesco Sforza, figlio del contadino Muzio Attendolo, diviene duca di Milano, e Federigo di Montefeltro, duca di Urbino, un provetto condottiero. Lo stesso figlio di papa Alessandro VI, Cesare Borgia, sarà cardinale, duca, condottiero e committente di condottieri.
Insomma, una nuova generazione di capitani mercenari si era affacciata sulla scena politica e militare. Non più soltanto di basso lignaggio, ma proveniente da casati illustri come i Baglioni, gli Orsini, i Medici, i Colonna. L’ascesa al potere dei più scaltri sarà favorita, più che dalla cronica condizione di belligeranza in cui versava la penisola, dall’assenza di milizie locali consistenti e da un debole spirito feudale. A Firenze su ogni cento cittadini, cinque dovevano prestare servizio militare per novanta giorni all’anno. Nel 1351 questo servizio verrà commutato con un versamento in denaro (analogo al citato “scutagium”). In questo modo i fiorentini raccoglievano fino a cinquantaduemila fiorini annui, in parte investiti proprio per il reclutamento di milizie mercenarie. Per altro verso, rituali come le investiture, i giuramenti, gli atti di omaggio e le sfide a singolar tenzone rimanevano importanti. Ma la vera base del sistema feudale, l’idea che il ruolo sociale dell’individuo fosse inalterabilmente stabilito dalla sua nascita, in Italia non era mai stata forte.
Ha scritto Jacob Burckardt che “la liberalità dei principi nordici del XIII secolo era limitata ai cavalieri; alla nobiltà che serviva e adulava. Era ben diverso con il despota italiano. Con la sua sete per la fama e la passione per le opere monumentali non aveva bisogno di nascita, ma di talento. In compagnia di poeti e letterati -e, si può aggiungere, di mercenari- egli si sentiva in una nuova posizione; quasi in possesso di una nuova legittimità” (“La civiltà del Rinascimento in Italia”, Newton Compton, 2010).
Al grande storico del Rinascimento non sfuggiva l’orgoglio professionale dei condottieri italiani, che non escludeva un qualche loro impegno anche in campo civile. Questo orgoglio, infatti, non aveva prodotto solo due rinomate scuole militari: quella dei “bracceschi” (da Braccio da Montone), famosi per l’impeto dei loro assalti; e quella degli “sforzeschi” (da Francesco Sforza), inventori di ingegnosi stratagemmi tattici. Giovanni Acuto si era preoccupato di sovvenzionare l’ospedale inglese di Roma. Francesco Sforza aveva costruito palazzi e monasteri in tutto il milanese. Federigo da Montefeltro poteva vantare la collezione di libri più vasta e più preziosa d’Europa, che diventerà il nucleo della Biblioteca vaticana. Eppure le fortune da lui accumulate risalivano quasi esclusivamente alla sua attività di condottiero, prima al servizio di papa Pio II contro il Piccinino, poi contro il Colleoni; e infine al soldo della Lega fiorentina contro Venezia.
C’è quanto basta almeno per mitigare la pessima reputazione di cui godevano i condottieri. Convinto assertore della coscrizione popolare, nel “Principe” Machiavelli ne darà invece un giudizio assai aspro e sprezzante: “[…] o sono uomini nelle armi eccellenti o no: se sono, non te ne puoi fidare, perché sempre aspireranno alla grandezza propria, o con l’opprimere te che li se’ patrone, o con l’opprimere altri fuora della tua intenzione; ma, se non è il capitano virtuoso, e’ ti rovina per l’ordinario […]. E per esperienza si vede a’ principi soli e repubbliche armate fare progressi grandissimi, e alle arme mercenarie non fare mai se non danno”. Si spiega, quindi, il compiacimento del Segretario fiorentino per la “strage di Senigallia” (gennaio 1503), ordita da Cesare Borgia contro Paolo Orsini, Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo e Giampaolo Baglione, rei di aver congiurato contro di lui.
(PRIMA PARTE)