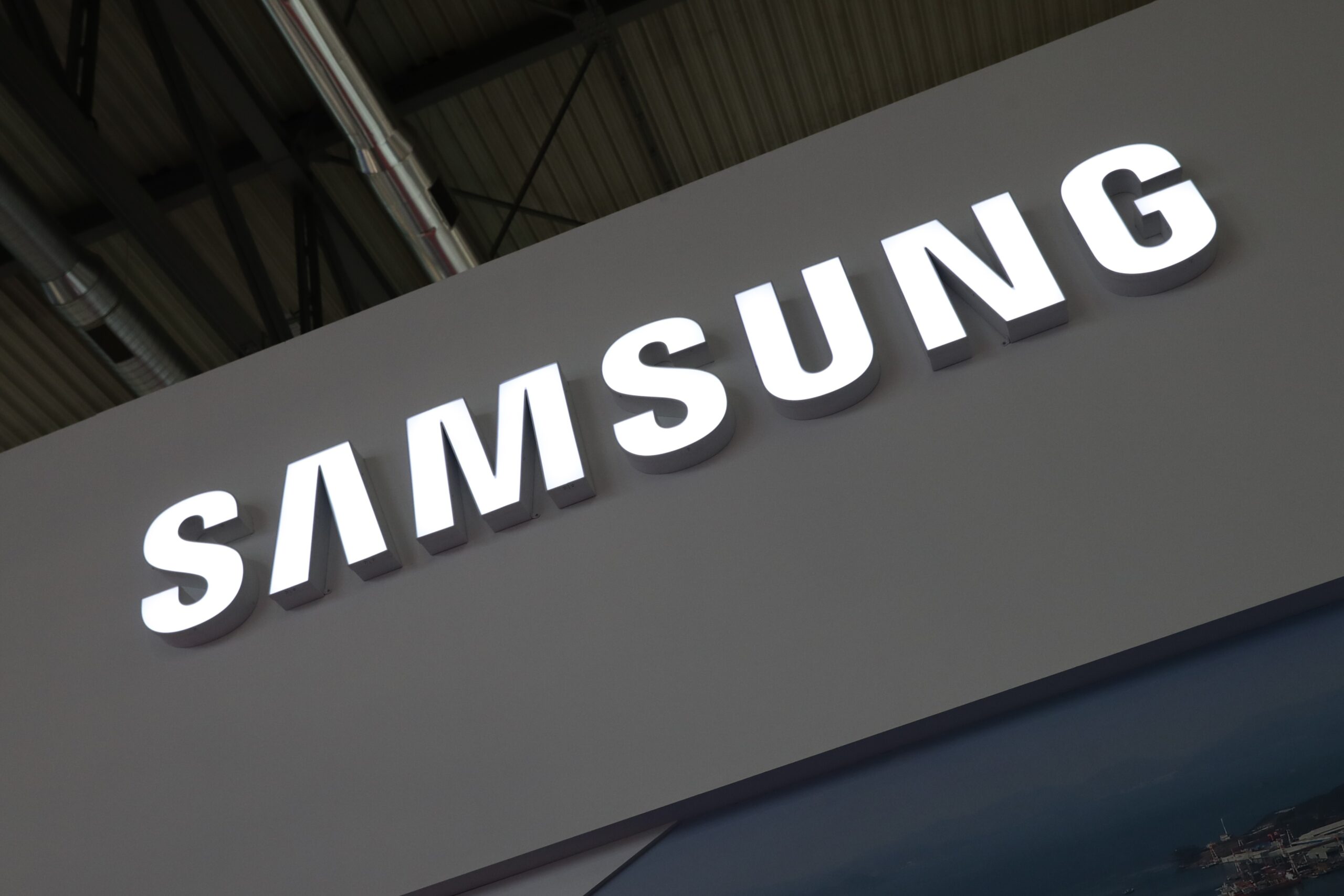Manhattan, 14 gennaio 1970. Siamo in un lussuoso attico che domina Park Avenue. Il padrone di casa è Leonard Bernstein, Lenny per gli amici, musicista, compositore, pianista, direttore d’orchestra. Una squadra di camerieri rigorosamente bianchi (per non offendere gli ospiti afroamericani), serve bocconcini di roquefort ricoperti di noci tritate. La cena è stata organizzata per finanziare la difesa legale dei membri del Black Panther Party in prigione con pesantissime accuse (da cui saranno prosciolti).
Tra gli invitati della bella e sofisticata Mrs Bernstein, nata Felicia Montealegre, ci sono Jason Robards e Lillian Hellman, Giancarlo Menotti e Aaron Copland, Mike Nichols e Richard Avedon, Peter Duchin e Arthur Penn, Harry e Julie Belafonte, Sidney Lumet e Otto Preminger.Vengono scambiate ricette di cibo “soul”. Poi, in un clima definito da Wolfe “nostalgie de la boue”, nostalgia del fango, insomma voglia di esplorare lo stile di vita delle classi inferiori, esplode un’accesa discussione, puntualmente registrata da Charlotte Curtis con due articoli scritti il giorno dopo per il New York Times, intitolati “Un elegante tour dei quartieri poveri”.
La serata verrà raccontata anche dal dandy metropolitano Tom Wolfe in Radical Chic, That Party at Lenny’s (sottotitolo italiano, “Il fascino irresistibile dei rivoluzionari da salotto”), un lungo resoconto dell’evento pubblicato dal New York Magazine nel giugno 1970. Diventerà persino più celebre del celeberrimo ballo in bianco e nero organizzato quattro anni prima da Truman Capote al Plaza Hotel di New York (ospite d’onore Katharine Graham, la prima editrice donna del Washington Post). Con la locuzione “radical chic”, Wolfe intendeva designare una certa sinistra snob, mondana e progressista. Locuzione che sarà poi tradotta in altre lingue, sempre con una connotazione vagamente dispregiativa, come “gauche caviar” in francese, “esquerda caviar” in portoghese, “salonkommunist” in tedesco.
Wolfe è stato molto di più di un semplice giornalista. Con il suo modo di fare, da dandy del Sud, e i sui completi bianchi, molto eleganti e un po’ vecchio stile, ha rivoluzionato il modo di fare informazione. Uno dei suoi più celebri articoli, pubblicato sul New York Magazine il 21 febbraio 1972, intitolato “The New Journalism”, sancì la nascita di quella scuola di scrittura caratterizzata dall’utilizzo delle tecniche narrative proprie della letteratura applicate al giornalismo. Nato nel 1930 a Richmond, in Virginia, Wolfe è morto il 14 maggio 2018. Satirico, beffardo, conservatore, acuto osservatore dei costumi del suo tempo, ha conquistato il grande pubblico con i suoi romanzi, anzitutto con Il falò delle vanità (1987), un ritratto impietoso del mondo di Wall Street (finito sul grande schermo grazie a Brian De Palma).
Se in Francia fu Raymond Aron, da noi fu Indro Montanelli a riprendere i temi di Wolfe in un altro celebre articolo del 1972 sul Corriere della Sera. L’attacco era rivolto a Camilla Cederna, principale ispiratrice della lettera aperta pubblicata l’anno precedente sul settimanale L’Espresso contro il commissario Calabresi. Ma probabilmente il suo vero obiettivo era Giulia Maria Crespi, la zarina della borghesia imprenditoriale milanese, proprietaria del quotidiano di Via Solferino da lei schierato su una linea progressista con la direzione di Piero Ottone.
In ogni caso, i ricchi di sinistra di Wolfe, che “offrono champagne a quelli che li impiccheranno”, non furono impiccati, ma rimasero impiccati -Bernstein e i suoi amici artisti e intellettuali- alla sua spietata definizione. Da allora è diventato radical chic tutto ciò che odora di solidarismo (“è per lavarsi la coscienza!”) o di amore per la cultura (“è per umiliare la gente semplice!”), e ovviamente di critica del populismo (“è disprezzo per il popolo!”). Insomma, è stato utilizzato con spregiudicatezza per bollare quel vasto e disorientato mondo detto “sinistra occidentale” come una ipocrita cricca di potenti con la puzza sotto il naso, che ha perduto ogni “rapporto sentimentale” (espressione molto di moda nella sinistra italiana) con i ceti popolari.
L’hanno perduto nelle ultime elezioni presidenziali? No e sì. No, se si pensa che Kamala Harris ha pur sempre avuto sessantotto milioni di voti (e non possono essere solo professori di Harvard e gay). Sì, se si pensa che quel rapporto oggi appare profondamente compromesso, con i “rednecks dell’Ohio” (ovvero i bifolchi), e con essi quasi l’intera working class degli Stati Uniti, che non si sentono minimamente rappresentati dai democratici.
In queste ore si stanno versando fiumi d’inchiostro su tale questione, e non è qui possibile elencare tutti i deficit di linguaggio, di identità e di progetto che minacciano di affondare la sinistra americana. Tuttavia, ammesso e anche concesso che i liberal per i bifolchi dell’Ohio hanno fatto poco e male, che cosa ha fatto per loro Donald Trump? La risposta è la stessa: poco o niente. Ma, anzitutto, cosa farà per loro nel prossimo quadriennio? Difficile dirlo. Chi vivrà, vedrà. Sapendo però che, in fondo, a chi si riconosce nello slogan della variante estrema del trumpismo (“Make America Great Again”), il popolo va benissimo così com’è.