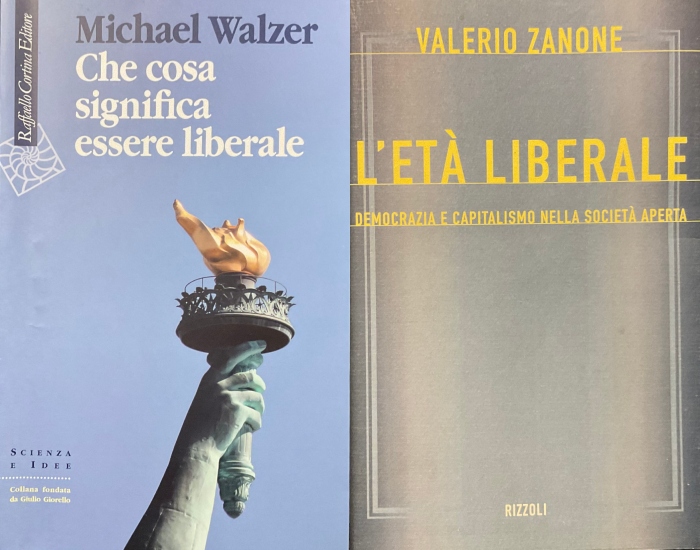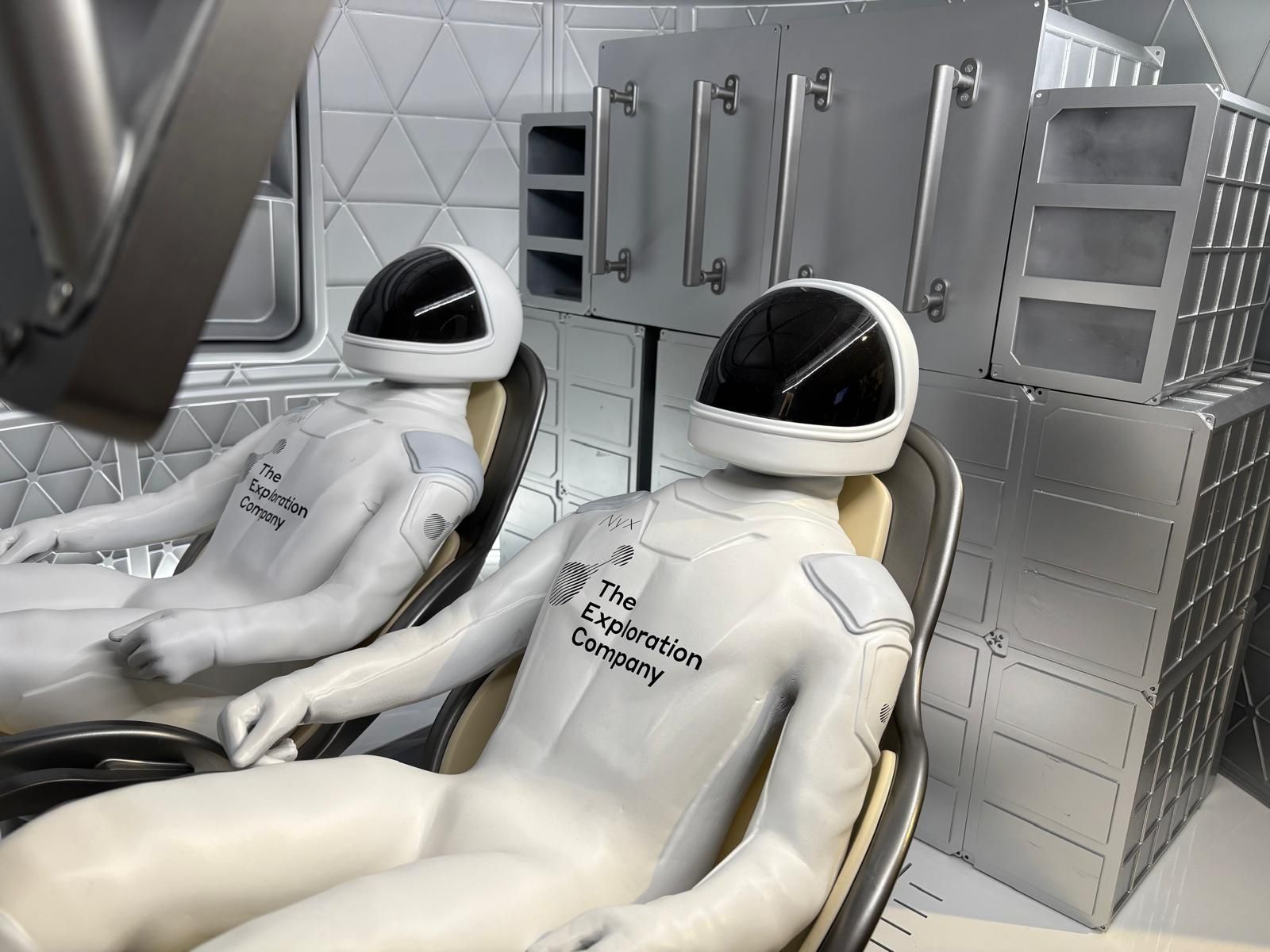Il termine “liberale” è ottocentesco. Entra nel linguaggio politico con le Cortes di Cadice nel 1812, in cui designava il partito delle pubbliche libertà opposto al partito “servil”, fedele al vecchio ordine assolutistico. Nel Novecento i partiti che si richiamavano al liberalismo hanno occupato negli schieramenti parlamentari posizioni assai diverse: conservatrici, centriste, moderate, progressiste. Secondo Benedetto Croce, tuttavia, il vero liberalismo non aveva bisogno di aggettivi per definire la sua dottrina. Il suo nome bastava a se stesso “perché i liberali non potevano dividersi in conservatori o democratici, moderati o progressisti, essendo, per vocazione e per coerenza intellettuale, accomunati dalla missione comune di stabilire e far rispettare la libertà” (Taccuini di guerra. 1943-1945, Adelphi, 2004).
Di tutt’altro avviso è Michael Walzer nel suo ultimo libro, che in inglese si intitola The Struggle for a Decent Politics: On ‘Liberal’ as an Adjective (“La lotta per una politica decente: ‘liberale’ è un aggettivo”), che si ispira a due testi che rendono omaggio proprio a questo aggettivo. Il primo è Socialismo liberale di Carlo Rosselli (1930). Il secondo è Liberal Nationalism della studiosa e politica israeliana Yael Tamir (1995). Ambedue modelli esemplari, rispettivamente, di un socialismo e di un sionismo non dogmatico, democratico e pluralista (Che cosa significa essere liberale, Raffaello Cortina Editore, aprile 2023). Ma chi è, oggi, un liberale? È chi, risponde il professore emerito dell’Institute for Advanced Study di Princeton, non ha dimenticato l’accezione più antica del vocabolo. Essa alludeva a una vita vissuta nell’ozio in cui coltivare la mente; ma non l’ozio dei ricchi indolenti: semmai, un impegno dal passo lento e riflessivo nelle “arti liberali” e nell’apprendimento della cultura classica. Il gentiluomo di una volta non era soltanto il detentore di un certo rango nella gerarchia sociale, ma anche e soprattutto una persona di modi gentili e mente curiosa. Per Walzer, pertanto, oggi i liberali sono meglio descritti in termini morali anziché in termini poltici o culturali: è liberale chi non è fanatico e settario, ma altruista e tollerante, qualunque sia la sua ideologia e la sua religione. Una sensibilità descritta magistralmente da poeti come la polacca Wislawa Szymborska, l’israeliano Yehuda Amichai e tre americani: Philip Levine, Philip Schultz e C.K. Williams. Sono loro cinque “ad avermi insegnato qualcosa sulla compassione, sull’umorismo e sull’ironia gentile che si accompagnano all’aggettivo ‘liberale’, ma che non escludono la rabbia e un feroce realismo”.
Come traspare anche da questo brano, il libro di Walzer non è un trattato accademico. Le sue pagine non hanno nulla di sistematico; sono disseminate di racconti, aneddoti, riflessioni, riferimenti storici, citazioni raccolte nel corso di una vita di letture. Tutte si propongono di dimostrare che il “liberalismo del New Deal” è la versione statunitense del liberalsocialismo europeo, e non un radicalismo estremista. Lo testimonia il modo con cui egli affronta il tema controverso della meritocrazia, che anche in Italia è al centro di un aspro dibattito. Dal punto di vista dell’eguaglianza, non c’è nulla di sbagliato -sostiene Walzer- nell’assegnare posizioni nei servizi pubblici, in un’università o in un ospedale, a uomini e donne di talento e competenti, presupponendo una procedura di selezione non corrotta dal denaro o dal potere, dalla razza o dal sesso. Anche se occorre sempre guardarsi da quella che Shakespeare chiamava “l’insolenza della carica”. Lo stesso vale per chi si candida a una funzione di governo, e promette che le proprie capacità miglioreranno il paese. Devono essere gli elettori a decidere se l’affermazione è fondata. Ma non si dovrebbe mai prendere in considerazione niente di simile all’idea di John Stuart Mill, e cioè di dare un doppio voto a chi è laureato in quanto le sue conoscenze lo rendono politicamente più saggio. Non è così: “Conosco persone molto istruite che sono degli idioti politici. Le persone colte dovrebbero essere rispettate nei propri campi, dove il loro sapere è pertinente, ma non altrove, dove non lo è”.
In Sfere di giustizia (1983), Walzer scriveva: “Questa è l’eterna speranza nominata dalla parola eguaglianza: mai più inchini e prostrazioni, mai più adulazioni e servilismi, ma più altezza e eccellenza, mai più servi e padroni”. Ma quanta diseguaglianza è compatibile con una società giusta? Quarant’anni dopo ritorna su quella speranza con argomenti che forse risulteranno indigesti alle sinistre “pauperiste”. Se un imprenditore di successo -sottolinea Walzer- può permettersi una vacanza più costosa della mia, la differenza di reddito non è un’offesa a un malinteso egualitarismo. Se invece può acquistare cure mediche a me inaccessibili, questo è ingiusto. Avere più soldi di un altro non è un crimine. Non si dovrebbe poter comprare un giudice, un senatore, o (auspicabilmente) armi ad alto potenziale offensivo, o cibi contaminati. E il mercato va certamente regolato. Ma “non ho mai compreso la critica della sinistra al consumismo, come se ci fosse qualcosa di sbagliato nel fare acquisti o nel desiderio di cose belle. […] Mio padre gestiva una gioielleria e mi raccontò storie di famiglie di operai siderurgici che venivano a comprare una collana o un braccialetto per le loro figlie sedicenni: erano acquirenti orgogliosi. Una conquista che in troppi a sinistra non apprezzano”.
La prima ragione dell’ostilità di “quei troppi” verso il mercato è stata sempre quella che il profitto, e le tecniche adottate per accumularlo, incentiverebbero una concezione materialistica del benessere, inducendo consumi futili e volgari. Ora, può anche essere deplorevole che nelle stazioni di servizio sulle autostrade si vendano più cassette di canzoni atroci che di musica classica, o che la tiratura dei rotocalchi pettegoli superi quella delle riviste letterarie. Poiché del passato si salva per fortuna la memoria dei letterati e dei musicisti, e non quella dei pettegolezzi e delle canzonette usa e getta, viene da immaginare che lo sviluppo capitalistico abbia provocato un involgarimento dei costumi. Ciò deriva dal fatto che fino all’età moderna, ossia all’età in cui il capitalismo si è sposato con la democrazia, le élite sociali e culturali sono state il soggetto dominante della storia. Soltanto la rivoluzione industriale e la rivoluzione democratica hanno portato in primo piano i gusti e i consumi delle masse. Sarebbe senz’altro desiderabile che esse mostrassero gusti colti e costumi raffinati, ma il compito di svilupparli spetterebbe più al sistema educativo che ai capitalisti.
Walzer dedica uno dei capitoli più originali del suo volume alle “femministe liberali”, in cui tiene in gran conto l’opera della neozelandese Susan Moller Okin, nota soprattutto per aver posto l’accento sulla giustizia all’interno della famiglia e per la sua critica al multiculturalismo (Le donne e la giustizia. La famiglia come problema politico, Dedalo, 1999). Alcune religioni impongono codici di abbigliamento alle donne, denuncia Okin, per limitare la loro libertà al di fuori della famiglia e per rafforzare le restrizioni che subiscono all’interno della famiglia. Per altro verso, gli sforzi per proibire particolari capi di vestiario, per esempio il velo in Francia, sembrano soltanto aumentare il numero delle donne che scelgono di indossare ciò che è vietato -magari più per solidarietà che per convinzione. Più leggi, insomma, comportano più veli e più corpi coperti. Con una possibile eccezione, aggiunge Walzer: il burqa musulmano. Non solo perché nasconde l’identità negli ambienti legali -allo sportello passaporti, nei tribunali- che richiedono il volto scoperto. Ma anche perché in una democrazia liberale l’inimitabile sé di ciascuno dovrebbe essere mostrato senza vincoli tanto in pubblico che in privato. Il che non implica vietare il burqa, ma soltanto garantire alle donne che possono toglierlo quando vogliono. Peraltro moltissime donne credenti, negli Stati Uniti e in altri paesi, si stanno attivamente opponendo alla discriminazione dall’interno delle proprie comunità, cercando nei testi sacri nuove interpretazioni a favore della parità di genere. La differenza è un valore, ma lo è ancora di più quando è espressa dalle donne stesse. Ogni volta che le donne lottano contro la subordinazione all’altro sesso, le autorità statali non dovrebbero fare altro che salvaguardare i diritti democratici che rendono possibile tale lotta.
David Ben Gurion nel 1958 rivolse a una cinquantina di intellettuali, i “Saggi di Israele”, una cruciale domanda: Chi è ebreo? Il quesito all’epoca assunse un carattere di estrema urgenza a causa della cosiddetta “Legge del ritorno”, la norma che, in contrasto con la tradizione talmudica (Halakhah), consentiva anche a chi non era figlio di madre ebrea o a chi non aveva completato il percorso di conversione di ricevere la cittadinanza israeliana. La risposta (maggioritaria) degli studiosi fu che non era necessario porre la domanda poiché la religione dice che solo il figlio di una madre ebrea è un ebreo. Classe 1935, ebreo newyorkese, studente di una università ebraica, la Brandeis, Walzer era ovviamente molto interessato alle accese discussioni che animavano la Knesset, in particolar modo sull’accettazione dei figli dei matrimoni misti, ossia di madre non ebrea. Nel 1957 si era imbarcato con la moglie su una nave diretta a Haifa. Unici passeggeri paganti, gli altri erano rifugiati egiziani che avevano lasciato il loro paese dopo la crisi di Suez del 1956, e rifugiati polacchi costretti all’esilio dopo che le riforme di Gomulka avevano reintrodotto l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Gli egiziani erano ebrei ortodossi, i polacchi erano ebrei comunisti.
Il viaggio lo convinse che perfino la vecchia massima “Anche un ebreo che commette peccato rimane sempre un ebreo” esprimeva un orientamento liberale. E infatti negli Usa gli ebrei non tradizionalisti si erano schierati in prima linea a sostegno dello Stato laico creato dai padri fondatori. George Washington, in una lettera del 1790 alla congregazione ebraica di Newport, aveva solennemente dichiarato che “una classe di cittadini non gode dell’esercizio dei propri diritti naturali in virtù dell’indulgenza di un’altra classe di cittadini”. L’ebreo, come ogni cittadino americano, si sarebbe “seduto sicuro sotto la propria vite e il proprio fico, e non ci sarebbe stato nessuno a spaventarli”. Il temperamento dell’ebreo liberale, osserva inoltre Walzer, mal si concilia con una concezione “lacrimosa” della storia del popolo dell’Alleanza. Perché essa è anche una storia di coraggiosa innovazione, di creatività intellettuale, di sopravvivenza collettiva contro ogni avversità. La maggior parte degli americani pensa che i liberali di qualunque fede votino Partito democratico, anche se ci sono repubblicani che rispettano la Costituzione, credono in una magistratura indipendente, si sentono a proprio agio in una società laica e pluralista.
Ma, si chiede da ultimo il filosofo americano, come applichiamo l’aggettivo “liberale” a figure storiche che incarnano quelle che oggi consideriamo contraddizioni radicali? Voltaire si batteva coraggiosamente per la libertà religiosa dei protestanti nella Francia cattolica, ma era razzista e antisemita. Thomas Jefferson fu uno dei redattori della Dichiarazione di Indipendenza del 1776, ma aveva degli schiavi. John Stuart Mill condannava ogni tentativo dello Stato di limitare la libertà di opinione, ma appoggiò il colonialismo con una visione paternalistica delle nazioni “meno avanzate” dell’Inghilterra. O, ancora, molti esponenti del pensiero liberale (non però Mill) davano per scontata l’inferiorità delle donne. La loro reputazione è stata messa di recente sotto accusa. È diventato di moda rimproverare le colpe dei nostri antenati. Walzer, con la garbata ironia che gli è consueta, si prende gioco di questa deriva inquisitoria. E lo fa servendosi di un versetto della Bibbia su Noè che recita: “Era un virtuoso tra la sua generazione”. Era, cioè, un uomo virtuoso nel suo tempo, non un virtuoso per tutte le stagioni. Tra i suoi contemporanei, era un buon cittadino.
Così come, nella loro epoca, Voltaire era un un filosofo liberale, Jefferson un repubblicano liberale e Mill un liberale puro. Mentre non è mai esistita né può esistere una teocrazia liberale, ovvero un governo liberale di sacerdoti, rabbini, imam, ayatollah. Chi parla in nome di Dio è intollerante nei confronti del dissenso. Più in generale, lo scetticismo liberale non va d’accordo con l’onniscienza divina, né l’ironia liberale con l’onnipotenza divina. Né può esistere una versione del razzismo che sia liberale -e lo stesso vale per l’antisemitismo, l’islamofobia, la misoginia e l’omofobia. Il fanatismo e l’odio non hanno declinazioni liberali. Di contro, ci sono stati democratici razzisti e socialisti antisemiti. Tanto che uno dei leader della socialdemocrazia tedesca, August Bebel, nel 1893 definì l’antigiudaismo come il “socialismo degli imbecilli”. Possono esserci anticomunisti liberali, ma durante la Guerra fredda ci fu un anticomunismo viscerale, rappresentato dal senatore John McCarthy, e alcuni intellettuali liberali esitarono a condannarlo. Mentre gli intellettuali liberali non dovrebbero avere alcuna esitazione a dire non soltanto la verità al potere, ma sempre e soltanto la verità.
* Il Foglio