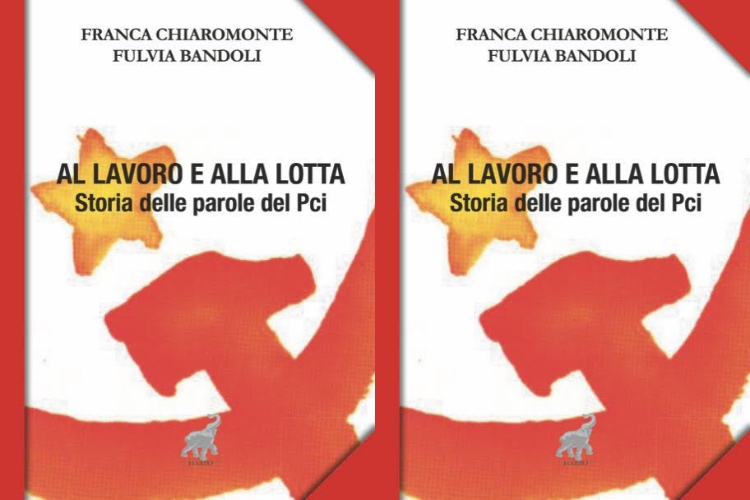Una pioggia di pamphlet, saggi, memoriali, articoli, convegni: non si può certo dire che il centenario della nascita del Pci (Livorno, 21 gennaio 1921) sia passato inosservato. Del resto, il partito di Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti è stato, nel bene e nel male, un protagonista del “secolo breve” italiano. E la sua storia ancora oggi divide e fa discutere. C’è chi la rimpiange, magari non avendola neppure conosciuta. Chi candidamente la ignora. E c’è chi le imputa errori fatali e vizi imperdonabili: la rottura con i socialisti, un congenito settarismo, la sindrome scissionista, il mito della Rivoluzione d’Ottobre, il mancato approdo alla socialdemocrazia europea.
Questo repertorio di mezze verità e di luoghi comuni è tornato alla ribalta nelle pubblicazioni e nei dibattiti che hanno accompagnato la celebrazione del centenario. Se ne discosta felicemente un libro di Fulvia Bandoli e di Franca Chiaromonte, “Al lavoro e alla lotta. Storia delle parole del Pci”. Stampato nel 2017 da Harpo Editore, la prossima settimana sarà disponibile in una versione ebook aggiornata e ampliata. Se ne discosta perché è stato concepito “sine ira et studio”, senza stucchevoli intenti pedagogici e senza tesi precostituite, non per tifare ma per capire. Le due autrici, la prima ingraiana e la seconda amendoliana, sono riuscite così a confezionare un piccolo capolavoro della memoria, il cui esergo a buon diritto potrebbe recitare il celebre motto di Spinoza: “…Humanas actiones non ridere, non lugere, neque detestari sed intelligere” (Non irridere, non compiangere, non disprezzare ma comprendere le azioni umane).
“Al lavoro e alla lotta” non è, insomma, un “Amarcord” nostalgico, per citare un memorabile film di Federico Fellini. Del resto, quando parliamo di nostalgia bisogna intendersi bene. Il termine nasce come neologismo medico in Svizzera alla fine del Seicento. Parente stretto della malinconia, era il malessere degli sradicati, dei soldati mercenari lontani dalla propria terra. Solo più tardi diventa senso della perdita del passato, il pathos degli esuli che anima i nazionalismi ottocenteschi. Ecco, non credo che Chiaromonte e Bandoli si sentano esuli in patria, e di sicuro non sono nazionaliste. Come non credo che il loro libro nasca da un rimpianto per il passato, ma da un disagio per il presente, per la condizione sconfortante in cui versa una sinistra che somiglia a una nave con marinai indisciplinati e priva di bussola, di un portolano aggiornato, di nocchieri esperti.
Qui è forse lecito rimpiangere uno dei tratti distintivi del Pci. Quando la “linea” (una delle parole chiave del libro) veniva decisa, non era messa ogni giorno in discussione. Con alti e bassi, con svolte improvvise o con aggiustamenti graduali, restava la percezione di un partito affidabile e attento all’interesse generale del paese, anche se sul piano ideologico persisteva l’utopia di un cambio di sistema. Quando invece l’opportunismo invade la scena e viene spacciato per realpolitik, i mezzi diventano fini e i fini diventano mezzi. E quando contano solo le convenienze elettorali del momento, si possono tranquillamente recitare due parti in commedia: quella di antagonista del populismo e quella di concorrente del populismo sul suo stesso terreno.
“Il Pci — ha scritto Emanuele Macaluso — fece politica, azione sociale concreta e la fecero anche i suoi funzionari. Chi con intelligenza, ironia e rigore, chi con stupidità, settarismo e pignoleria, chi con religiosità e chi laicamente. A volte quel partito seppe spingere avanti la ruota della storia e lo sviluppo del paese, a volte li frenò; ma fu parte di una vicenda nazionale, non di una chiesa separata con un dio chiamato comunismo”.
Un giudizio nel quale mi riconosco, e credo che Bandoli e Chiaromonte non farebbero fatica a condividerlo. Infatti, proprio con intelligenza, ironia e rigore raccontano le parole con cui il Pci ha saputo parlare alle classi popolari, coinvolgendole in un’esperienza democratica che ha contribuito a costruire il nostro edificio costituzionale. Parole che sono ordinate in un originale vocabolario di circa centonovanta voci, redatte con un linguaggio asciutto e con onestà intellettuale. Non è poco, anzi è molto. Perché le parole talvolta non sono solo pietre. Sono armi di confusione di massa, di sproloqui e soprattutto di vaniloqui, che non trasmettono significati chiari e universalmente percepibili. Anche per questo è un libro prezioso. Perché restituisce al “lessico famigliare” del Pci, per così dire, la sua perduta autenticità:
“blocco storico” (oggi senza storia), “battaglia delle idee” (oggi senza idee), “Comitato centrale” (oggi il capo), “conflitto” (oggi il tweetstorm), “dissenso e il consenso” (oggi il silenzio-assenso), “l’alternativa” (oggi un mistero), “ceti medi” (oggi non riflessivi), “cretinismo parlamentare” (oggi il demenzialismo), “partito nuovo” (oggi non c’è neanche il vecchio), “discorso politico” (oggi il tweet), “forme di lotta” (oggi quelle di resa), “guerra di posizione” (oggi non c’è alcuna posizione), “intellettuale organico” (oggi trasformista disorganico), “donne comuniste” (oggi donne quasi mai al comando), “classe operaia” (ieri in paradiso oggi all’inferno), “scuola di partito” (oggi né scuola né partito), “ora X” (oggi X-Factor), “compagno di strada” (oggi di carriera), “lavoro” (oggi per se stessi e gli amici), “servizio d’ordine” (oggi di disordine), “meridionalismo” (oggi defunto), “popolo” (oggi i followers), “scissione” (quella è rimasta), “teoria e la prassi” (oggi dire una cosa e farne un’altra), “regioni rosse” (oggi sempre meno rosse), “socialdemocrazia” (oggi social e basta), “verbalizzare” (oggi post su Facebook) [il copyright dell’arguto controcanto è di Mario Sechi].
Sono solo alcuni esempi di un dizionario dimenticato in qualche angolo polveroso della tua biblioteca. Ma che, quando lo sfogli nuovamente, schiocca come una frusta sui tuoi ricordi. Come è capitato a chi scrive quando si è imbattuto nella voce “Capitalismo straccione”. Ad essa, infatti, è legato il mio primo incontro con il mondo comunista, che risale al marzo 1962. Ero stato invitato di straforo a un convegno dell’Istituto Gramsci sulle tendenze del capitalismo italiano, rimasto negli annali di Botteghe Oscure. Eravamo in pieno miracolo economico. Amintore Fanfani presiedeva il primo dicastero di centro-sinistra (allora aveva il trattino) con l’appoggio esterno del Psi. Un nuovo ciclo di lotte sindacali bussava alle porte. La compattezza della vulgata marxista cominciava ad incrinarsi, interrogata da correnti di pensiero che non vi avevano mai avuto cittadinanza (l’esistenzialismo, i francofortesi, la psicoanalisi). In questo contesto era maturata l’esigenza di una rinnovata riflessione sui principi teorici, le strategie politiche, le strutture organizzative e gli stessi referenti sociali (in primis, il proletariato industriale e agricolo) su cui il Pci aveva fondato il proprio radicamento nel primo quindicennio repubblicano. Di tale esigenza fu appunto espressione il convegno del Gramsci, segnato da un duro scontro tra Giorgio Amendola e Bruno Trentin.
Ora, si provi a immaginare lo stupore di un ragazzo, quale io ero allora, di fronte alla relazione del pupillo di Di Vittorio, che spaziava da Keynes a Schumpeter, dalla Scuola delle relazioni industriali del Wisconsin ai pianificatori francesi; e di fronte a un’analisi del capitalismo domestico in cui campeggiavano termini quali alienazione, consumismo, società opulenta, ancora stranieri nella pubblicistica di partito. Per me, che avevo appena iniziato a masticare l’abc del marxismo-leninismo, fu una specie di scoperta dell’America.
Per la cronaca, la tesi di Trentin — come di Vittorio Foa e Pietro Ingrao — era che le forze più dinamiche della Dc avevano un progetto di modernizzazione economica e sociale del paese, basato su un patto neocorporativo tra grandi imprese e movimento sindacale, con cui bisognava confrontarsi. Amendola la liquidò seccamente, ritenendola avveniristica.Il compito del movimento operaio, fu la sua replica, era quello di supplire alle carenze di una borghesia assenteista, responsabile della storica arretratezza del Mezzogiorno, e quindi di tagliare le unghie alla rendita e ai monopoli. Dopo quasi sessant’anni, si può dire che Amendola non aveva torto quando sosteneva che, per vincere quella battaglia, era necessaria la riunificazione della sinistra in una prospettiva di governo. Ma Trentin aveva ragione quando sosteneva che il miracolo economico non poteva più essere interpretato con le tradizionali categorie dell’extraprofitto parassitario e del supersfruttamento operaio: cardini di un “capitalismo straccione”, appunto, ormai sulla via del tramonto.
Infine, un telegramma sulle interviste a un gruppo di personalità del Pci, o che hanno dialogato col Pci, in appendice al libro (tra le altre, Achille Occhetto, Aldo Tortorella, Emanuele Macaluso, Gianni Cuperlo, Luigi Covatta, Mario Tronti, Luciana Castellina, Livia Turco, Marisa Rodano, Maria Luisa Boccia, Letizia Paolozzi). Sono un interessante e significativo ritratto delle letture, delle passioni letterarie e degli ideali che hanno animato l’impegno di generazioni diverse e dalle culture politiche diverse, ma unite da un forte tensione etica (sia della convinzione che della responsabilità). Curiosamente, ma non per caso, quasi tutte dichiarano di non avere attualmente alcun partito di riferimento. “A loro — chiosano Chiaromonte e Bandoli — ci aggiungiamo noi, che continuiamo ad amare la politica ma non troviamo luoghi confortevoli dove farla con altre e altri”. Se me lo permettono, mi aggiungo anch’io.