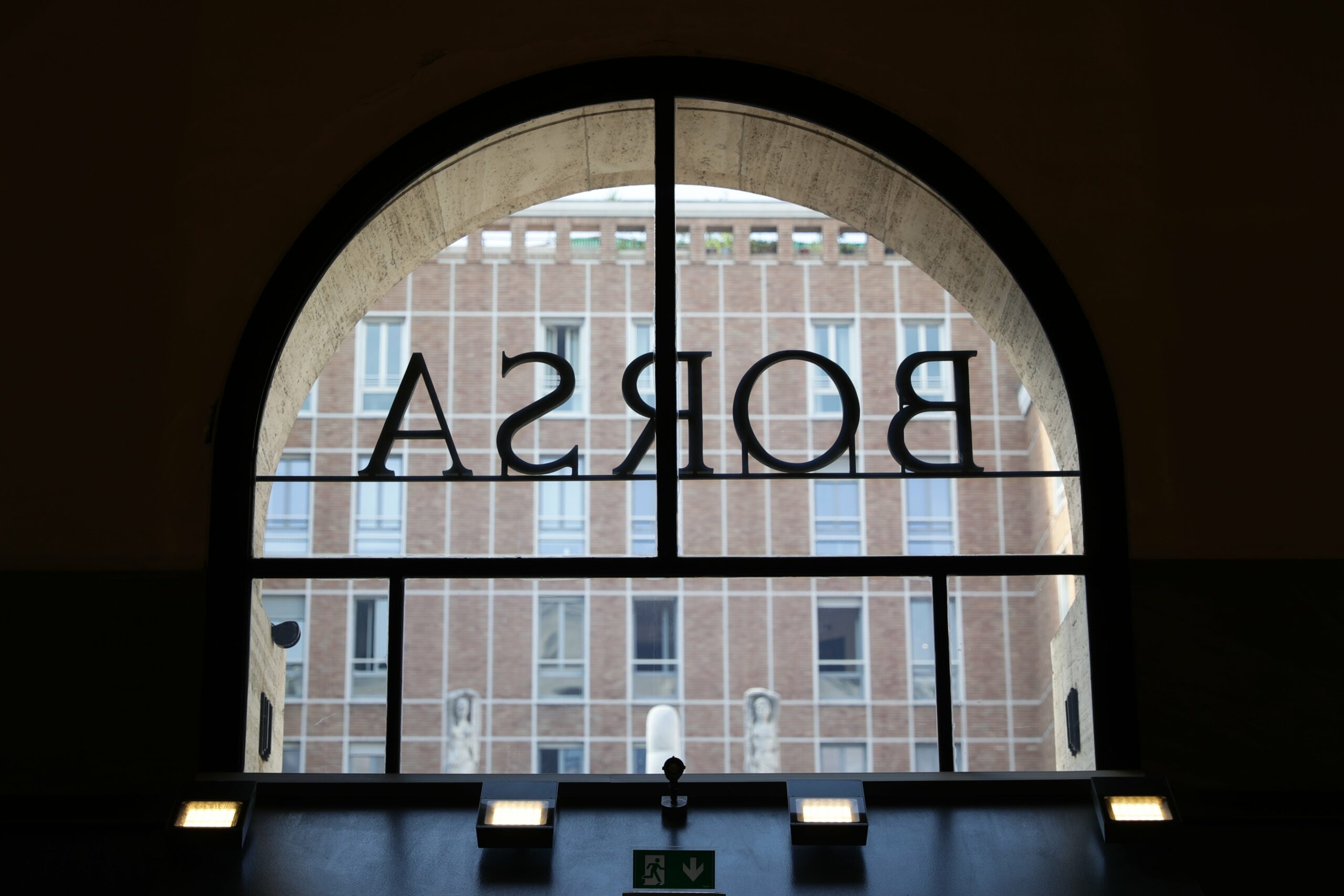Combattere e stravincere la guerra delle parole, non potendo competere nelle guerre dei fatti. Per esempio in politica con i voti (sempre che si possano considerare fatti), oppure in economia, dove pare bastino alcune decisioni a livello globale, come la riduzione dei tassi da parte delle banche centrali europea e americana, per produrre un incontenibile effetto depressivo sull’andamento della produzione e della ricchezza. È un po’ questa la chiave della comunicazione che potremmo definire politicamente corretta o woke, che si esprime da un lato nella cancel culture, nella richiesta cioè di censurare, emendare, condannare, cassare ciò che si ritiene scomodo, e dall’altro nell’insufflare neologismi e modalità retoriche sempre nuove.
Ce ne accorgiamo scorrendo la cronaca nei titoli dei telegiornali, sui quotidiani o sui siti. Vi troviamo intanto un’imposizione estrema dell’agenda setting, cioè una selezione di argomenti e fatti che ne esalta alcuni di indimostrata rilevanza (si prenda l’aneddoto latore del neologismo ecoansia), oscurandone altri che parrebbero invece meritori, e poi una rappresentazione dei temi prescelti che risponde a curiose regole stilistiche. Si veda l’omicidio di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla che, dal nome e dai tratti somatici, appare chiaramente straniero. Ma che il Corriere della Sera, nel suo strillo di prima pagina, indica senza mai dire esplicitamente che fosse egiziano come i suoi assassini: o, per meglio dire, lo lascia dedurre, scrivendo che “voleva aiutare la famiglia in Egitto” e che “lavorava con un connazionale” che lo ha ucciso.
Il Messaggero è un quotidiano più popolare e quindi attento alla cronaca. Riportando di questo delitto in un minuscolo box, scrive esplicitamente che i due assassini sono “connazionali” del “diciannovenne egiziano”, squarciando poi il velo su alcuni cenni della macabra cronaca. Il quotidiano romano dà maggiore rilievo al seguito di una notizia del giorno precedente, la morte di Sofia Castelli uccisa dall’ex fidanzato, della cui nazionalità e origine non sappiamo però nulla. Si tratta di Zakaria Atqaoui, del quale bisogna addentrarsi nella lettura per scoprire che è marocchino, mentre il search del nome su Google ci rende immediatamente e regolarmente noto che è 23enne. Curioso come l’insistenza sull’aspetto anagrafico contrasti con questa vaghezza sulle origini.
Repubblica, molto semplicemente, ignora entrambe le notizie mentre sulla Stampa, a proposito di femminicidi, si auspica che “i media parlino ogni giorno della violenza sulle donne”, cosa che peraltro fanno: non per sensibilità editoriale, purtroppo, ma perché lo impone l’attualità. Commento a parte, però, dei due fatti non si trova nessuna notizia che parta in prima: curioso anche questo, si dovrà convenire. Se invece si passa ai quotidiani di centrodestra – anche qui, ai pochi che decidono di dare conto dei due omicidi – si segnala la Verità con un titolo in cui la provenienza straniera degli assassini viene enfatizzata: “Due egiziani tagliano la testa e le mani a un uomo, un altro picchia una ragazza a Milano”. La nazionalità, cioè, diventa un elemento del contendere, un segno di riconoscimento, di stigma.
Lo scenario è davvero avvilente. Prima di tutto per la sottovalutazione di notizie così rilevanti, ridotte a minuscoli richiami in prima dai quotidiani che decidono di darne conto (privilegiamo questa tipologia mediatica per comodità, nonostante la sua irrilevanza dal punto di vista della diffusione). Ma è triste anche la modalità linguistica. L’appartenenza culturale e ideologica contrapposta fa sì che chi ritiene che l’immigrazione in Italia sia eccessiva evidenzi questo dato biografico, oscurato al contrario dai fautori della società multiculturale con una pruderie sospetta. Da un lato la Verità, che già il 30 luglio titolava “Marocchino sgozza l’ex fidanzata, albanese massacra la vicina”, con un’enfasi che evidentemente rappresenta la replica alla modalità inutilmente ipocrita con la quale, se l’autore di un crimine è straniero o italiano di seconda generazione, questo dato va taciuto. Una sorta di coda di paglia, quasi che parlando di violenza commessa da magrebini, africani in genere, asiatici o sudamericani si temesse di aprire al dubbio su una connaturata tendenza di queste culture al disprezzo per le donne oppure all’associazione a fini criminosi. Che si possa incentivare il pregiudizio che un tempo soprattutto legava ai napoletani furto e contrabbando, ai siciliani il delitto d’onore, ai terroni in genere i comportamenti illeciti.
Questa censura rientra oggi in un quadro culturale per cui qualunque elemento dell’identità della persona va sottaciuto. In qualche modo è questa la cifra della nostra società, che Bauman suggeriva di definire liquida e che adesso preferiamo chiamare fluida, pertanto – si sia italiani o stranieri, maschi o femmine, normodotati o disabili – dobbiamo essere descritti nel modo più asettico e impersonale possibile. Ad onta della completa descrizione che un tempo si predicava dal punto di vista informativo come regola delle “5 W”. E sempre fatta eccezione per l’età, che compare quale primo connotato dopo nome e cognome.
Montale scriveva non a torto che: “Codesto solo oggi possiamo dirti, / ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”. Si potrebbe quindi risolvere la diatriba procedendo per negazione e scrivendo che un “non italiano” o “diversamente italiano” è stato ucciso, ha ucciso qualcuno o è stato coinvolto in un qualunque altro fatto rilevante come protagonista, attore o vittima.