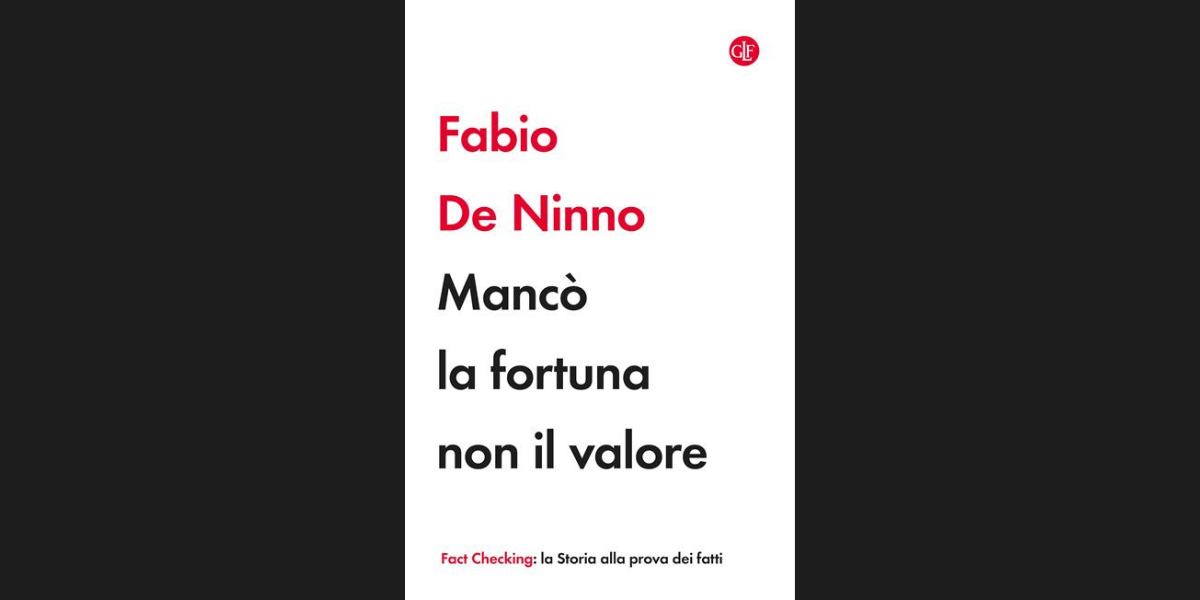Propongo ai lettori due capitoli della voce “Antisemitismo e antigiudaismo” redatta da Anna Foa, docente emerito di Storia moderna all’Università La Sapienza di Roma. Treccani, VII appendice.
Antisemitismo politico e antisemitismo razzista
Nella seconda metà dell’Ottocento l’idea, nuova nella cultura europea, che l’umanità fosse distinta in razze e che queste fossero suddivise tra razze dominanti, superiori (sostanzialmente quella bianca) e razze inferiori, destinate a essere dominate e guidate, divenne un’idea egemone, facilitata dall’avanzata del colonialismo e resa vincente dall’affermarsi della nuova cultura scientifica. Molti e anche contrastanti furono in realtà gli apporti alla nuova cultura razzista: in primo luogo quelli delle scienze, in particolare l’antropologia e l’eugenetica, che trovarono un punto di riferimento nel darwinismo sociale e nella sua enfasi sull’ereditarietà e la sopravvivenza del più forte, ma anche il diffuso spiritualismo divulgato in tutta Europa dalla Società Teosofica di Madame H.P. Blavatsky, con la sua esaltazione delle religioni indiane.
Nasceva il mito ariano, che vedeva negli ariani popoli del Nord i portatori di creatività e forza vitale, e negli ebrei una razza inferiore, degenerata (Léon Poliakov, “Il mito ariano”, Rizzoli, 1976). A operare la saldatura definitiva tra le prime teorie razziali e l’antisemitismo furono, verso la fine del XIX secolo, i circoli pangermanisti tedeschi, in particolare il circolo wagneriano di Bayreuth, dove operò H.S. Chamberlain (G. L. Mosse, “Il razzismo in Europa dalle origini all’Olocausto”, Laterza, 1980) il maggior teorico di queste dottrine. Meno stretta fu la connessione tra antisemitismo e razzismo in Francia, in cui l’antisemitismo, a parte il gruppo pur influente dei darwinisti sociali, restò fortemente caratterizzato in senso religioso, e quindi estraneo all’ideologia razzista. Il nuovo razzismo era infatti figlio della moderna cultura scientifica, che la Chiesa guardava con sospetto e con ostilità.
L’immutabilità dei confini tra le razze, che presto divenne uno dei suoi dogmi più importanti, era quanto di più lontano ci potesse essere dalla concezione cristiana dell’uguaglianza di tutti gli uomini e della possibilità per tutti di convertirsi al cristianesimo. Ma al pari delle forme di odio antiebraico che lo hanno preceduto, l’antisemitismo razzista era una formazione complessa, in cui trovarono posto, sia pur snaturate ed estremizzate, molte delle tradizionali formulazioni antigiudaiche -in primis la denuncia del potere degli ebrei- e in cui si ripetevano molte delle antiche accuse medioevali. Gli ebrei avvelenatori del Medioevo diventano ora portatori di tare nascoste e contagiose, sifilitici per usare una metafora utilizzata da Hitler a designare lo stesso ebraismo, considerato come la tabe per eccellenza dell’umanità. Quella che si diffonde, tra l’Ottocento e il Novecento, è un’immagine radicalmente negativa dell’ebreo: razzialmente diverso, intento a minare dall’interno la società ariana, a contaminarla.
Il miscuglio era nuovo ed esplosivo, ma non conteneva necessariamente in sé i germi di Auschwitz. Perché si concretizzasse nello sterminio degli ebrei d’Europa, non c’era solo bisogno dell’avvento al potere del nazismo in Germania e della guerra, ma c’era un passo ulteriore da fare, cioè l’inserzione della teoria razzista in un progetto di ordine nuovo mondiale dominato dalla cosiddetta razza ariana, i tedeschi e i popoli del Nord, in cui alcuni popoli (ebrei, zingari in primis) erano destinati inizialmente all’estinzione (attraverso politiche di eutanasia e di sterilizzazioni forzate) e poi allo sterminio nei campi, mentre altri (slavi, meridionali) erano destinati a essere ridotti in schiavitù.
[…]Antisionismo e antisemitismo
Mentre in Europa cresceva e prendeva sempre più forza la consapevolezza della Shoah e il dialogo ebraico-cristiano, una nuova forma di antisemitismo cominciava a diffondersi, l’antisionismo. Esso aveva origine nel mondo arabo, ed era legato direttamente a un conflitto di natura politica, quello tra i Paesi arabi e il nuovo Stato di Israele, fondato nel 1948. In Europa, esso cominciò a diffondersi soltanto nel 1967, dopo la guerra dei Sei giorni, che vide esacerbarsi il conflitto israelo-palestinese. Ma nei Paesi arabi l’antisionismo aveva radici che precedevano la nascita dello Stato di Israele e lo stesso inizio della lunga emigrazione ebraica, legati alla penetrazione, attraverso il colonialismo europeo, dell’antisemitismo occidentale e all’incontro di questi influssi con il declino dell’Impero ottomano e la disgregazione degli antichi equilibri tra le minoranze (cioè gli infedeli ebrei e cristiani) e la maggioranza musulmana. Per secoli questo equilibrio, fondato sulla sottomissione e sul pagamento di una tassa (dhimma), si era mantenuto e aveva consentito agli ebrei condizioni di vita più tranquille che nel mondo cristiano.
A partire dall’inizio dell’Ottocento, tuttavia, la penetrazione europea aveva alterato radicalmente l’antico sistema della dhimma, mentre gli influssi dell’antisemitismo europeo non mancarono, alla fine del secolo, di farsi sentire fra le minoranze cristiane, che l’influenza occidentale aveva sottratto al loro statuto di inferiorità. Nel 1840, fece la sua clamorosa comparsa a Damasco l’accusa di omicidio rituale: la presunta vittima era un frate cappuccino, accusato fu l’intero gruppo di notabili della Comunità ebraica, mentre il console francese soffiava sul fuoco e l’Inghilterra si schierava in difesa degli ebrei. Nelle terre ottomane, frequenti e ricorrenti furono da allora in poi, nel corso del XIX secolo, simili accuse. Alla fine del secolo, numerosissime furono le traduzioni arabe della letteratura antidreyfusarda, mentre la prima edizione araba dei Protocolli apparve al Cairo nel 1927. La fusione nel mondo arabo dell’antisemitismo europeo con l’antico disprezzo islamico per la minoranza ebraica si realizzava così nel momento stesso in cui nasceva la questione sionista, e si intrecciava con questo problema, che era di per sé un problema politico.
L’antisionismo non ha infatti, da un punto di vista teorico, nulla a che vedere con l’antisemitismo, e ha rappresentato originariamente l’opposizione al progetto sionista di costituzione di uno Stato ebraico in Palestina. Essenzialmente politica fu, per es., la durissima opposizione al sionismo condotta dal governo ottomano, anche se non mancarono voci inclini a far propri gli stereotipi dell’antisemitismo europeo. Ma negli anni Trenta e Quaranta, mentre si intensificava l’emigrazione ebraica in Palestina e si accentuava lo scontro tra arabi ed ebrei, ampia fu la diffusione della propaganda antisemita nazista sui movimenti nazionalisti arabi. Vicinissimo a Hitler fu, com’è noto, Amin al Hussein, Gran Muftì di Gerusalemme, convinto antisionista e ancor più convinto antisemita. Questa mescolanza divenne esplosiva dopo la fondazione dello Stato di Israele, nel 1948, e il nascere del conflitto israelo-palestinese, dando vita a una forma di violento antisemitismo, in cui la guerra contro lo Stato di Israele e il sionismo trovano la loro giustificazione ideologica nei più vieti stereotipi antiebraici, un processo che il fondamentalismo islamico e il terrorismo internazionale hanno ulteriormente potenziato.
Al suo centro, l’idea di un complotto sionista-occidentale contro i Paesi islamici e la negazione della Shoah, vista come un mito occidentale finalizzato a spossessare delle loro terre i palestinesi a favore degli ebrei. In un contesto europeo in cui, dopo la Shoah, l’antisemitismo tradizionale era diventato tabù, questa ideologia di antisemitismo e terzomondismo si è diffusa nella parte più radicale della sinistra, legittimata dal sostegno alla causa palestinese. Tutto questo rende difficile distinguere l’antisionismo dall’antisemitismo e tracciare una linea netta di confine tra l’opposizione alla politica dello Stato di Israele e questo antisemitismo che è alla base di fenomeni nuovi, quali la lotta contro l’Occidente dei fondamentalisti islamici e l’ostilità antiebraica sempre più diffusa fra gli immigrati arabi in Occidente.
*InOltre, 19 aprile 2024