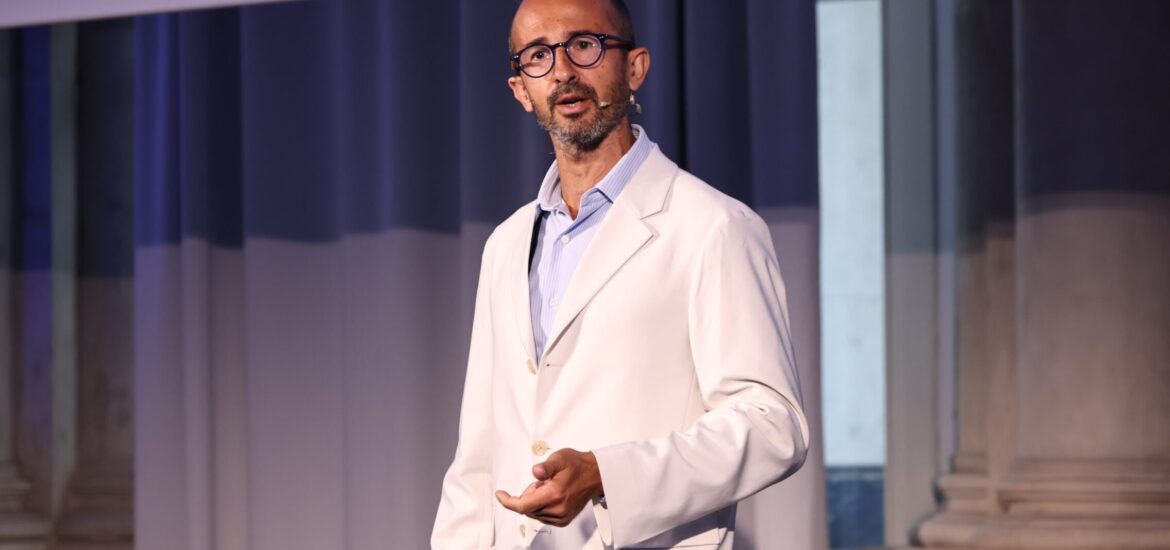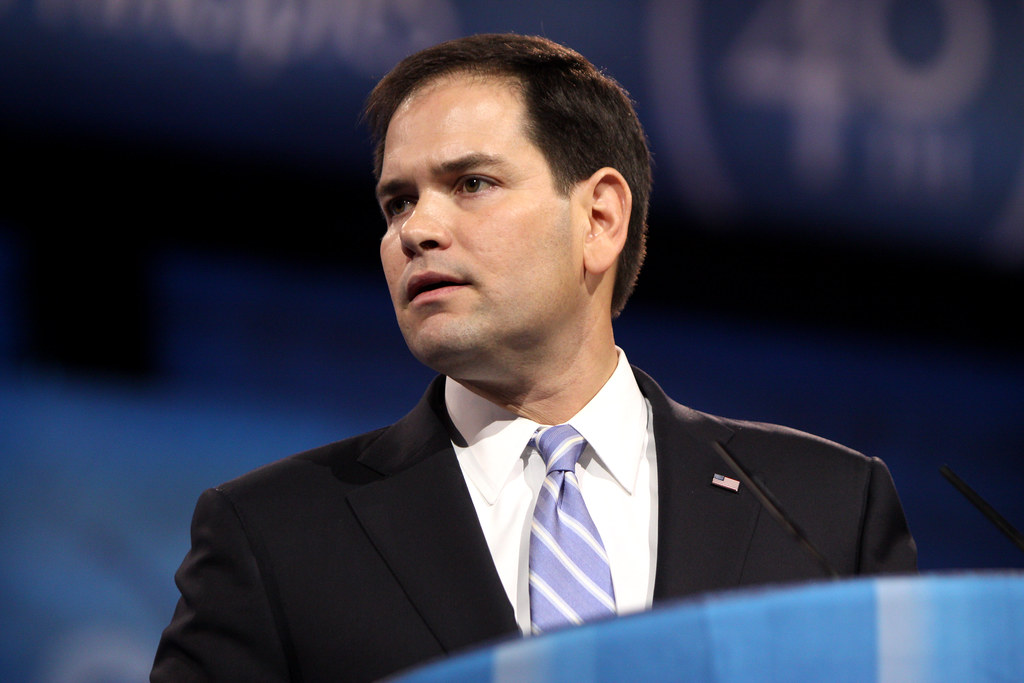Negli ultimi anni l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno attinto molto al manuale economico della Cina, specialmente per quanto riguarda l’instradamento della transizione energetica, ma non solo. Gli esempi di protezionismo e di intervento statale sono numerosi: l’ultimo, e forse il più eclatante, è l’ingresso del governo americano nel capitale di Intel. Nel libro scrivi che in America «il vincolo del mercato sulla base della sicurezza nazionale cresce sempre di più, fino a quando l’arma della sicurezza nazionale si confonde con l’arma economica». È un “approccio” destinato a durare a lungo, secondo te?
Noi viviamo nell’epoca del capitalismo politico. È un aspetto che ho sviluppato nel dettaglio nei miei articoli degli ultimi dieci anni e nei miei libri degli ultimi cinque anni.
In un mondo più contestato, soprattutto per via dell’ascesa economica e manifatturiera cinese, l’equilibrio tra Stato e mercato è alterato dall’allargamento della sicurezza nazionale. Questo toglie di mezzo alcune ipocrisie. Certo, negli Stati Uniti l’investimento diretto del governo federale nelle imprese è stato raro, ma il cosiddetto Washington Consensus valeva soprattutto per gli altri e in diverse occasioni sono stati utilizzati strumenti di guerra economica come dazi, sanzioni, controlli sugli investimenti esteri, controlli sulle esportazioni, organizzazione degli appalti per favorire le imprese nazionali e altre politiche industriali.
Si può facilmente notare un’escalation di questi strumenti degli ultimi dieci anni. Del resto, siamo nel 2025, l’anno designato dal piano Made in China 2025, ed era prevedibile che ci sarebbero stati questi cambiamenti, che sono in linea con la mia visione del “capitalismo politico”. Quindi non era proprio tecnicamente possibile rimanere in uno scenario dove ascoltiamo Margrethe Vestager che fa il discorso sulla visione luterana della concorrenza (cosa realmente accaduta nel 2016) e la si prende sul serio.
Sul fatto che questi elementi resteranno o meno negli Stati Uniti, è un tema che intendo approfondire ulteriormente in altri libri che sto scrivendo ora sullo Stato e il “Deep State”, ma comunque c’è un consenso di fondo da parte della “sinistra” statunitense, pur con alcune differenze.
Nei nostri sistemi, se la sicurezza economica è sicurezza nazionale, la conseguenza logica, portata alle estreme conseguenze, è: tutto, o quasi, diventa sicurezza nazionale. Quest’ipertrofia rischia di diventare una frenesia che divora ogni cosa. Senza criterio. Perché poi però per conseguenza della totalizzazione della sicurezza nazionale, da un lato non ci sono (né in sostanza ci possono essere, per essere pratici) gli apparati statali per gestire tutto in quanto sicurezza nazionale, dall’altro lato non hai più i giocattoli sugli scaffali a Natale. Perciò c’è e ci sarà sempre un pendolo, un tentativo di equilibrio tra i mercati e la sicurezza nazionale, un processo di contrattazione. Solo che il punto di equilibrio si colloca diversamente rispetto a quanto si poteva pensare qualche tempo fa.
E la Cina che fa, invece?
La Cina persegue la sua strada, in cui nel “socialismo con caratteristiche cinesi” c’è un po’ di tutto, un vasto sistema di partecipazioni statali centrali e locali, il controllo finanziario, ma anche una competizione fortissima. Il limite comunque è: il capitale non può comandare, il denaro non può comandare. Da ultimo, deve comandare il Partito.
La politica industriale della Cina, che poggia su un’ampia base di scienziati e lavoratori qualificati, ha permesso al paese di trionfare in tanti settori tecnologicamente avanzati. Ma questo approccio dirigistico ha anche dei costi: Pechino spende parecchio per i sussidi alle industrie, ad esempio, e diversi settori – dai dispositivi solari alle auto elettriche – sono sovraffollati e interessati da “guerre dei prezzi”. Ad oggi, inoltre, nonostante gli sforzi, la Cina non è riuscita a raggiungere traguardi significativi nella manifattura avanzata di microchip: senza questi componenti, l’intelligenza artificiale non potrà evolvere. La Cina ha davvero già vinto?
Bisogna considerare vari aspetti.
In primo luogo, la capacità tecnologica cinese non è solo politica industriale o sussidi, perché concentrarsi solo su questo sarebbe sottovalutare la capacità delle loro aziende, dei loro imprenditori, dei loro lavoratori. Sarebbe ormai un errore grossolano. Questa crescita di capacità è avvenuta in uno specifico momento storico, quello dell’entrata in un relativo benessere di centinaia di milioni di persone e dell’ampiamento di un mercato interconnesso, e capace di condizionamento sul resto del mondo. Tale condizionamento avviene in parte in termini di consumo e soprattutto in termini di organizzazione di produzione, in particolare con la produzione elettronica e di smartphone e con le altre industrie collegate a questa filiera. La produzione di Apple in Cina, come mostrato anche in alcuni elementi del libro di Patrick McGee su questo tema, è stato un evento davvero epocale.
Poi c’è il tema che diceva qualche tempo fa Jamie Dimon (che rappresenta l’ambito in cui gli Stati Uniti sono senz’altro più forti, la finanza) di cui ho scritto anche su Startmag. In sintesi, il punto è che i cinesi hanno problemi, non hanno raggiunto ancora certe nicchie, ma in fondo “mettono 100.000 ingegneri al lavoro su un problema e capiranno che fare”. Anche Bill Dally, il chief scientist di NVIDIA tra i personaggi del mio Geopolitica dell’intelligenza artificiale, alla domanda precisa di un panel federale degli Stati Uniti “ma allora dicendo che ci vogliono i talenti cinesi stai dicendo che sono più bravi degli americani?” ha risposto in pratica “beh, lì ci sono più persone, e sempre più persone effettuano certi studi e si preparano in modo adeguato, quindi fate voi i vostri calcoli”.
Perciò si può dire al sistema cinese “non hai raggiunto questo componente”, “non hai raggiunto questa nicchia” ma allo stesso tempo devi riconoscere quest’enorme scala tecnica e ingegneristica di cui la Cina risponde, e le sue conseguenze in alcune altre filiere, come quella degli stessi chip. E la velocità con cui si presentano queste conseguenze e queste trasformazioni. A che serve a un europeo fare questo discorso di limiti della Cina, visto che nel mentre sui segmenti in cui agiscono aziende europee come Stm, Infineon, Nxp le imprese cinesi fanno passi avanti enormi? Visto che ASML (che con la sua filiera è una “perla” della capacità tecnologica europea) è comunque condizionata dal suo giro d’affari in Cina, trimestrale dopo trimestrale, mentre per via della storia delle acquisizioni di ASML che ho descritto nel mio libro Il dominio del XXI secolo (2022) c’è lo stesso anche il condizionamento degli Stati Uniti?
Pertanto, non è vero che il sistema cinese non possa produrre innovazione, anche perché ciò avviene in un contesto storico in cui “l’innovazione di scala” ha un ruolo essenziale. Certo, rimane essenziale – come scrivo – il tema delle scelte di quelle persone, dei milioni di persone che sono formate in Cina con competenze tecniche e scientifiche. Dove vogliono vivere i talenti del mondo? Se vogliono vivere negli Stati Uniti, se gli Stati Uniti rimangono ciò che sono stati, cioè il magnete principale dei talenti del mondo, compresi i cinesi, allora la Cina è più debole. Per questo le politiche sull’istruzione, la formazione, la ricerca sono così importanti. Come scrivo nel libro, sono tutti temi che non a caso catturano in modo molto profondo l’attenzione di Wang Huning nel suo viaggio del 1988.
Sull’intelligenza artificiale, infatti…
Prendiamo le statistiche, rese note anche da “Bloomberg”, sui brevetti dell’intelligenza artificiale generativa. Si guardano quei dati e ci sono quasi solo entità statunitensi e cinesi. La Zhejiang University è al secondo posto tra Google e Microsoft.
Una cosa interessante è che in quella classifica, con moltissimi brevetti, c’è State Grid, la società della rete elettrica cinese. State Grid dal 2014 ha anche una quota di CDP Reti, cioè rete gas e rete elettrica in Italia. Ipotizziamo che investitori istituzionali italiani, oppure privati italiani, per varie ragioni, ricomprino quella quota. Oppure, un po’ di italiani e un po’ di statunitensi. È un tema di cui si discute da tempo. La cosa davvero importante è sapere che nel mentre, qualunque cosa accada, in sintesi State Grid si è già presa gli utili di CDP Reti e ha investito nei brevetti dell’intelligenza artificiale generativa, oltre a fare altre migliaia di cose. L’acquisizione della tedesca Kuka da parte di Midea è ormai avvenuta circa dieci anni fa e nel mentre i passi avanti sull’intensità robotica cinese sono stati colossali.
La vittoria cinese è stata questa, poi il futuro come sempre nella vita è aperto ma bisogna conoscere il recente passato e i fattori essenziali che condizionano la posta in gioco.
In Europa ci siamo accorti tardi che la Cina non era più soltanto la “fabbrica del mondo”, ma una potenza dell’innovazione e un soggetto onnipresente in tante filiere critiche, dall’elettronica all’automotive alla cantieristica. Talmente presente che oggi la stessa Commissione europea promuove il trasferimento tecnologico dalle aziende cinesi a quelle europee, soprattutto nel settore delle batterie per i veicoli elettrici. Intanto, continuiamo a parlare di “approccio europeo all’intelligenza artificiale”. Ci mancano le basi per competere nelle nuove industrie e per attrarre talenti? Siamo destinati a essere subordinati ai cinesi?
L’approccio europeo è stato completamente sbagliato perché non fondato sul ruolo essenziale della produzione e su una conoscenza profonda delle supply chain. Se poi hai tante norme e tanti regolamenti, questo ti rende più debole e non più forte. E dobbiamo sempre ricordare che paragonare “l’Europa” a Stati Uniti, Cina, India, vuol dire paragonare le mele con le pere, perché sono chiaramente forme politiche differenti in termini di capacità di azione. Ma sono ormai cose note.
Non so se ci sarà il trasferimento tecnologico dalle aziende cinesi a quelle europee. Penso che ci saranno più resistenze, rispetto al passato, sui prodotti cinesi in Europa. Come scrivo a un certo punto, è chiaro che il mercato cinese – nonostante sia un mercato potente, ben diverso da quello dell’Unione Sovietica ovviamente! – non basta per la capacità produttiva cinese; pertanto, ci sarà sempre l’incentivo ad avere altri mercati di riferimento (anzitutto Sud-Est asiatico, ma anche Europa, Sud America, Africa) per sopperire alla conflittualità sul mercato statunitense. Questo è un tema che chiaramente esiste è che continuerà a porsi.
Ma il punto importante su cui prestare molta attenzione, dal punto di vista culturale e pratico, è che noi non possiamo reggere né il nostro benessere né la nostra sicurezza sull’Antico Vinaio. Continueremo ad avere storie di successo nel campo della ristorazione e di altri elementi che non riguardano la competizione industriale e tecnologica. Ciò creerà posti di lavoro, qualcuno vorrà sempre mangiare italiano, bere italiano, vestire italiano, vivere italiano, ma alla fine queste cose possono bastare per reggere? La risposta è: sicuramente no. Altrimenti noi diventiamo letteralmente la profezia che si auto-avvera della frase di Boris sulla ristorazione come unica cosa seria di questo Paese.
Su cosa dovremmo concentrarci, secondo te?
L’importante, per il futuro dell’Italia, è chi sarà il nuovo Giuseppe Crippa, il fondatore di Technoprobe. È non tanto se l’eredità di Del Vecchio porta a un cambio del cosiddetto “salotto buono,” ma è se questo processo porta all’emergere di realtà imprenditoriali paragonabili al gruppo di Del Vecchio. È quello che emergerà, se emergerà qualcosa di forte, dall’attenzione per la difesa e l’elettronica che caratterizza il nostro tempo. È in che modo la meccanica italiana saprà fare salti digitali. È il consolidamento del packaging, se ci sarà, ed essere anche predatori e non solo prede nell’ambito europeo, ma in un mercato più integrato. È la quota di Fincantieri nei nuovi sviluppi della cantieristica globale. È cosa faremo sui chip quantistici. È se invece di Industria 5.0, Transizione 5.0, o simili, avremo incentivi veloci ed efficaci. È se ci sarà in Italia una sorta di Technogym della robotica. E così via. Questi sono i temi importanti.
«L’America è sempre inquieta, e ha sempre bisogno di un nemico». «Quando credi che solo il tuo nemico ti definisca, senza il tuo nemico non sei più niente». Mi hanno colpito questi passaggi del tuo libro. Mi chiedo: è solo l’America a essere ossessionata dall’avversaria? La Cina non è mossa da una simile volontà di diventare la “numero uno”?
Direi di no perché le ossessioni della Cina sono diverse. Verso l’America, l’ossessione della burocrazia celeste cinese, incarnata da Wang Huning e dalla sua preveggenza, dal suo studio, è comprendere quali sono i punti di forza e di debolezza dell’avversario. L’ossessione sull’America della Cina ha a che fare, in questa fase, con lo sfaldamento del sistema degli Stati Uniti, non “essere il numero uno” ma, come scrivo, vedere il cadavere del numero uno che passa sul fiume e indicare agli altri quel cadavere. Inoltre, il sistema cinese non ha espresso nella storia la forma di colonialismo di alcune realtà europee e non ha nemmeno espresso un “impero nascosto” come quello degli Stati Uniti. Certo, c’è il sistema dei tributi e si può pensare, nel contesto contemporaneo, un sistema simile a quello dei tributi, una sorta di “colonialismo datore” à la Kojève rovesciato, per riprendere un aspetto che discutevo ne Le potenze del capitalismo politico (2020).
Questo per quanto riguarda l’esterno. L’ossessione della Cina è chiaramente interna: la tenuta del Partito, l’adattamento a sfide su cui c’è consapevolezza (l’invecchiamento della popolazione, il rapporto coi vicini) e su cui continueranno a essere compiuti errori. Solo che gli errori sono stati troppo spesso confusi con la sindrome del “collasso” cinese, solo che sono stati utilizzati argomenti troppo “statici” (come quelli classicamente “geopolitici”, se vogliamo utilizzare quest’aggettivo di cui nel libro non faccio alcun uso diretto, ma per esempio se ci riferiamo alle caratteristiche geografiche della Cina). Ciò ha reso e rende miopi rispetto ad altri aspetti, su cui la Cina ha continuato a sorprendere. Bisogna quindi saper conoscere i propri concorrenti, i propri avversari, e guardarsi dentro, evitando che la logica del nemico annebbi il ragionamento.