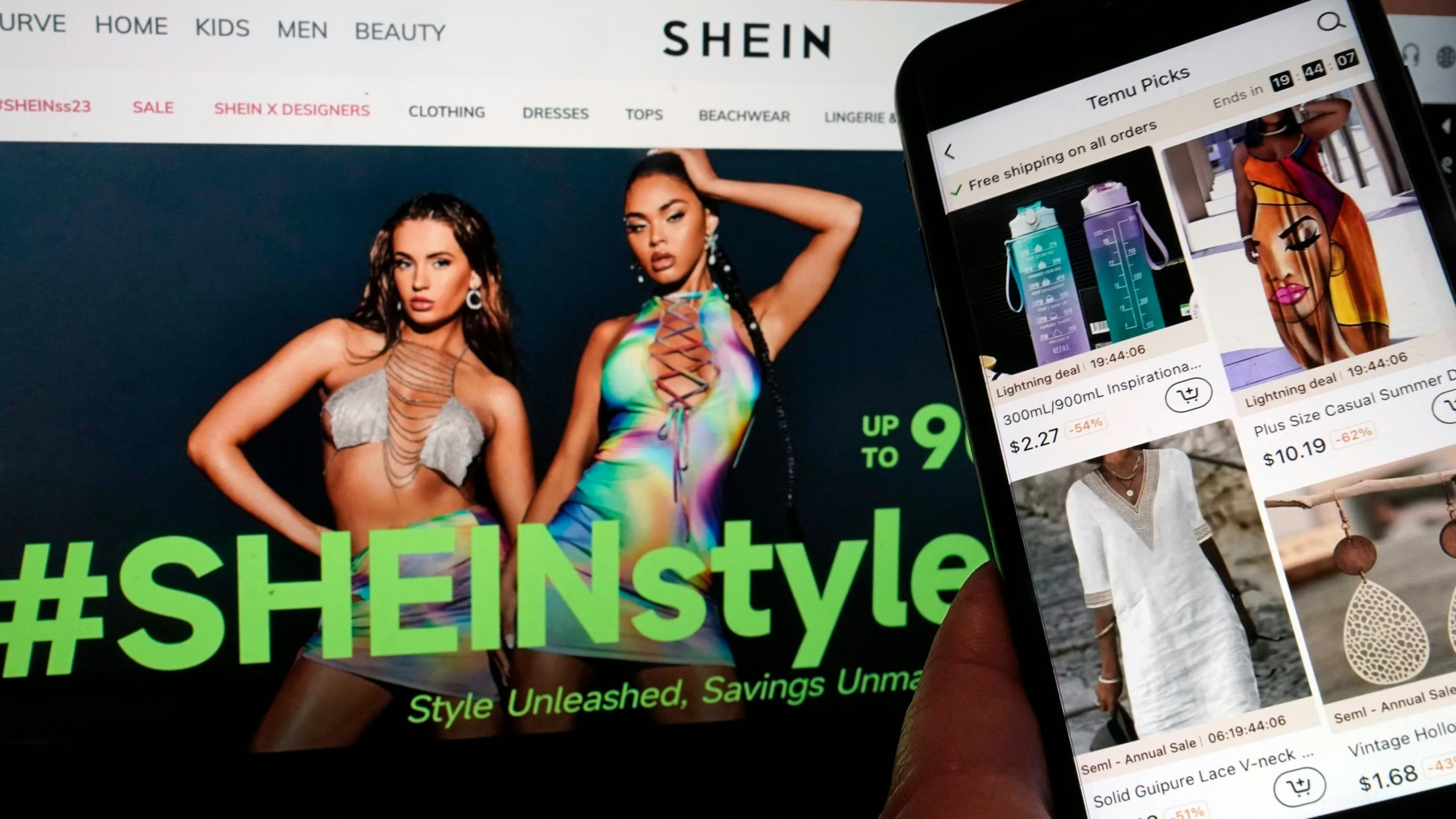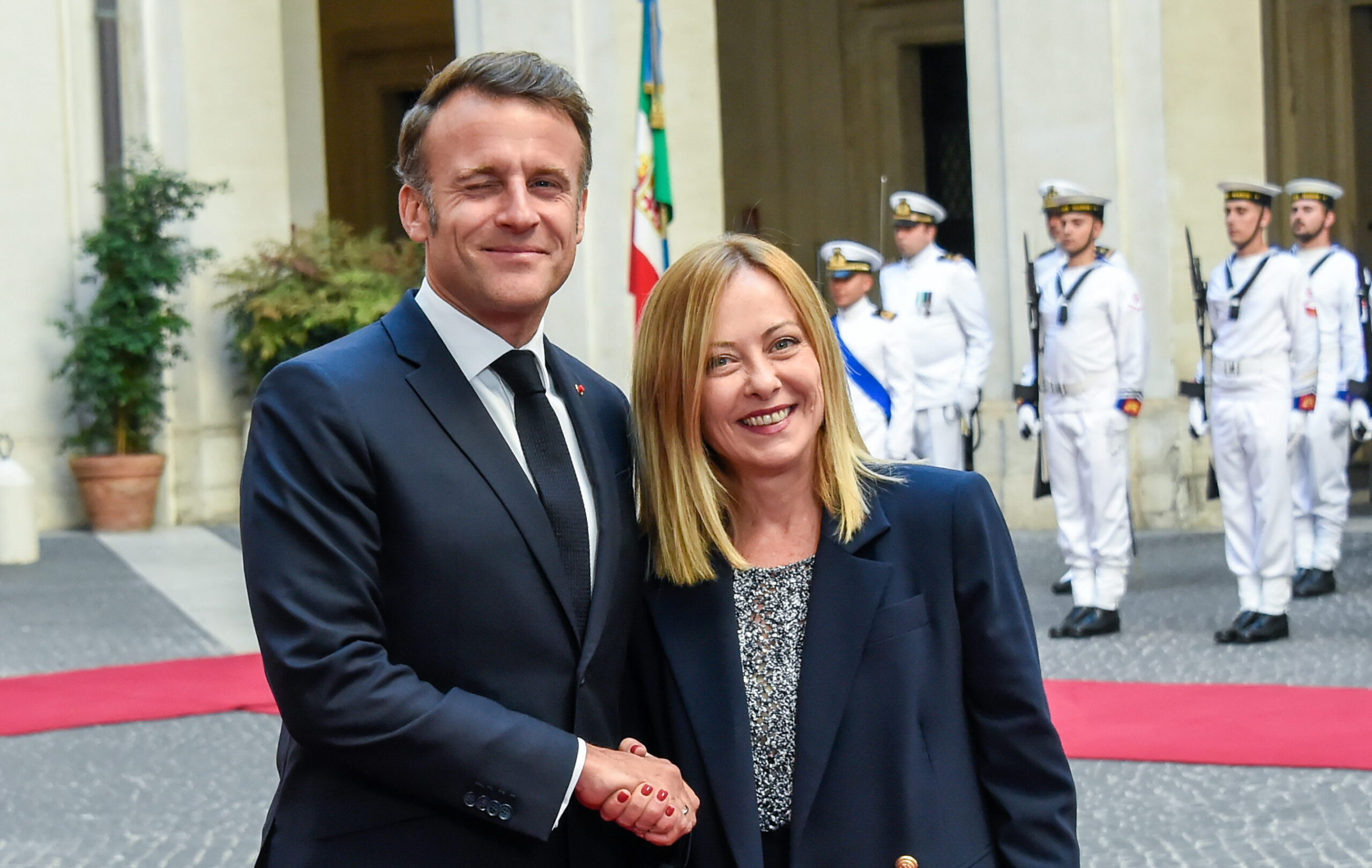Donald Trump sembra essere sempre più intenzionato a cambiare il volto della democrazia americana. Sul piano internazionale il piglio deciso (ma fino a quanto concludente?) ha sostituito la tessitura diplomatica. Tanti penultimati da un lato, nei confronti dei nemici storici dell’Occidente; e veri e propri diktat rispetto ai suoi antichi alleati. Ed ecco allora i dazi proibitivi contro il Canada (reo di aver manifestato la volontà di riconoscere lo Stato Palestinese) o contro il Brasile, per rispondere alla decisione dei giudici di quel Paese di aver disposto i domiciliari per l’ex Presidente Jair Bolsonaro, grande amico dell’inquilino della Casa Bianca.
Sul piano interno, nemmeno a parlarne. Il vecchio deep state, segno della continuità bipartisan della storia americana, è stato decapitato. I vecchi dirigenti di un tempo, selezionati dopo un lungo percorso professionale, sono stati sostituiti da improbabili personaggi, il cui unico merito è la fedeltà al capo. Chi resiste come Jerome Powell, posto dallo stesso Trump, seppure in epoca passata, alla testa della FED (Federal Reserve Bank), è oggetto di un continuo attacco personale. Per costringerlo ad adottare linee di politica monetaria più compiacenti. La stessa matematica è considerata un’opinione. E se i numeri non rispondono ai desiderati, la cosa più naturale è licenziare il capo del Bureau of Labor Statistics.
Nella lunga storia americana vi sono stati momenti altrettanti bui. Si pensi solo al maccartismo. Ma quel periodo, per quanto controverso, era almeno decifrabile. La “caccia alle streghe” era a senso unico. Colpiva i comunisti o i presunti tali. Forse con un accanimento eccessivo, ma comunque giustificato almeno in parte dagli avvenimenti di quel tempo: gli anni ‘50. L’inizio della “guerra fredda”, con i suoi punti caldi, come il conflitto coreano. La croce data addosso a tanti intellettuali innocenti, ma anche il caso di clamorosi casi di spionaggio, come nella vicenda che riguardò Julius ed Ethel Rosenberg. Ai giorni nostri, invece, conta solo la volubilità del Presidente, le sue continue giravolte, a volte figlie di ossessioni indecifrabili.
Nella letteratura più recente è difficile trovare elementi che in qualche modo giustifichino le pretese della Casa Bianca. Forse l’opera più organica è quella di Stephen Miran (A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System), deciso ammiratore di Donald Trump e da questi subito ricambiato con la nomina a chair of the Council of Economic Advisers. La necessità di utilizzare i dazi per far fronte alle difficoltà dell’economia e della società americana è tutta figlia del suo sacco. Come pure le giustificazioni che dovrebbero sostenerle.
Il dato di partenza è fornito dall’osservazione storica: il deficit sistematico della bilancia commerciale americana. Dagli anni ‘90 essa è stata in surplus o in pareggio solo tre volte. Nei successivi sette lustri è stata sempre in rosso, con squilibri che, in alcuni casi, avevano raggiunto l’8% del Pil. Come spiegarlo? Con il fatto che il dollaro è moneta di riserva. Di conseguenza la relativa gestione non può tener conto delle sole esigenze dell’economia americana. Ma dei più complessi equilibri internazionali. Per cui il valore del dollaro non risente solo degli andamenti della bilancia commerciale americana, legittimando, di conseguenza, politiche correttive. Ma riflette il peso di una domanda aggiuntiva originata dalle esigenze di riserva dei vai Paesi che, a loro volta, chiedono dollari o di titoli di Stato, come i Treasury.
L’eccesso di domanda di dollari è quindi sistemica. E ne determina una costante sopravvalutazione. Che, a sua volta, impedisce il riequilibrio della bilancia commerciale. Finché il peso dell’economia americana sulla realtà internazionale era debordante, il relativo costo era sopportabile. Ma con la crescita delle altre aree concorrenti (soprattutto Cina ed Europa) il relativo onere, legato a questa funzione, è divenuto insostenibile. Da qui la necessità di imporre dazi per riequilibrare la situazione, ripartendo almeno una parte dei costi generali, legati al finanziamento dell’economia mondiale, tra tutti i partecipanti. Analisi in parte corretta, ma troppo parziale.
Fosse così, sarebbe sufficiente per gli USA abbandonare quel ruolo, o meglio condividerlo con altri Stati. Proposta quest’ultima avanzata, fin dai tempi di Bretton Woods, da John Maynard Keynes, capo della delegazione inglese. Il “bancor” – questo il nome – era una semplice unità di conto governata dal sistema bancario. Un “tallone monetario” in grado di misurare il valore delle singole monete, al fine di calcolarne i mutevoli rapporti di cambio, con evidenti implicazioni sulle politiche da seguire in caso di eventuali scostamenti. Allora gli Stati Uniti, depositari della maggior parte dell’oro in circolazione, dissero di no. E da allora quella posizione non è mutata.
Negli anni successivi la proposta è stata ripresa sia a livello tecnico (Robert Mundell) che politico. Nel 2009 fu il governatore della Banca Popolare Cinese Zhou Xiaochuan a rilanciare il tema, con un discorso dal titolo “La riforma del sistema monetario internazionale”. Proponeva un uso massiccio dei DSF (Diritti speciali di prelievo), la quasi-moneta, gestiti direttamente dal FMI, che a sua volta condivideva lo spirito della proposta cinese (Reset e Accumulation and International Monetary Stability), sulla scorta di analoghe indicazioni dell’ONU. Tentativi partoriti sull’onda del GFC (Global Financial Crise) che, come detto più volte, ha rappresentato uno spartiacque, nella storia del Terzo Millennio, paragonabile all’impatto della grande crisi del ’29 sul secolo precedente.
Di fronte a queste possibilità, l’atteggiamento di Donald Trump è stato quello di una chiusura “senza se e senza ma”, al punto da mettere in imbarazzo il suo stesso ghostwriter. Stephen Miran è stato, infatti, costretto a riconoscere, seppure a denti stretti, che “eppure il Presidente Trump ha elogiato lo status di riserva del dollaro e ha minacciato di punire coloro che smettono di utilizzare il dollaro ai fini di riserva”. Segno evidente che gli Stati Uniti sono tutt’altro che dei samaritani. Come avrebbe voluto il suo economista principe. Dal momento che nel signoraggio del dollaro trovano quelle convenienze che i teorici di MEGA, sono costretti a minimizzare se non addirittura ad occultare.
Del resto l’arcano è facile da svelare. Nel corso degli anni il confronto tra gli USA e l’UE mostra una forte simmetria del ciclo economico, anche se nel corso degli anni ‘80 e ‘90 il ciclo americano era anticipato di un anno rispetto a quello europeo. La principale differenza consisteva, invece, nella forza della ripresa, dopo il punto di svolta negativa, negli USA sempre maggiore. A dimostrazione della maggiore resilienza di quell’economie, dovuta anche al signoraggio del dollaro. Diversità che, dopo la GFC del 2008, sono divenute abissali.
Nel 2009 la differenza di reddito pro capite tra le due sponde dell’Atlantico era pari a poco più di 13 mila dollari. Per crescere fino a 42 mila nel 2024. Fossimo a Le Mans saremmo ad una sorta di doppiaggio. Non si capiscono allora i fondamenti delle critiche delle nuove élite americane nei confronti dell’UE. Si può essere d’accordo sul fatto che la manna di una protezione militare quasi gratis debba finire. Ma accusare gli europei di essere solo degli scrocconi (come dicono all’unisono JD Vance e Trump), sulla scorta dei soli dati della bilancia commerciale, è una semplificazione ridicola. Che dimostra solo la pseudo giustificazione nel preferire il lato oscuro della forza. Il che, invece di rassicurare, dovrebbe solo preoccupare.