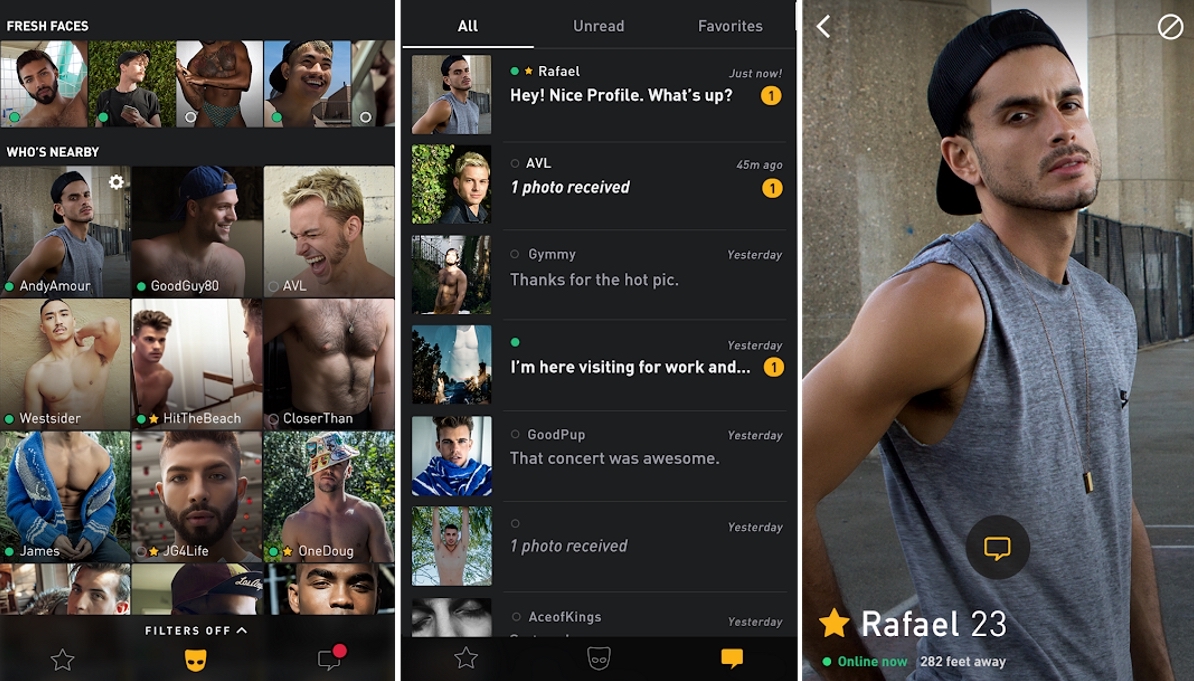Un tempo Seagram era la più grande compagnia di distillazione al mondo. Fondata nel 1857 a Waterloo, nell’Ontario, viene comprata nel 1928 dalla famiglia Bronfman. Grazie a una politica commerciale spregiudicata e approfittando della propria origine canadese, durante il periodo del proibizionismo la società conquista un terzo del mercato americano.
Febbraio 1933: il diciottesimo emendamento, che vietava produzione, vendita e trasporto di liquori, viene abrogato. Il consumo di alcool ridiventa legale e i profitti di Seagram si impennano vertiginosamente. I mezzi finanziari giganteschi di cui ormai dispongono consentono ai Bronfman di diventare azionisti di riferimento del colosso chimico Du Pont de Nemours. La fama di Edgard M. Bronfman, dal 1971 patron della famiglia, sale alle stelle. Presidente del World Jewish Congress, è lui a concludere la trattativa che portò allo storico accordo con le banche svizzere per la restituzione (parziale) dei beni sottratti agli ebrei durante il nazismo.
Il destino gli sarà però avverso. Suo figlio Edgard jr, dopo qualche fallimentare esperienza come compositore e produttore musicale, viene misteriosamente nominato Ceo del gruppo. Siamo a metà degli anni Novanta. Dopo qualche anno, il giovane rampollo rivende a Du Pont de Nemours le azioni dell’azienda in suo possesso (si calcola che oggi varrebbero oltre trenta miliardi di dollari) per realizzare il suo sogno: acquistare Universal Studios. Certo, il cinema è divertente mentre la chimica è noiosa. Solo che è un pessimo affare (non ci voleva un genio per sapere che le major di Hollywood falliscono con regolarità cronometrica e nessuno ci ha mai guadagnato). Non pago, compra anche Polygram, leader mondiale della musica, esattamente un minuto prima che la rivoluzione digitale ne azzerasse i ricavi. Si mette allora in affari con un socio ancora più stravagante: Jean Marie Messier, Pdg (presidente e direttore generale) di Vivendi, quella stessa Vivendi che ha tentato invano di scalare Telecom Italia e Mediaset, che poi altro non è che la vecchia Générale des Eaux.
I due decidono di convolare a nozze in una fusione che imploderà in pochi mesi, con una perdita del 90 per cento circa del valore delle azioni. Un disastro che richiederà un salvataggio organizzato dall’amministratore delegato di Axa Jean Claude Bébéar, esponente di spicco dell’establishment francese. Messier viene licenziato in tronco e gli spirit di Seagram (marchi come Chivas Regal, Crown Royal, Captain Morgan, Martell, The Glenlivet e molti altri) vengono venduti a prezzi stracciati a due multinazionali del settore, Diageo e Pernod Ricard. La memoria di quella che è stata una delle etichette più celebri su scala planetaria è ora affidata solo al Seagram Building, che resta uno dei grattacieli più belli di New York. Si conclude così la storia di un clamoroso fallimento del family business made in Usa.
Morale: anche negli Stati Uniti i proprietari delle imprese familiari possono nascere dalla mamma sbagliata. In Italia, però, questo rischio è assai più elevato. Attenti agli equilibri dinastici, sono infatti tutt’altro che inclini all’innovazione e aperti alla flessibilità, inflitta invece al lavoro in misura che ormai impedisce di formare una famiglia, affittare una casa, avere figli. Da noi la flessibilità che manca non è quella del lavoro, bensì del capitale. Questa non c’è legge che possa imporla, se non la disciplina del mercato. Ma un sistema finanziario capace di svolgere il proprio ruolo dovrebbe spingere le imprese ad accorparsi, trasformarsi, innovare, invece di coccolare patron che non vogliono rinunciare ai benefici privati del controllo (come scaricare sul bilancio aziendale spese “improprie”, o gestire il non sempre marginale “nero”).
Perché, infine, internazionalizzazione in Italia significa vendita all’estero delle nostre imprese e quasi mai il contrario? I dati degli ultimi anni sono impressionanti: Pinifarina e Ilva agli indiani, Italcementi ai tedeschi di Heidelberg Cement, Ansaldo Sts e Ansaldo Breda ai giapponesi di Hitachi, Pirelli ai cinesi, World duty free dei Benetton agli svizzeri di Dufry, Indesit Merloni agli americani di Whirpool, la milanese Edison alla francese Edf, Fendi, Pucci e Bulgari a Louis Vuitton, Gucci a Henri Pinault, Valentino all’emiro del Qatar, i gelati Grom agli anglo-olandesi di Unilever, e potremmo continuare.
Le operazioni in controtendenza si possono contare sulle dita di una mano, come quelle del gruppo Campari nel settore degli spirit. Secondo Eurispes, i marchi del made in Italy finiti sotto il controllo straniero sono più di 430. A questo punto, decine di indizi formano più di una prova: in una parte larga del capitalismo familiare domestico gli eredi di grandi e medie fortune hanno il vizietto di convertire in rendita i profitti ereditati dai loro avi.
Tutta colpa di un padronato geneticamente avido e rapace, dunque? Non credo. Il nostro sistema politico, caratterizzato nel passaggio di secolo da un bipolarismo zoppo e da governi di coalizione compositi e litigiosi, ha contribuito non poco a generare quelle zone di opacità nell’economia in cui prosperano e si riproducono le lobby della rendita finanziaria e immobiliare.