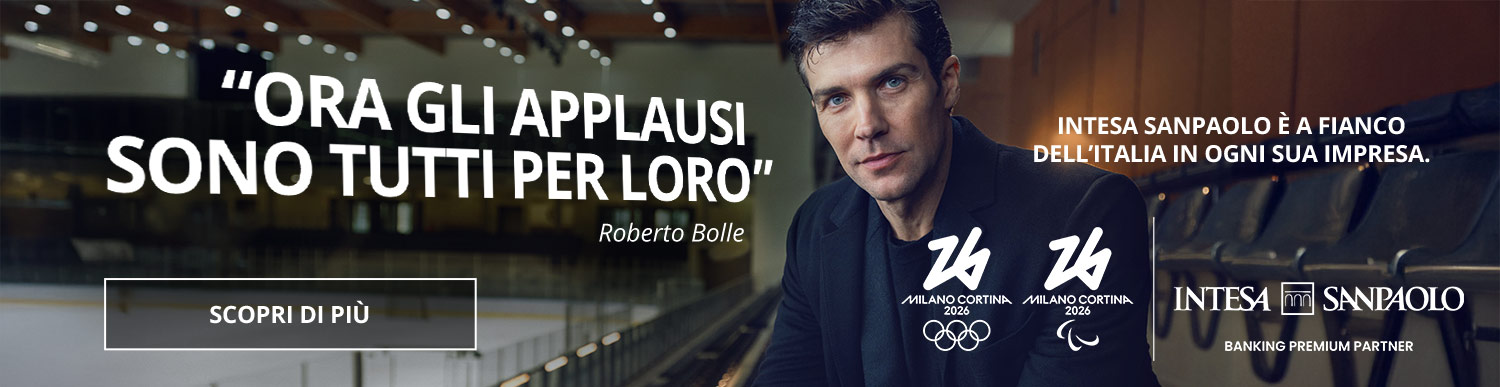Ci sono tanti modi per seguire la vicenda dei dazi che l’amministrazione di Donald Trump sta negoziando con i suoi principali partner commerciali per riequilibrare gli scambi degli Usa con l’estero.
Il primo è quello di aderire alla visione manichea che comprende la descrizione di Trump alla stregua di un pazzo senza freni, circondato da una corte di giannizzeri pronti ad adularlo in ogni occasione; completano il quadro la fiducia granitica nelle magnifiche sorti e progressive della Ue che spezzerà la reni al mostro. Ovviamente nulla sul fatto che questo sia solo l’ultimo episodio di una serie cominciata già nel 2015, con il Dieselgate, proseguita con i dazi del primo mandato di Trump e, sotto diversi aspetti, anche sotto la presidenza di Joe Biden. La richiesta degli Usa è sempre stata la stessa: il rapporto commerciale relativo ai beni scambiati tra Ue e Usa è viziato a favore della Ue (leggi Germania) e necessita di un riequilibrio.
Ma non c’è sordo peggiore di chi non vuol sentire.
Chi crede che sia tutto così semplice, potrebbe interrompere qui la sua lettura e godersi le sue solide certezze, maturate e confermate leggendo i principali quotidiani italiani. Tutti schierati come un sol uomo a sostenere la reductio ad Hitlerum di Trump.
Chi invece è assalito dal dubbio ed è almeno curioso di capire quale sia il disegno complessivo dell’amministrazione Trump, senza con ciò sostenerne la correttezza dell’operato, può incamminarsi con noi che seguiamo da tempo i fatti e cerchiamo di valutarli su un orizzonte temporale più lungo di una giornata di contrattazioni in Borsa.
Basta fare una rassegna stampa che esca dall’orticello del Bel Paese e i dubbi non mancano. Sia sulla giustificazione delle mosse di Trump che sui veri difetti della sua impostazione e sui rischi che corre.
Il disegno strategico di Trump conta su più pilastri. Dazi, riduzione delle imposte, deregulation, basso costo delle materie prime energetiche e conseguente bassa inflazione e dollaro relativamente debole. Tutti si compongono ad unità per rimettere, in un arco temporale di almeno un paio di anni, gli Usa su un sentiero di crescita più equilibrato e solido, non troppo sbilanciato sui consumi e più focalizzato sugli investimenti privati destinati a irrobustire la capacità produttiva industriale del Paese. Con la consapevolezza che la riduzione di un deficit commerciale verso l’estero determina, per definizione, una riduzione delle attività finanziarie Usa detenute dagli stranieri e quindi minori flussi verso Wall Street.
Ma, anche qui, senza passare da un estremo ad un altro, con un approccio tendente ad un riequilibrio anziché ad un ribaltamento delle posizioni.
Sembra perfino salutare che si sia sgonfiata senza produrre grandi danni la bolla del mercato azionario Usa, frutto di almeno 7-8 anni di crescita praticamente ininterrotta, con i prezzi delle azioni che tuttora incorporano multipli rispetto agli utili semplicemente insostenibili e quasi sempre più alti di quelli europei.
Tuttavia, non sembra essere minacciato il paradigma di fondo, che vede gli Usa, contemporaneamente e inscindibilmente, essere i consumatori di ultima istanza del pianeta e i fornitori delle attività finanziarie con cui si possono pagare quei consumi. Ci perdoneranno i puristi, ma gli Usa è come se fossero i fornitori delle fiches del Casinò. Andando più sul tecnico, è impossibile essere importatori netti senza avere adeguate riserve valutarie, e gli Usa non avranno mai scarsità di riserve valutarie. Perché le creano loro. Anzi, sono obbligate a crearle per consentire al dollaro di essere la valuta dominante nelle transazioni commerciali del pianeta. Si tratta “soltanto” di riportare la barra verso il centro, perché così l’assetto di navigazione è troppo rischioso. Non sembra esserci alcuna intenzione, né possibilità, di sostituire il modello.
Resta però una manovra delicatissima e dobbiamo rifugiarci sulla stampa internazionale per trovare qualche disamina non partigiana. Premesso che ormai anche il Wall Street Journal non lesina critiche a Trump e tutto il resto delle principali testate è da tempo su posizioni assolutamente critiche, la necessità di mantenere un minimo di reputazione quasi “costringe” tali testate a un minimo di equilibrio.
E così ci capita di leggere sul Washington Post una combattiva Liz Truss, ex-premier britannica, che avverte che le élite economiche globali ostacolano politiche pro-crescita. Nel suo editoriale, esorta Trump e il Segretario al Tesoro Bessent a resistere al “deep state” e promuovere crescita attraverso dazi, tagli fiscali, deregolamentazione e controllo della spesa pubblica. Riflettendo sulla sua esperienza nel 2022, Truss critica l’establishment per aver bloccato le sue riforme, causando stagnazione. L’invito a Trump a smantellare la burocrazia e sfidare le élite per salvare l’Occidente, è vibrante.
Oppure, ci siamo imbattuti, sul quotidiano francese Le Figaro, in un articolo in cui si spiega La Francia è meno colpita dai dazi di Trump rispetto alla Germania, grazie alla natura delle sue esportazioni verso gli USA. Con un deficit commerciale di 4,2 miliardi di euro nel 2024, la Francia esporta soprattutto aerei (9,7 miliardi), bevande (4,1 miliardi) e farmaci (3,8 miliardi), tassati al 10%. La Germania, con un surplus di 93 miliardi e il 27% delle esportazioni in auto, subisce tariffe medie del 12,3%. L’eccesso commerciale tedesco è il vero bersaglio di Trump.
Sono le politiche di compressione della domanda tedesca hanno indebolito le esportazioni di altri paesi UE, come la Francia.
Anche Bloomberg non ha potuto non dare eco alla descrizione di negoziatori Ue confusi e privi di un preciso mandato, tali e tanti sono gli interessi eterogenei da conciliare, fatta filtrare dal segretario al Tesoro Usa Scott Bessent. Questi ha dichiarato che l’UE soffre di un “problema di azione collettiva” che ostacola i negoziati commerciali con gli USA. L’UE, con un surplus commerciale di 250 miliardi di dollari, fatica a trovare un accordo unificato a causa di interessi divergenti tra Stati membri, e così Trump ha minacciato dazi del 50% dal 1° giugno 2025. Bessent si è dichiarato invece ottimista su accordi con Asia (Giappone, Indonesia, Taiwan), ma prevede tempi lunghi con l’UE. Bessent sottolinea che l’UE è rallentata da interessi contrastanti tra Stati membri, come Italia e Francia, rendendo difficili i negoziati commerciali con gli USA.
Nel frattempo sul sito Politico.ue (anche qui non certo un pericoloso covo di anti-UE) ci viene dettagliatamente spiegato come è stato possibile per il Regno Unito passare da essere gli ultimi della coda (ricordando le infelici parole di Barack Obama poco prima del referendum per la Brexit del 2016) ad essere il primo Paese a chiudere un accordo con gli Usa. Il Regno Unito, guidato da Keir Starmer, ha concordato una riduzione dei dazi su auto (da 27,5% a 10% per 100.000 veicoli) e acciaio (da 25% a 0%). L’accordo, annunciato l’8 maggio 2025, mantiene standard britannici su cibo e farmaci, ma lascia dazi al 10% su altri beni. Starmer ha sfruttato la relazione con Trump, costruita con diplomazia pragmatica, per ottenere un vantaggio rispetto all’UE, nonostante le difficoltà interne.
L’uscita dall’UE ha permesso al Regno Unito di negoziare autonomamente, evitando i dazi del 20% imposti all’UE.
È dalle colonne del Wall Street Journal che arriva l’analisi per noi più condivisibile. I rischi per Trump sono tutti annidati nei tempi e con i quali si assesteranno i diversi accordi commerciali con i suoi più importanti partner. In parallelo, dovrebbero entrare al più presto “in circolo” gli effetti della riduzione delle imposte, che dopo il passaggio alla Camera dei Rappresentati, è atteso ora al Senato.
Si tratta di un provvedimento pro-crescita molto importante, da cui dipende buona parte del successo politico di Trump. Staremo a vedere. Importante è stare lontano dai commenti ansiogeni, isterici e grossolani che capita di trovare su alcuni grandi (non sappiamo fino a quando) quotidiani italiani.