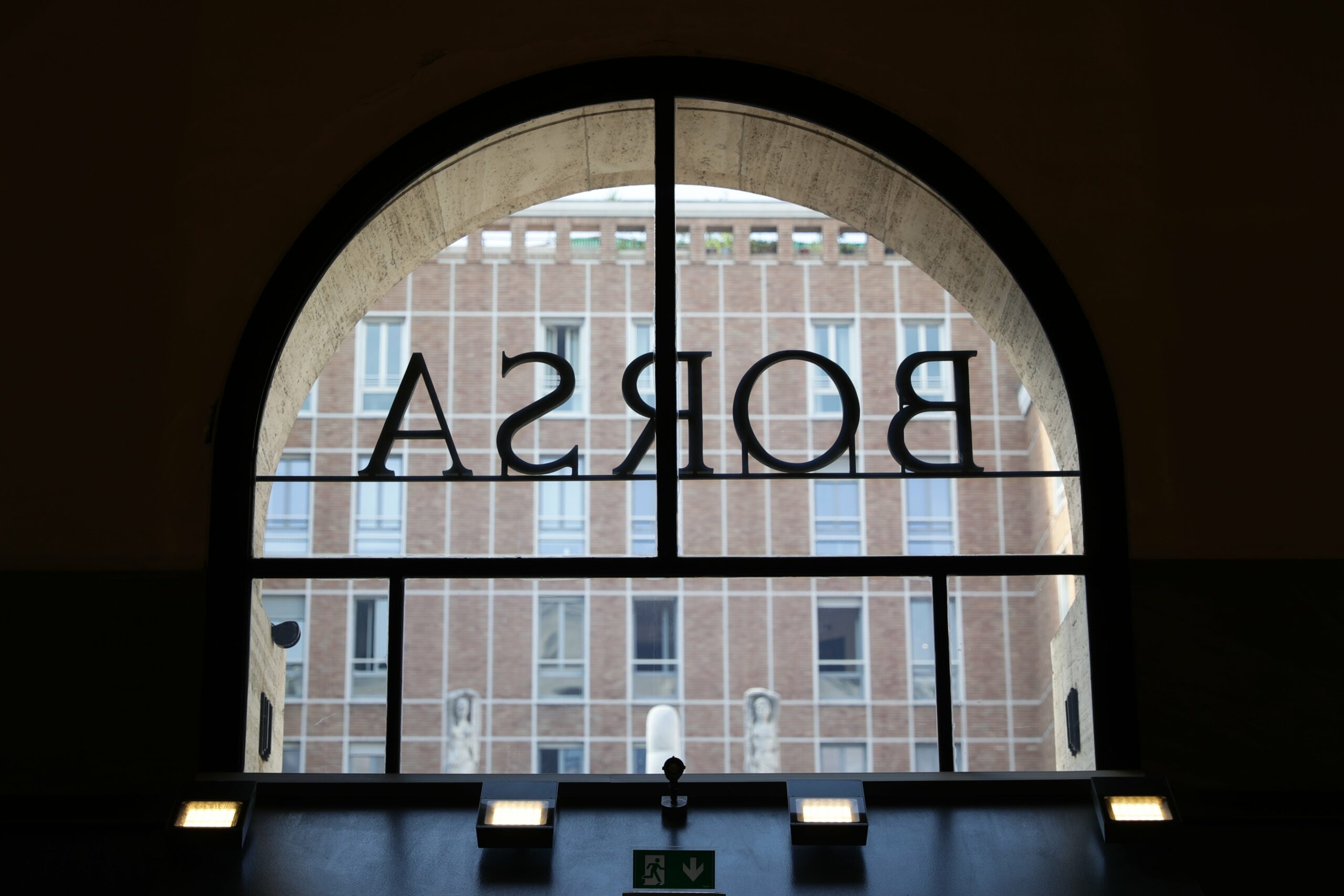I tre gasdotti che dalla Russia rifornivano l’Europa
Il gasdotto russo-ucraino è un gasdotto lungo 4.500 chilometri che trasportava il gas dal giacimento di Urengoj all’Alta Siberia fino all’Ucraina e poi in Europa. Faceva parte del programma “gas in cambio di condotte” e la sua costruzione fu sostenuta dalla banca “Ost-West Handelsbank”, aperta a Francoforte nel 1973 dal Partito Comunista dell’Unione Sovietica (PCUS). Il gasdotto fu costruito fra il 1982 e il 1984, completando il sistema di trasporto del gas transcontinentale Siberia occidentale-Europa occidentale che esisteva dal 1973. Inizialmente, il progetto prevedeva la posa di due linee in un corridoio utilizzando interamente tecnologie, attrezzature e tubi di grande diametro di fabbricazione occidentale.
I piani sovietici di costruzione del gasdotto furono fortemente osteggiati dall’amministrazione statunitense di Ronald Reagan. Gli americani temevano che l’Europa occidentale sarebbe divenuta dipendente dalle forniture di gas sovietiche, offrendo un vantaggio strategico all’Unione Sovietica. Temevano, come di fatto avvenne, che Mosca avrebbe utilizzato le entrate delle esportazioni per scopi militari. Nel dicembre 1981, gli Stati Uniti implementarono sanzioni che impedivano alle aziende americane di esportare tecnologie di petrolio e gas in Unione Sovietica. La ragione formale dell’imposizione delle sanzioni da parte degli Stati Uniti fu l’accusa che l’Unione Sovietica fosse il mandante dell’imposizione dello stato di emergenza in Polonia il 13 dicembre 1981, che diede inizio alla repressione del popolo polacco. A seguito dell’embargo imposto dal presidente Regan sulle forniture di attrezzature americane ad alta tecnologia, il progetto fu rivisto.
Il gasdotto partiva dal giacimento di Urengoj in Siberia e raggiungeva Užhorod nell’Ucraina occidentale. Da lì, il gas naturale veniva trasportato nei Paesi dell’Europa centrale e occidentale. Insieme al gasdotto Soyuz e al gasdotto Progres formava il cosiddetto corridoio di transito occidentale in Ucraina. Passando attraverso Sudža, nell’oblast’ di Kursk, attraversava il confine russo-ucraino a nord di Sumy. Inoltre, trasportava il gas alla stazione di Užhorod al confine ucraino con la Slovacchia e a stazioni di pompaggio più piccole ai confini ungherese e rumeno.
Il Nord Stream 1
Inaugurato nel 2012 e lungo 1.224 chilometri, il gasdotto Nord Stream 1 trasportava gas proveniente dalla Russia in Europa occidentale, attraverso il Mar Baltico e la Germania. Il condotto venne ufficialmente inaugurato dalla Cancelliera tedesca Angela Merkel, dal Presidente russo Dmitrij Medvedev e dal Primo ministro francese François Fillon, l’8 novembre 2011.
Il Nord Stream 2
Il Nord Stream 2 è il gasdotto offshore più lungo del mondo.
Avrebbe dovuto trasportare gas naturale per 1.230 chilometri, dalla costa baltica della Russia fino a Greifswald, in Germania, poco distante dallo sbocco di Nord Stream 1. Allacciato alla rete di distribuzione dell’Unione Europea, attraversa il Mar Baltico, nelle acque territoriali di Russia, Finlandia, Svezia, Danimarca e Germania.
Il Nord Stream 2 – alimentato da una delle più grandi riserve di gas naturale al mondo, quella di Bovanenkovo nella penisola di Yamal nella Russia settentrionale – composto da due linee parallele di condutture, doveva aggiungere i suoi flussi di gas a quelli trasportati dai due condotti già presenti del Nord Stream 1. Le due condutture di Nord Stream 2 avrebbero dovuto raggiungere una portata di 55 miliardi di m3 di gas naturale all’anno, circa il 13 per cento del fabbisogno dell’Unione Europea. Insieme al Nord Stream 1, con la stessa portata, avrebbero permesso alla Russia di rifornire l’Europa con 110 miliardi m3 di gas naturale all’anno.
Chi costruì il Nord Stream 2?
Nel giugno del 2015, durante il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, tre compagnie energetiche europee – E.ON (tedesca), OMV (austriaca) e Royal Dutch Shell (anglo-olandese) – firmarono un accordo con Gazprom, la più grande compagnia energetica controllata dal Cremlino che produce il 70 per cento della produzione di gas russo e possiede il 18 per cento delle riserve di gas naturale conosciute, per costruire un nuovo gasdotto tra la Russia e la Germania attraverso il Mar Baltico. In seguito si aggiunsero all’accordo anche le compagnie tedesche BASF/Wintershall e Uniper, la francese ENGIE e la norvegese Statoil. Germania e Austria sono i due Paesi europei che più hanno investito nel progetto, che nelle diverse fasi di costruzione e fornitura di tecnologie avanzate coinvolse anche Finlandia, Svezia, Danimarca e Italia.
Tuttavia, Gazprom – la società che ha finanziato con 4,75 miliardi di Euro il 50 per cento dell’opera, era l’unica azionista di Nord Stream 2 AG – e manteneva il controllo assoluto del gasdotto.
Implicazioni geopolitiche del Nord Stream 2
Fin dalle fasi iniziali dell’accordo con Gazprom, la costruzione del Nord Stream 2 è stata molto criticata da chi pensava che avrebbe sottoposto a una pericolosa dipendenza dal gas russo l’Unione Europea. Inoltre, la sua costruzione vanificava le sanzioni internazionali imposte alla Russia in seguito all’annessione della Crimea nel 2014.
Quasi tutti i governi dei Paesi dell’Est Europa, a partire da quello polacco, le tre repubbliche baltiche – Estonia, Lettonia e Lituania – la Repubblica Ceca e la Bulgaria, si sono sempre opposte al nuovo gasdotto perché prevedevano l’abbandono del gasdotto russo-ucraino e temevano l’uso coercitivo dell’energia che ne avrebbe fatto Mosca.
Infatti, dopo le controversie con gli occidentali e gli innumerevoli incidenti che lo hanno interessato, la Russia ha smesso di esportare gas attraverso il gasdotto russo-ucraino alla fine del 2024, addebitando all’Ucraina l’interruzione della fornitura, per essersi rifiutata di rinnovare il contratto.
Gli Stati membri dell’ex Unione Sovietica che hanno conquistato la libertà con il crollo del comunismo, hanno sempre temuto – a ragion veduta – che il Nord Stream 2 avrebbe incoraggiato le aggressioni russe, in quanto esclusi dal passaggio dei condotti attraverso i loro territori. Convinti che il nuovo gasdotto a Nord li avrebbe penalizzati e messi in pericolo, pensano che la sua realizzazione sia stata una manovra strategica della Russia prima di invadere l’Ucraina, per renderla non più in grado di interferire sui flussi di gas diretti alla rete di distribuzione europea.
Il blocco dei Paesi dell’Europa orientale temeva inoltre che aumentando la dipendenza europea dal gas russo si sarebbe messa a rischio la sicurezza energetica dell’UE. Il Nord Stream 2, sostengono, fu un tentativo del governo russo di aumentare la propria influenza politica in Europa e avrebbe dovuto essere considerato nel contesto più ampio della guerra ibrida russa e dell’aggressione militare in Crimea.
Anche gli Stati Uniti si sono sempre opposti stati al Nord Stream 2, nel suo primo mandato il presidente Donald Trump aveva chiesto al Congresso di imporre sanzioni sull’intero progetto per bloccarne la costruzione. Come i polacchi, gli statunitensi pensano che il gasdotto rendeva l’Europa troppo dipendente dal gas della Russia e hanno più volte proposto ai Paesi dell’Unione di comprare il gas naturale statunitense, trasportandolo allo stato liquido con le navi metaniere per poi essere immesso in rete con i rigassificatori. Modalità di importazione di Gnl, petrolio e combustibili nucleari per la cifra astronomica di 250 miliardi di dollari che ora la Commissione Europea ha dovuto obtorto collo accettare dall’Amministrazione Trump 2.0, come parte dell’accordo per abbassare i dazi al 15% sulle importazioni.
La strategia coercitiva russa delle fonti energetiche
Il Nord Stream 2 non fu solo un semplice accordo commerciale, ma molto di più: come succede per tutti i progetti energetici di questa portata, il lato economico è accompagnato da implicazioni geopolitiche e strategiche, perché la sicurezza energetica di uno Stato è sempre associata alla sicurezza nazionale.
Uno dei motivi che hanno spinto la Russia alla costruzione di un nuovo gasdotto era quello di togliere all’Ucraina un’importante fonte di guadagno economico, Kyiv riceveva ogni anno più di 2 miliardi e mezzo di Euro in tasse per il passaggio del gas russo attraverso il gasdotto russo-ucraino. Ma soprattutto privarla di un pesante strumento geopolitico: già nel 2009 durante una disputa tra i due Paesi, l’Ucraina aveva ridotto il flusso di gas dal condotto russo-ucraino che attraversava il suo territorio, facendo rimanere l’Unione Europea senza forniture di gas per due settimane nel mezzo dell’inverno. Il progressivo incrinarsi delle relazioni con l’Ucraina, complicate anche dall’annessione da parte russa della Crimea nel 2014 e dall’inasprirsi del conflitto in corso nell’Ucraina orientale, ha fatto sì che Gazprom preferisse cercare rotte alternative.
I gasdotti Nord Stream non sono mai stati solo un progetto energetico. Si trattava di un’arma geopolitica mascherata da infrastruttura, progettata per intrappolare l’Europa nella dipendenza da Mosca, bypassando i partner dell’Europa orientale che hanno compreso il rischio fin dall’inizio.
Grazie al Nord Stream 1 e 2, il presidente Vladimir Putin ha pensato di avere le mani libere in Ucraina per muovere il suo esercito fino ai confini orientali dell’Unione Europea, senza alcun impatto sui flussi di gas.
Il Nord Stream 2 ha minato l’unità della NATO, diviso l’UE e incoraggiato il Cremlino. Ha contribuito a finanziare la guerra che ora minaccia la stabilità del continente.
Il sabotaggio del Nord Stream del settembre 2022
Nelle prime ore della notte di lunedì 26 settembre 2022, quattro falle causate da diverse esplosioni, alcune delle quali confermate anche dai sismologi che registrarono due potenti detonazioni, precedettero delle grandi dispersioni di gas in mare. La prima esplosione fu registrata dalla rete sismica nazionale svedese a Sud-Est dell’isola danese di Bornholm. Una seconda esplosione, più forte, a Nord-Est dell’isola, nella stessa notte, fece segnalare ai sismografi fenomeni sismici equivalenti a quelli di un terremoto di magnitudo 2,3 – registrate da diverse stazioni sismografiche – in Danimarca, Norvegia e Finlandia.
Fu subito chiaro che le esplosioni che causarono grosse perdite di gas, presente solo nel gasdotto Nord Stream 1, erano il risultato di un’azione deliberata di sabotaggio e non di un incidente.
Prima dell’aggressione militare russa contro l’Ucraina, attraverso il gasdotto danneggiato, Nord Stream 1, passava più di un terzo delle esportazioni di gas naturale russo verso l’UE. Il Nord Stream 2 sarebbe dovuto entrare in funzione nel 2022, ma la Germania era stata “indotta” dall’Amministrazione Biden a bloccarne l’uso a febbraio 2022 dopo il tentativo, fallito, di dissuadere la Russia dall’invadere l’Ucraina.
Ad agosto 2022 Mosca interruppe completamente le esportazioni anche attraverso il Nord Stream 1, a causa dell’ulteriore inasprimento delle sanzioni economiche imposte dall’UE per il perdurare della guerra contro l’Ucraina.
Sin dall’inizio delle perdite di gas risultarono evidenti le impronte che quell’incidente era da inquadrare nell’ambito della guerra energetica provocata dall’invasione russa dell’Ucraina.
Il sabotaggio avvenne il giorno prima dell’inaugurazione a Goleniow del gasdotto Baltic Pipe, che a partire dal 1° ottobre avrebbe iniziato a trasportare gas dalla Polonia alla Danimarca, un progetto fondamentale per la sicurezza dell’approvvigionamento nella regione e risultato di una politica UE volta a diversificare le fonti di approvvigionamento del gas. Una infrastruttura chiave per trasportare il gas dalla Norvegia, attraverso la Danimarca, alla Polonia e agli Stati baltici, aprendo una nuova rotta di importazione dal Mare del Nord verso l’Unione Europea. In quelle settimane la NATO aveva segnalato un forte aumento delle attività navali e della presenza di droni russi nel Mare del Nord. E ancora prima, nelle settimane di aprile 2021, alcuni soldati della 342a unità di ricerca e soccorso della Flotta baltica della Marina russa a bordo della nave di soccorso multifunzionale Rescuer Karev, avevano svolto operazioni subacquee nell’area di costruzione del Nord Stream 2. Non si possono escludere scenari in cui gli ordigni esplosivi con comandi a distanza possano essere stati consegnati da sottomarini e piazzati dagli incursori dell’Unità militare 40056 del GUGI (Direzione Principale della Ricerca Profonda), afferente all’intelligence militare russa (GRU), nota anche per le sue azioni di spionaggio e sabotaggio sui cavi sottomarini.
La Russia potrebbe aver organizzato le esplosioni ai gasdotti Nord Stream 1 come parte di un’operazione per paralizzare l’economia europea, per sbloccare e lanciare il Nord Stream 2 e per creare le condizioni per non essere definitivamente bloccato anche in caso di interruzione del conflitto, poiché il percorso alternativo è stato reso inutilizzabile.
Una cosa è certa: quell’atto di sabotaggio ha colpito il sistema energetico dell’UE.
Ovviamente gli scambi di accuse tra Occidente e Russia sono reciproci, ma la complessità di quella operazione di sabotaggio subacqueo in mare aperto ha determinato un’altra certezza: chiunque sia stato l’autore, siamo davanti all’azione di un attore statale (o suo proxy), russo o antirusso, e dell’ennesimo attacco ‘false flag”, che rientrerebbe nella strategia degli attacchi sotto falsa bandiera che la Russia usa spesso sferrare per iniziare guerre, per ottenere il sostegno pubblico, per creare panico tra le popolazioni, per coprire crimini, per eliminare nemici e traditori.
La Russia ha sempre praticato attacchi di sabotaggio alle infrastrutture critiche e con il prolungarsi della guerra abbiamo visto come i russi utilizzano tattiche ibride e siano tornati alle operazioni in stile Guerra Fredda, pianificate e praticate per un conflitto non cinetico e nella zona grigia con l’Occidente.
Tuttavia, dall’inizio dell’invasione russa del suo territorio, anche l’Ucraina ha portato a segno diverse operazioni “false flag”. Pertanto, non si può escluderla a priori.
Il vantaggio principale per un ipotetico attore statale occidentale, come la stessa Ucraina, ottenuto dal danneggiamento dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, ove questi fossero operativi, consisterebbe nell’impedire alla Russia di continuare a guadagnare miliardi di dollari (rubli) dalla vendita del gas e dall’utilizzarlo come strumento di ricatto e di guerra economica contro l’Europa a dispetto delle sanzioni. Con quel sabotaggio, in pratica sarebbe venuta meno la possibilità da parte della Russia di usare il suo gas come arma di coercizione geopolitica contro l’Europa e per finanziare la guerra. Tuttavia, rimane difficile credere che nel 2022 uno Stato europeo (a eccezione dell’Ucraina aggredita) potesse essere interessato a utilizzare tattiche di guerra ibrida, i cui effetti sono ricaduti sui cittadini europei, alimentando instabilità nel mercato dell’energia e aggravando la crisi socioeconomica.
Le indagini
Tutti i Servizi di intelligence hanno attivato indagini per individuare i responsabili e soprattutto i mandanti dei sabotaggi in acque internazionali.
In teoria potrebbero essere diversi i possibili attori occidentali di un attacco “false flag” ai gasdotti Nord Stream.
Il Cremlino ha sempre respinto qualsiasi responsabilità sull’accaduto e ha accusato gli Usa, perché hanno sempre contrastato la costruzione del Nord Stream 2. Inoltre, il presidente Biden qualche giorno prima dell’invasione russa dell’Ucraina dichiarò che quel gasdotto sarebbe stato chiuso in caso di aggressione, come effettivamente decise di fare la Germania. Mosca ha chiesto l’avvio di un’indagine internazionale al Consiglio di sicurezza dell’ONU, richiesta che è stata respinta. Svezia e Danimarca hanno avviato proprie indagini sul sabotaggio ma sono state chiuse nel febbraio 2024 senza identificare i responsabili, mentre la Germania continua a indagare.
A giugno 2024 le autorità tedesche hanno emesso un mandato di arresto europeo per un cittadino ucraino sospettato di aver utilizzato lo yacht Andromeda, insieme ad altri due soggetti, per sabotare i gasdotti. Il 21 agosto 2025, a quasi tre anni dal sabotaggio dei gasdotti russi Nord Stream nel mar Baltico, sulla base di quel mandato la Procura Federale Tedesca ha ordinato l’arresto del cittadino ucraino Serhii K. segnalato nella provincia di Rimini, perché sospettato di essere uno dei coordinatori del commando.
Il 30 settembre anche le autorità polacche, su mandato di arresto europeo emesso dalla Germania, hanno fermato un secondo uomo ucraino accusato di avere partecipato al sabotaggio dei due gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2. L’uomo è un sommozzatore ucraino identificato come Wladmir S., e secondo gli investigatori tedeschi, sarebbe stato lui a posizionare le cariche esplosive che danneggiarono i gasdotti.
Si tratta di una questione controversa. Le persone accusate erano state interrogate in precedenza e rilasciate. A quanto pare non c’erano prove che li collegassero al sabotaggio di quelle condutture, e il loro coinvolgimento è molto improbabile a causa delle difficoltà tecniche connesse alle profondità dei tubi danneggiati (circa 100 metri).
I danesi hanno pubblicato documenti che in quel periodo dimostrano attività sospette di un gruppo di navi russe dotate di attrezzature per immersioni in saturazione nell’area a Est di Nexø e Dueodde su Bornholm. Questi includevano movimenti complessi delle navi nell’area dei gasdotti Nord Stream.
“Non è nell’interesse della Polonia estradare in Germania il cittadino ucraino arrestato per l’inchiesta sul Nord Stream”.
Il successivo 7 ottobre, il primo ministro polacco Donald Tusk ha affermato che coloro che hanno costruito il Nord Stream 2, non coloro che sono accusati di averlo sabotato, “dovrebbero vergognarsi e rimanere in silenzio”, aggiungendo che “non è nell’interesse della Polonia” consegnare il sospettato.
Le dichiarazioni di Tusk sono state rilasciate nel mezzo di un rinnovato dibattito sul gasdotto Nord Stream 2, relativamente alla gestione da parte della Polonia di una richiesta di estradizione tedesca per un cittadino ucraino arrestato pochi giorni prima nella Polonia centro-orientale, perché accusato dalle autorità tedesche di essere coinvolto nell’esplosione del gasdotto nel 2022.
“Questa non è una situazione nuova”, ha dichiarato il premier Tusk durante una conferenza stampa congiunta a Varsavia con il Primo Ministro lituano Inga Ruginiene. “Dal nostro punto di vista, le uniche persone che dovrebbero vergognarsi e rimanere in silenzio sulla questione del Nord Stream 2 sono coloro che hanno deciso di costruirlo”.
Tusk ha aggiunto di aver presentato la posizione della Polonia all’ex Cancelliere tedesco Olaf Scholz e al presidente Volodymyr Zelensky “molti mesi fa”.
“La nostra posizione non è cambiata. Non è certamente nell’interesse della Polonia accusare o consegnare questo cittadino a un altro Paese”, ha affermato Tusk.
Il presidente del Consiglio polacco ha aggiunto che la costruzione del gasdotto, che collega la Russia e la Germania attraverso il Mar Baltico, va “contro gli interessi più vitali dell’intera Europa”.
“La decisione spetterà alla Corte”, ha affermato Tusk, aggiungendo che il governo non interferirà.
Tomasz Siemoniak, ministro coordinatore dei Servizi segreti polacchi, ha dichiarato in precedenza che il caso è “estremamente grave” e che il tribunale ha fino a 100 giorni per decidere se estradare il sospettato in Germania.
L’indagine tedesca sostiene che Volodymyr Z. (Wladmir S. secondo le autorità tedesche), un sommozzatore e istruttore subacqueo, abbia contribuito a posizionare esplosivi sui gasdotti Nord Stream nel settembre 2022, insieme al sospettato ucraino arrestato in Italia ad agosto con accuse simili.
I dirompenti commenti del primo ministro polacco Donald Tusk hanno interrotto anni di auto-illusione europea. La sua opinione, secondo cui coloro che hanno costruito il Nord Stream 2 dovrebbero “vergognarsi e rimanere in silenzio”, è difficile da contestare.
Il dibattito sul sabotaggio può continuare nelle aule dei tribunali, ma il fallimento strategico è stato deciso molto prima, quando i governi e le aziende occidentali si sono convinti che il gas russo a basso costo valesse il costo della sicurezza e della sovranità.
Dopo aver ascoltato l’intervista della signora Merkel, in cui ha fatto da megafono alla propaganda del Cremlino, affermando che gli Stati baltici e la Polonia sono responsabili dell’aggressione della Russia sul fronte dell’Europa orientale, non si può fare a meno di evidenziare la lucidità del governo polacco.
Al contempo, emergono sempre con maggiore evidenza le implicazioni strategiche delle decisioni adottate durante l’Era Merkel – che unitamente a quelle all’Era del Cancelliere Schröder – costituiscono i principali fattori che hanno contribuito alla rinascita economica e delle ambizioni imperialiste della Russia, alla penetrazione in Europa della Cina e alla sfida che i due autocrati alleati hanno lanciato all’ordine internazionale. Fatti ora sempre più riconosciuti dagli stessi politici tedeschi.
Pertanto, il tentativo di deviare la responsabilità sui sabotatori (che vanno perseguiti e condannati) e di attribuire la colpa agli Stati baltici e alla Polonia che hanno subito le conseguenze di politiche energetiche filorusse, appare non solo poco convincente ma anche eticamente inaccettabile.