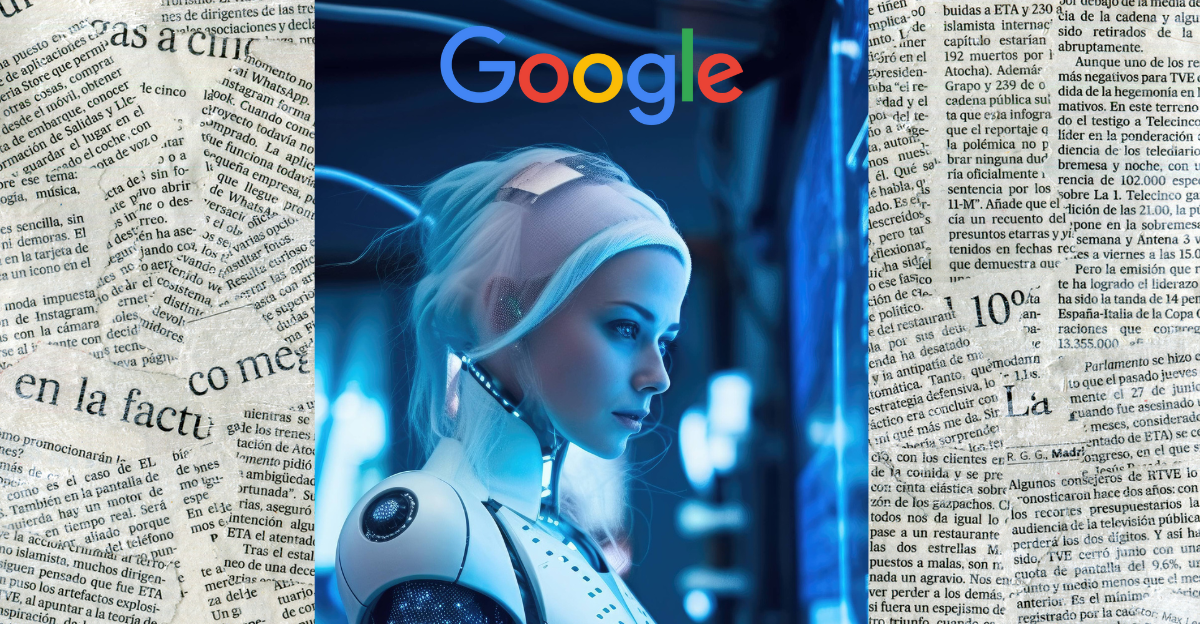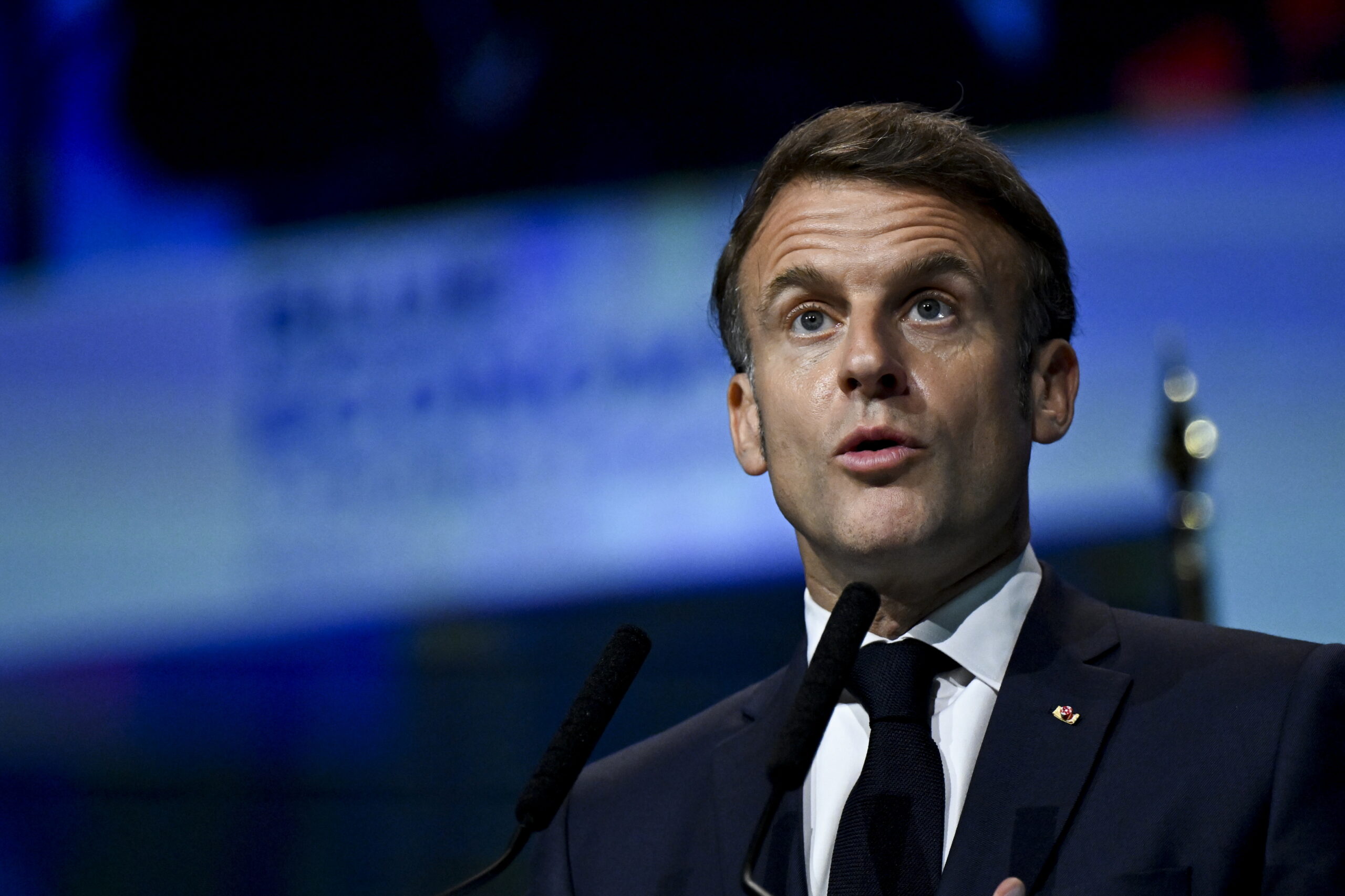Il “buy european” in difesa lascia il passo al rinnovato “buy american”?
Durante un incontro tenutosi a Turnberry in Scozia tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato annunciato un accordo commerciale sui dazi. Le merci europee in ingresso negli Stati Uniti saranno soggette a una tariffa doganale del 15%. In cambio, l’Unione europea si è impegnata ad acquistare energia e gas per un valore di 750 miliardi di dollari e a investire 600 miliardi in prodotti statunitensi, oltre all’approvvigionamento di “grandi quantità” di armi. “Non sappiamo quale sia la cifra esatta, ma noi produciamo i migliori equipaggiamenti militari al mondo”, ha dichiarato Trump.
Quali saranno gli armamenti americani che l’Europa comprerà? “Direi quelli che ci mancano”, ha osservato a Startmag Andrea Gilli, docente di Studi Strategici alla St Andrews University dettagliando in “F-35, droni per ISR a medio-lungo raggio e altri aerei per AEWC, Himars, difese anti-aeree ed eventualmente carri armati”.
Ma cosa ne sarà del “buy european” sollecitato da Bruxelles in occasione del ReArm Europe Plan/Readiness 2030?
Ecco cosa sostengono gli esperti.
CLAUSOLA DI ACQUISTO DI ARMAMENTI USA COERENTE CON LA LINEA DELL’AMMINISTRAZIONE TRUMP
Secondo Emmanuele Panero, responsabile Desk Difesa e sicurezza del Cesi, “è opportuno innanzitutto osservare come la clausola relativa all’acquisto di quelli che il presidente statunitense Donald J. Trump ha definito «centinaia di miliardi di dollari» di armamenti, appaia ancora piuttosto fumosa. La stessa è tuttavia coerente con la linea dell’Amministrazione Trump votata non solo a promuovere un ineludibile incremento della spesa europea in deterrenza e difesa, in particolare entro il perimetro Nato, ma anche di direzionarla verso l’acquisto off-the-shelf di mezzi, materiali e sistemi d’arma statunitensi, senza escludere l’iniziativa che prevedrebbe il pagamento da parte dei Paesi Ue dell’assistenza militare di Washington all’Ucraina”.
“Detto questo – prosegue Panero – la base tecnologica ed industriale della difesa statunitense è estremamente competitiva e sussiste da lungo tempo un solido legame con il mercato europeo per prodotti e soluzioni in tutti i domini ed ambienti operativi. Dalla difesa aerea, con il sistema Patriot che ha sempre più utilizzatori in Ue, passando per la componente aerea ad ala fissa, con l’F-35 anch’esso con una flotta europea in significativa crescita, fino alla capacità di bersagliamento a lungo raggio, incluso i missili da crociera Tomahawk in valutazioni da parte di alcuni Stati”.
LE CRITICITÀ
Inoltre, fa notare l’esperto del Cesi a Startmag, se da un lato “Il portafoglio prodotti statunitense è estremamente ampio e spesso idoneo a saturare con assetti comprovati i gap capacitivi delle Forze Armate dei Paesi Ue”, dall’altro lato “questo pone ovviamente delle criticità in termini di sostegno allo sviluppo ed al rafforzamento nel medio termine della base tecnologica ed industriale europea della difesa, strategicamente perseguito dal ReArm Europe Plan/Readiness 2030.”
IL PERIMETRO DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Restando nel campo di Bruxelles, il professor Gregory Alegi, saggista, docente di storia americana ed esperto di cose aeronautiche, spiega a Startmag: “Una prima osservazione è che la presidente von der Leyen non può Impegnare singoli paesi a fare alcunché perché la difesa è uno dei degli ambiti nei quali la commissione ha meno potere e si è sempre mossa, infatti, in chiave indiretta, intervenendo sulla ricerca, sulla possibilità di spese diciamo non conteggiate ai fini dei parametri di bilancio europeo eccetera”.
Dunque, “sgombriamo il campo von der Leyen non può ordinare alcun acquisto specifico” puntualizza Alegi. Dello stesso avviso è anche Alessandro Marrone, responsabile del Programma “Difesa, sicurezza e spazio” dello Iai – Istituto Affari Internazionali, secondo cui “bisogna precisare che la decisione di acquistare equipaggiamenti militari è una competenza del ministero della Difesa dei singoli Stati membri, non della commissione”. “Dunque – prosegue l’esperto dello Iai – l’Unione europea non ha competenza diretta sulle scelte di procurement di equipaggiamento militare che fanno capo esclusivamente ai ministri alla difesa degli Stati membri” ribadisce Marrone. “La commissione europea può decidere sul bilancio europeo, quindi sull’Edip (European Defence Industrial Programme), sul quadro finanziario 2028-35 in fase di negoziazione dove la proposta italiana è di avere un massimo di un terzo di valore di equipaggiamenti militari cofinanziati dall’Ue provenienti da fornitori extra Ue, e minimo due terzi da fornitori Ue. In questo terzo di Edip 28-35 potranno esserci anche delle forniture Usa a certe condizioni fissate dall’Ue, come potranno esserci componentistiche britanniche e norvegesi. Questa è l’unica leva di bilancio diretta dell’Unione europea” precisa l’esperto del think tank romano.
LA SPINTA AL RIARMO NEL VECCHIO CONTINENTE
“Per quanto riguarda invece la grandissima maggioranza delle spese militari che sono quelle nazionali – aggiunge Marrone – ogni governo decide autonomamente. Poiché c’è un cambio di paradigma dei bilanci di difesa della grande maggioranza dei paesi Ue, quindi obiettivo Nato al 3,5%, sedici paesi che hanno chiesto la clausola di salvaguardia al patto di stabilità, le richieste che arriveranno per usare 150 miliardi di presti di Safe: i bilanci della difesa sono cresciuti e continueranno a crescere nei prossimi anni come domanda, ma l’offerta europea ancora non si è adeguata, quindi sicuramente ci sarà già prima di questa trattativa sui dazi un delta di acquisti nazionali verso aziende americane”.
I SISTEMI AMERICANI
Dopodiché, per quanto riguarda gli armamenti interessati, secondo Marrone “possiamo parlare di Patriot, di F-35 e di altri equipaggiamenti militari”. Tutto ciò “principalmente da Polonia, da parte dell’Europa orientale, anche in parte della Germania e da altri paesi dell’Unione europea nel suo complesso”.
“Penso che a questo si riferisca le dichiarazioni dell’accordo e ribadisco – insiste l’esperto dell’Istituto Affari Internazionali a Startmag – è già un volume significativo. In Europa alcune industrie della difesa hanno aumentato la capacità produttiva. Vedasi anche nel nostro paese Thales Alenia Space che ha aperto la Space Smart Factory e Rheinmetall Italia che ha aperto nuovi stabilimenti, altre imprese hanno fatto meno o con più ritardo, quindi al momento c’è una limitata capacità produttiva europea e c’è un’urgenza di tanti Stati membri in Europa dell’est e del nord, ma non solo, di acquisire sul mercato e quindi anche sul mercato americano”.
I NODI DA SCIOGLIERE
Altro punto importante, secondo il professor Alegi, “è che ci manca un riferimento temporale. La cifra di cui si parla su quanti anni è spalmata? Perché in realtà ci sono già molti programmi per dotare le forze armate dei vari paesi dell’Unione di equipaggiamenti americani. Pensiamo alla proposta di una nuova tranche F-35 per l’Italia, ma anche ai sistemi di difesa aerea Arrow che ha già deciso di comprare la Germania, il cui missile è un prodotto per metà targato Boeing. Quindi la domanda è: per quanti anni? E poi che cosa ci va dentro?”.
Ecco perché, prosegue il professore Alegi, “È del tutto possibile che, diviso per tutti i paesi dell’Unione e spalmato su 5-10 anni, in realtà copra molte cose che già sono previste e che già sono in servizio. Dal punto di vista contenutistico, pensiamo soltanto ai costi di esercizio di sistemi d’arma già selezionati. Vanno dentro al paniere oppure no? Parliamo letteralmente di acquisti oppure anche di uso?”
Per chiarire, Alegi cita un esempio su tutti, la controversia di qualche mese fa sui servizi di Starlink. “Contano o contano? È difficile dare un giudizio autorevole, senza conoscere interamente il contenuto delle discussioni e i riferimenti specifici che sono stati concordati” sostiene il professore.
Prendiamo il caso dell’accordo annunciato dalla Difesa italiana con l’americana L3Harris, “la decisione risale evidentemente a tempo fa. La firma è di adesso, ma l’eventuale spesa sarà effettuata nell’arco di vigore di questo accordo sui dazi. Quindi conta, se conta, va tutto a nostro vantaggio. Nel senso che è una spesa che già avremmo fatto è che smarchiamo dal totale. Se invece fossero spese aggiuntive allora bisognerebbe fare tutto un’altro ragionamento, ma credo che sia molto poco realistico” osserva il professore.
RIGUARDO GLI INVESTIMENTI UE DA EFFETTUARE NEGLI USA
“L’ultima considerazione che farei – seguita il professore Alegi – è che mi preoccuperei altrettanto, o di più, riguardo i 600 miliardi di investimenti dell’industria europea negli Stati Uniti, perché lì ci sono due aspetti: uno legato al fatto che sarebbero investimenti in qualche modo sottratti all’Europa se si trattasse di prodotti che si possono fare ovunque. Si sta dicendo alle aziende di produrli negli Stati Uniti e non in Europa. Questo è il primo aspetto”.
“Il secondo – prosegue Alegi – è che evidentemente c’è una differenza fra gli investimenti che hanno un senso economico – faccio le cose lì perché è lì che le vendo e voglio essere vicino al mio mercato – dagli investimenti per motivi prettamente politici, senza che ci sia un particolare vantaggio economico. Faccio un esempio: Fincantieri ha da tempo deciso di investire negli Stati Uniti. Produce negli Stati Uniti e ormai da molti anni è un fornitore affidabile del Pentagono. Che Fincantieri continui ad investire sui cantieri americani rientra nella logica delle cose, perché è un fornitore delle forze armate americane, dunque è logico stare negli Stati Uniti. La stessa cosa vale in ambito Leonardo. Per gli elicotteri Agusta, dei quali da tempo ormai parliamo di quattro decenni, esiste il sito produttivo a Filadelfia che fa gli AW139 e gli AW119 in esclusiva, nel senso che è l’unico sito al mondo in cui si costruiscono quegli elicotteri, perché il mercato principale di quel tipo è negli Stati Uniti e probabilmente sarà l’unico sito produttivo del convertiplano AW609 se e quando sarà certificato. Altro è dire che obbligo queste aziende a investire negli Stati Uniti, con investimenti per prodotti che essendo di interesse globale, non hanno sede naturale negli Stati Uniti”.
In più, “mi preoccupa il fatto che su quel tipo di investimenti, si può immaginare che al di là di ogni considerazione di merito sull’accordo sui dazi, si aprirebbe una grossa battaglia politica nei singoli paesi. Cioè qualcuno in Commissione dovrebbe chiedere ai singoli paesi di tradurre in pratica questo e in qualche modo costringere le proprie aziende a investire negli Stati Uniti? E questo in un momento in cui siamo tutti in cerca di investimenti per fronteggiare le trasformazioni tecnologiche in tanti campi. A quel punto spendere in Europa o negli Stati Uniti avrebbe un effetto anche proiettato nel futuro, non soltanto nell’immediato” conclude il professore Alegi.