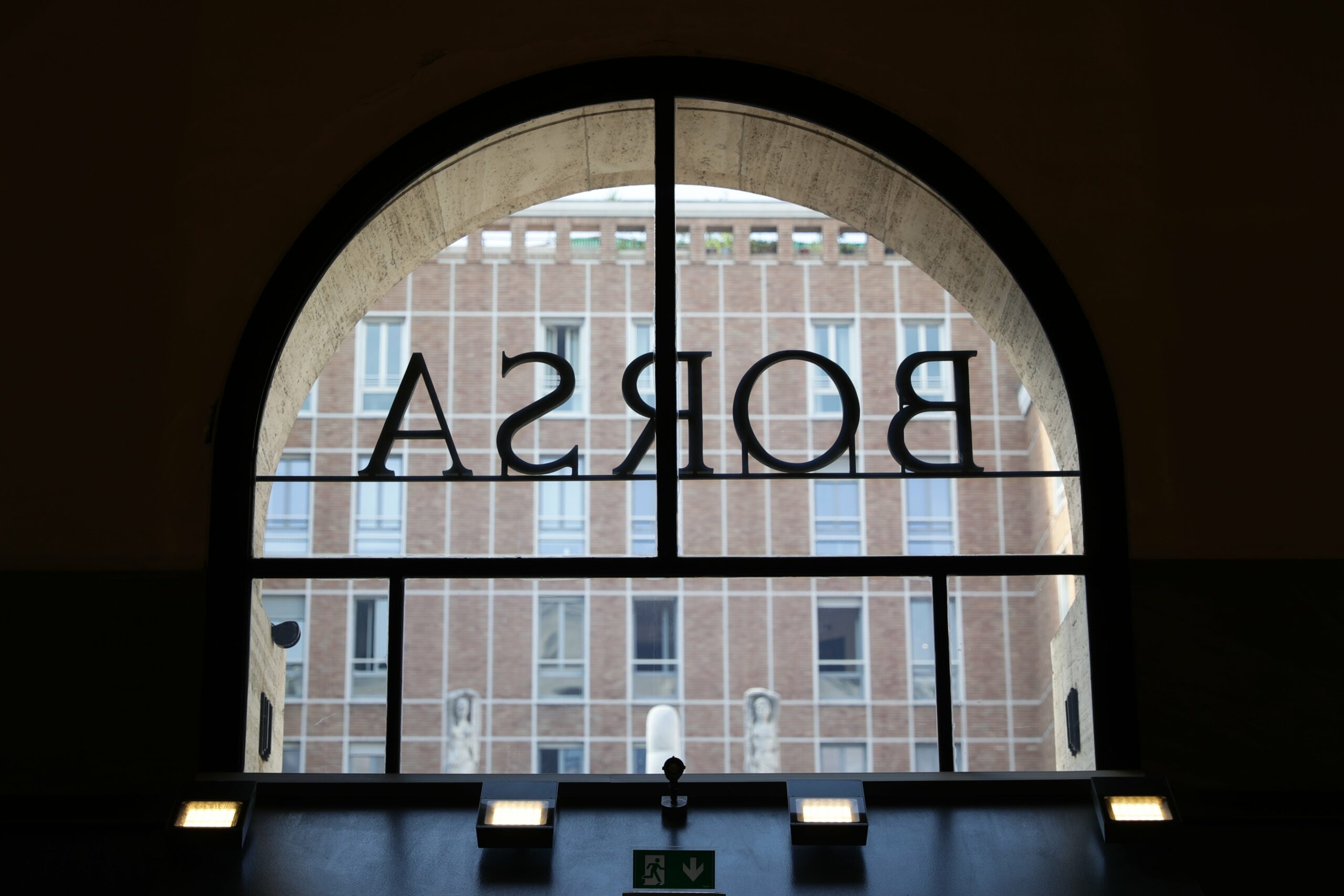Uno dei programmi più controversi della US Navy negli ultimi anni è sicuramente quello relativo ai cacciatorpediniere della classe Zumwalt. Un programma nato con grandi aspettative, che avrebbe dovuto svilupparsi su numeri importanti in quanto a unità da costruire e, infine, potenzialmente capace di portare con sé significative innovazioni.
La realtà invece è che molto di tutto ciò è andato deluso, fino a trasformare il tutto in un (quasi) fallimento. Un fallimento però che ha ancora qualche possibilità di essere mitigato; nella misura in cui per queste unità è prevista una importante modifica che appare destinata a cambiarne non solo alcune caratteristiche ma, di fatto, anche il loro stesso destino. Rendendolo cioè meno “amaro”.
Lo sviluppo questi nuovi cacciatorpediniere è stato complesso e condizionato sia da una concezione avvenuta in un momento particolare, sia da tempi troppo lunghi. I suoi primi passi risalgono infatti agli anni 90; anche se la accelerazione verso una puntuale definizione delle sue caratteristiche si ha poi nei primi anni 2000. Alla base delle capacità di queste nuove piattaforme viene posto un requisito operativo in qualche modo innovativo; ovvero, una maggiore enfasi sui contesti “littoral”,
In altri termini, non il classico cacciatorpediniere pensato per le altrettanto classiche operazioni in alto mare; quanto piuttosto, una nave pensata per l’appoggio a quelle che sono destinate a svolgersi in prossimità della costa. Da qui discendono 2 delle caratteristiche chiave degli allora futuri caccia della classe Zumwalt: una spiccata “stealthness” (cioè una ridotta segnatura radar) e, soprattutto, 2 potenti pezzi di artiglieria.
Il programma però fin da subito si caratterizza per problemi vari e per i ripensamenti della stessa US Navy. Un solo dato su tutti, utile a dimostrare quale confusione abbia finito per attraversarlo: dalle 32 unità inizialmente previste, alla fine la Marina Americana decide di troncarlo a sole 2 navi. Solo un intervento del Congresso porterà il numero finale a 3.
Ma il danno, per così dire, ormai era fatto; gli enormi costi di ricerca e sviluppo e quelli legati alla costruzione di sole 3 unità (poi realizzate dai cantieri Bath Iron Works, con la collaborazione degli attuali Huntington Ingalls Industries, HII) hanno fatto schizzare quello complessivo dell’intero programma a oltre 24 miliardi di dollari. In pratica, 8 miliardi per ogni singolo cacciatorpediniere; a oggi.
Certo, a fronte di questa ingente spesa va riconosciuto che le caratteristiche e le capacità finali di queste navi sono notevoli, al pari delle loro dimensioni: 190 metri di lunghezza per quasi 25 di larghezza, il tutto per un dislocamento di circa 15.600 tonnellate. A fronte di queste dimensioni, come detto una segnatura radar ridotta, grazie a forme di scafo innovative e a una grande sovrastruttura attentamente sagomata, al cui interno sono poi racchiuse non solo alcuni importanti locali per le operazioni, ma anche sensori, antenne nonché altri apparati della nave stessa. Oltre all’hangar per elicotteri (pilotati e non) imbarcati su di essa.
Nonostante le dimensioni davvero importanti, un’altra serie di innovazioni introdotte su queste unità hanno consentito di contenere il numero degli uomini di equipaggio ad appena 147 (più altri 28 del distaccamento aeronautico). Tra queste, un sofisticato sistema di controllo della piattaforma (con annessi apparati vari di sicurezza) Anche se poi, l’elemento più distintivo è rappresentato da un ancora più sofisticato sistema di gestione del combattimento, noto come Total Ship Computing Environment Infrastructure (TSCEI) che, di fatto, trasforma queste navi in enormi “computer galleggianti”.
Ugualmente innovativo anche l’impianto propulsivo, costituito da 2 turbine a gas principali e 2 ausiliarie che insieme forniscono la potenza di ben 78 MW; tutte queste turbine in realtà funzionano da generatori di corrente che alimentano i motori elettrici (i quali poi danno la propulsione alla nave) e, al tempo stesso, forniscono la corrente elettrica (per le utenze di bordo). Notevole dunque il quadro in termini di prestazioni, simboleggiato dal dato della velocità massima di oltre 30 nodi.
In linea con il percorso difficile di queste unità, anche sul fronte dei sensori principali si sono registrate delle “turbolenze”; in origine infatti, gli Zumwalt avrebbero dovuto essere dotati di 2 differenti radar ma la necessità di ridurre i costi ha portato alla decisione di eliminarne uno. E così, gli Zumwalt stessi ora sono dotati del solo AN/SPY-3, che svolge varie funzioni. Per rimanere in ambito sensori, degna di nota la suite sonar, dotata di apparati fissi montati a scafo e un altro rimorchiato per estendere il raggio di scoperta nei confronti di minacce subacquee.
Ma un altro aspetto distintivo di questi cacciatorpediniere è rappresentato dall’armamento; in particolare dalle 80 celle di lancio verticali MK 57 che possono contenere missili per la difesa aerea (quali gli ESSM e gli SM-2 Block IIIA), altri in funzione antinave/attacco contro obiettivi terrestri (e cioè i Tomahawk o eventuali altri futuri ordigni simili) e, ancora, missili per il contrasto di sottomarini (VL-ASROC). Ma l’aspetto più interessante di queste celle di lancio è che sono state spostate sui fianchi della nave, differentemente dalla loro tradizionale sistemazione sulle navi moderne.
E il motivo è presto detto; il bisogno di fare spazio ai 2 potenti pezzi di artiglieria Advanced Gun System (AGS) da 155 mm e ai relativi depositi di munizioni sottostanti. Proprio questi pezzi avrebbero dovuto essere l’elemento più importante della nave, perché teoricamente capaci di sparare proiettili autopropulsi e guidati (gli LRLAP, Long Range Land Attack Projectile) a grandi distanze; anche intorno alle 100 miglia. In realtà le cose sono andate diversamente poiché il costo esorbitante di questi proiettili ha portato alla cancellazione della loro produzione e, di conseguenza, alla completa inutilità degli AGS medesimi.
Ma poi la svolta; la US Navy, al pari delle altre Forze Armate Americane, intuisce le potenzialità offerte dai nuovi missili ipersonici e cioè quegli ordigni capaci di volare a velocità superiori a Mach 5. E’ così che nel 2018 avvia i primi studi nell’ambito di un programma congiunto con lo US Army, allo scopo di sviluppare un missile sostanzialmente uguale e adattato poi per le specifiche esigenze dei 2 futuri utilizzatori. Per la US Navy, il missile in questione assume così la definizione di “Conventional Prompt Strike (CPS) system” e sarà un ordigno dalle dimensioni e prestazioni impressionanti: 12 metri di lunghezza circa, peso al lancio di quasi 7.500 kg, portata stimata in almeno 3.000 km e velocità (sempre stimata) di ben Mach 17!
Una volta superato il passaggio legato allo sviluppo del missile in sé, quello successivo non poteva che essere rappresentato dalla scelta della piattaforma che lo avrebbe ospitato; ed ecco l’intuizione. Ovvero: rimuovere i 2 AGS degli Zumwalt (e i sottostanti depositi delle munizioni) per installare al loro posto i nuovi missili ipersonici. E infatti questo è quello che accadrà. La prima unità è infatti appena giunta nei cantieri HII dove (nel giro di un paio di anni) avverrà tale trasformazione. Via gli AGS e ciò che a essi è collegato; al loro posto 4 cosiddetti Advanced Payload Modules (APM) che conterranno a loro volta 3 CPS ciascuno, per un totale di 12 armi.
A seguire, lo stesso percorso sarò affrontato dalle altre 2 navi della classe; così da permettere alla US Navy non solo di poter tornare a disporre di unità pienamente operative ma, al tempo stesso, di poter attraversare la nuova “frontiera” di quei missili ipersonici destinati a rivoluzionare i campi di battaglia del futuro. Dato che in un futuro prossimo, questi ordigni saranno ospitati anche dai sottomarini nucleari della classe Virginia, conferendo così alla Marina americana stessa la capacità di colpire bersagli a grandi distanze in poco tempo; insomma, un “game changer”.