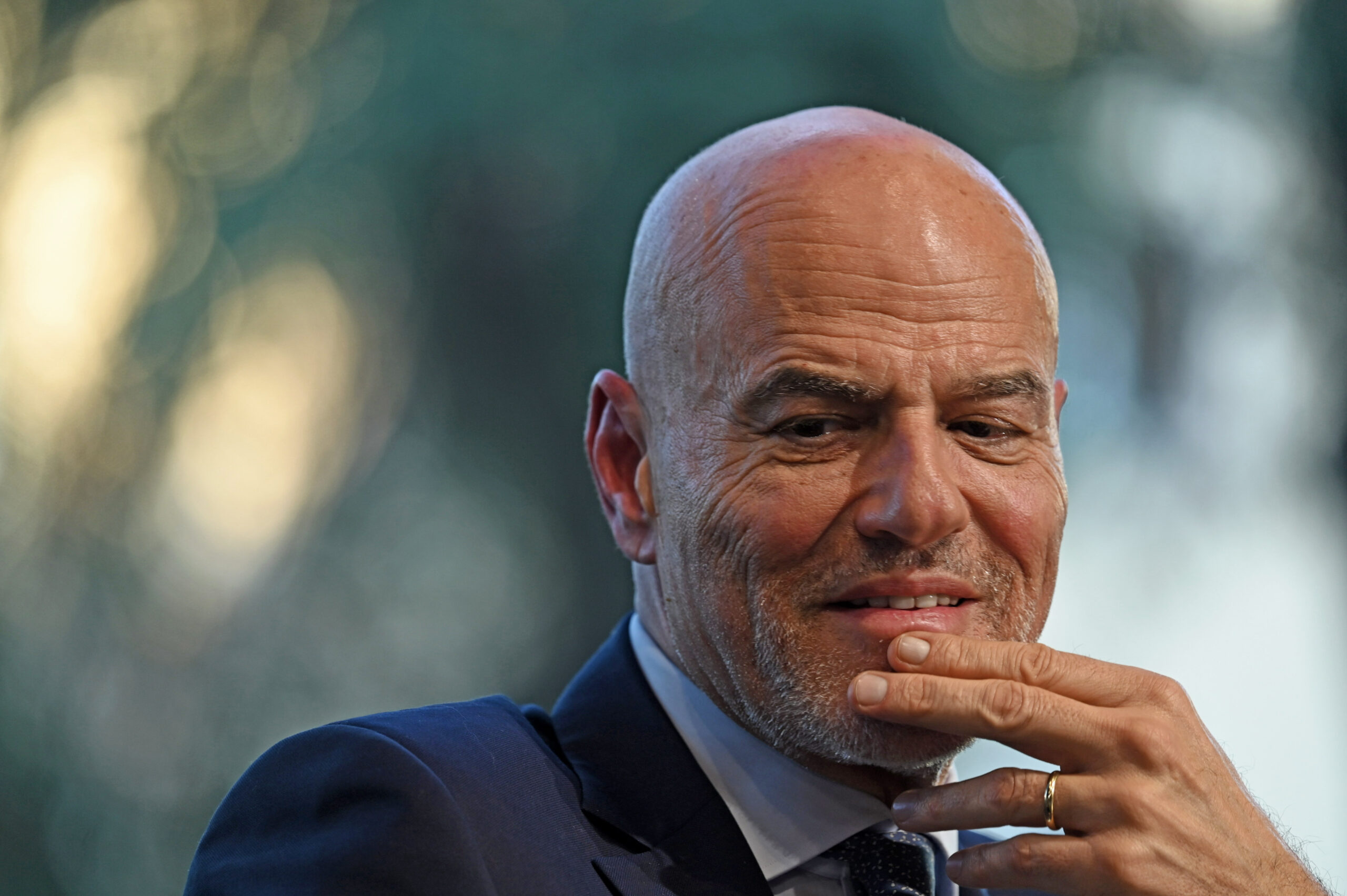L’Italia è uno dei principali paesi esportatori a livello globale ed è il primo in Europa per volume di merci movimentate tramite il cosiddetto short sea shipping, ovvero il trasporto marittimo su brevi distanze. I porti rappresentano un’infrastruttura cruciale per il nostro sistema economico, dato che la nave è il mezzo utilizzato per muovere il 28 per cento del valore dell’import-export italiano il 50 per cento della quantità.
Il settore italiano della portualità vale 8,1 miliardi di euro, oltre il 17 per cento dell’intera “economia del mare” (blue economy) e l’anno scorso i nostri porti hanno movimentato quasi 475 milioni di tonnellate di merci (il 3,2 per cento in meno del 2022, una conseguenza del rallentamento economico). Sono italiani sette dei primi dieci porti europei roll-on/roll-off (cioè attrezzati per il carico e lo scarico di merci tramite veicoli con ruote, semplificando) nel mar Mediterraneo.
COME RILANCIARE LA COMPETITIVITÀ DEI PORTI ITALIANI
Ciononostante, la competitività del sistema portuale italiano è intaccata da un’efficienza logistica non altissima. Il tempo medio di attesa delle navi nei nostri porti (1,28 giorni) è ad esempio molto più alto rispetto alla Spagna (0,86 giorni) e ai Paesi Bassi (0,54), stando ai dati esposti nel rapporto Le nuove sfide dei porti dell’area euro-mediterranea. La crisi nel Mar Rosso e le trasformazioni imposte dai modelli green del centro studi SRM, collegato a Intesa Sanpaolo.
Secondo lo studio, le autorità italiane dovrebbero inoltre lavorare al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture per l’intermodalità, definite “cruciali per il rilancio e lo smistamento dei carichi portuali”: il 20 per cento delle imprese manifatturiere ricorre infatti all’intermodale. Non tutti i porti italiani sono collegati alla rete ferroviaria nazionale.
Oltre all’integrazione con le ferrovie e le altre modalità di trasporto delle merci, lo studio invita allo sviluppo delle aree retroportuali “attraverso la piena implementazione della Zona Economica Speciale del Mezzogiorno (ZES) e delle Zone Logistiche Speciali (ZLS)”, che fungeranno da stimolo agli investimenti e all’insediamento di nuove imprese nei pressi dei porti.
In ultimo, bisogna allineare i porti italiani alla transizione energetica, promuovendo l’elettrificazione delle banchine (in gergo cold ironing), l’utilizzo di fonti rinnovabili e lo sviluppo di infrastrutture per l’accoglienza delle navi alimentate a gas liquefatto o con carburanti alternativi come l’ammoniaca, l’idrogeno e il metanolo.
L’ENERGIA
Il segmento energy è preponderante per il 35 per cento dei porti italiani, che potrebbero dunque venire trasformati in dei poli logistico-energetici a basse emissioni, specialmente in un’ottica di approfondimenti dei contatti con i paesi del Nordafrica.
I PORTI DEL NORD ITALIA
I porti del nord Italia, ovvero quelli tra Savona e Livorno sul versante tirrenico e tra Ravenna e Trieste sul versante adriatico, valgono circa la metà dei traffici complessivi a livello nazionale, il 40 per cento dei traffici rotabili e l’80% del traffico container gateway misurati in unità di carico.
Nello studio si afferma che “l’operatività della portualità del Nord Italia e la domanda di trasporto che gli scali dell’area soddisfano con regolarità risultano, quindi, fortemente connesse al tessuto economico di riferimento […]. La combinazione fra la posizione geografica dei porti e la conformazione del territorio del Nord Italia determina, inoltre, l’affermarsi di una rilevanza sovraregionale dei singoli scali, in particolare di quelli liguri, che, ben al di là dei confini regionali, rappresentano una porta di collegamento fra le principali aree produttive del Paese e le origini e destinazioni oltremare”.
IL RUOLO DEL PNRR
Nello studio si legge anche che gli investimenti legati al PNRR possono rappresentare “una grande opportunità per rimuovere definitivamente i colli di bottiglia che ancora interessano il trasporto merci da/per i porti e per consentire una effettiva e maggiore penetrazione nei mercati del sud Europa”, attraverso in particolare il potenziamento dei collegamenti tra il cosiddetto “ultimo miglio portuale” e le ferrovie.
LE DIFFICOLTÀ SULLE TRATTE A LUNGO RAGGIO
Un rapporto di Cassa depositi e prestiti dell’aprile 2023 spiegava come l’Italia stia faticando a intercettare i flussi di traffico marittimi sulle tratte a lungo raggio: tra il 2004 e il 2021, infatti, l’incidenza del traffico transhipment – cioè la movimentazione di container da nave a nave – è scesa dal 48 al 36 per cento del totale nazionale.
I porti italiani hanno subìto in particolare la competizione del Pireo, degli scali spagnoli (Valencia e Algeciras) e di quelli nord-africani di Port Said e Tanger Med, che hanno invece migliorato sensibilmente il loro posizionamento all’interno del network del commercio internazionale.