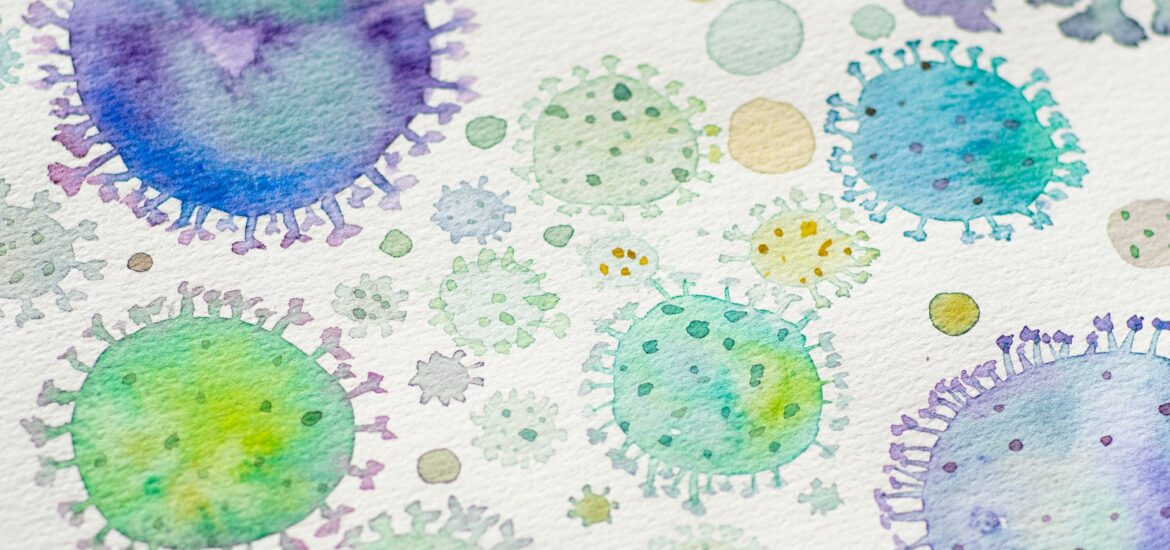La notizia è di questi giorni. Un’anziana di 82 anni residente a Roma è morta all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi (Latina) per il West Nile Virus (WNV) che provoca la cosiddetta “Febbre del Nilo” (West Nile Fever). E nella provincia di Latina ci sono, al momento, altri sei casi di infezione dal virus. Tra questi un uomo di 63 anni e uno di 72 sono in condizioni critiche con sintomi neurologici per la presenza di patologie concomitanti. Sempre in provincia di Latina sarebbe morto anche un cavallo.
Il pensiero va subito alla recente pandemia. Come in quel caso, parliamo di un virus con un genoma ad RNA. Sono molti i virus di questo tipo che in questi ultimi anni ci hanno fatto allarmare, a partire da quelli che hanno mietuto più vittime: HIV e Covid. A differenza di questi, WNV appartiene alla famiglia Flaviviridae che comprende anche altri virus pericolosi per la nostra salute quali Zika, Dengue e il virus della febbre gialla. E, come leggiamo sul sito dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS), a differenza di Covid non si trasmette per contatto diretto tra uomini, ma attraverso la puntura delle zanzare del genere Culex, vettore primario di molte malattie virali e parassitiche.
Il virus è stato isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, ma si è diffuso verso Nord a causa del cambiamento climatico portando a focolai in tutta Europa e nel Nord America. In particolare l’aumento delle temperature e delle precipitazioni, favorendo la proliferazione delle zanzare, ha alimentato diffusione del virus in tutta Europa, con focolai annuali nelle regioni mediterranee e centrali dagli anni ’90, in particolare in Romania, Italia, Spagna e Grecia. Recentemente si è osservato un aumento anche nel nord Europa (Paesi Bassi, Germania) e in Ungheria è stato registrato il più grande focolaio europeo del 2022 che ha causato 1.340 casi e 104 decessi. Il virus infetta anche altri mammiferi, soprattutto equini. Il periodo di incubazione dal momento della puntura della zanzara varia fra 2 e 14 giorni.
Nell’80% dei casi la persona infetta non mostra alcun sintomo mentre la quasi totalità del restante 20% presenta sintomi leggeri: febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Questi sintomi possono durare pochi giorni, in rari casi qualche settimana, e possono variare molto a seconda dell’età della persona. Solo uno ogni 150 infetti mostra sintomi gravi a carico del sistema nervoso centrale (encefaliti o meningiti). Tra queste il tasso di mortalità è di 1/10 (ovvero meno di una persona infetta su mille). Le persone più a rischio sono, come nel caso del Covid, quelle più fragili come anziani o quelle con patologie croniche.
La crescente minaccia del WNV sottolinea necessità urgente di mettere a punto terapie antivirali. Che al momento, tuttavia, non sono disponibili ancora e quindi la miglior difesa è la prevenzione, che consiste soprattutto nel ridurre l’esposizione alle punture di zanzare sia grazie ai trattamenti antizanzare da parte dei comuni che ai comportamenti dei singoli cittadini.
Negli ultimi anni sono stati compiuti progressi significativi nello sviluppo di molecole che inibiscono l’attività di alcune proteine di WNV. La loro applicazione clinica, però, richiede passi ulteriori come lo sviluppo di modelli animali e in vitro specifici per WNV, sulla scorta di quelli già disponibili per altri flavivirus come YFV, DENV e ZIKV. Con il crescente verificarsi di casi, è urgente arrivare allo sviluppo di modelli sperimentali per corroborare i risultati biochimici e accelerare lo sviluppo di antivirali efficaci. Tali sforzi potrebbero anche contribuire alla terapia per altri flavivirus.
Per quanto riguarda i vaccini, rimane moltissima strada da fare. Alcuni sono in fase di sviluppo ma ancora agli stadi iniziali. Sicuramente, la cattiva reputazione dei vaccini tra ampi settori dell’opinione pubblica, in particolare per i vaccini ad RNA che sono quelli più veloci da sviluppare, non favorisce lo sviluppo di questi potenti strumenti di prevenzione.