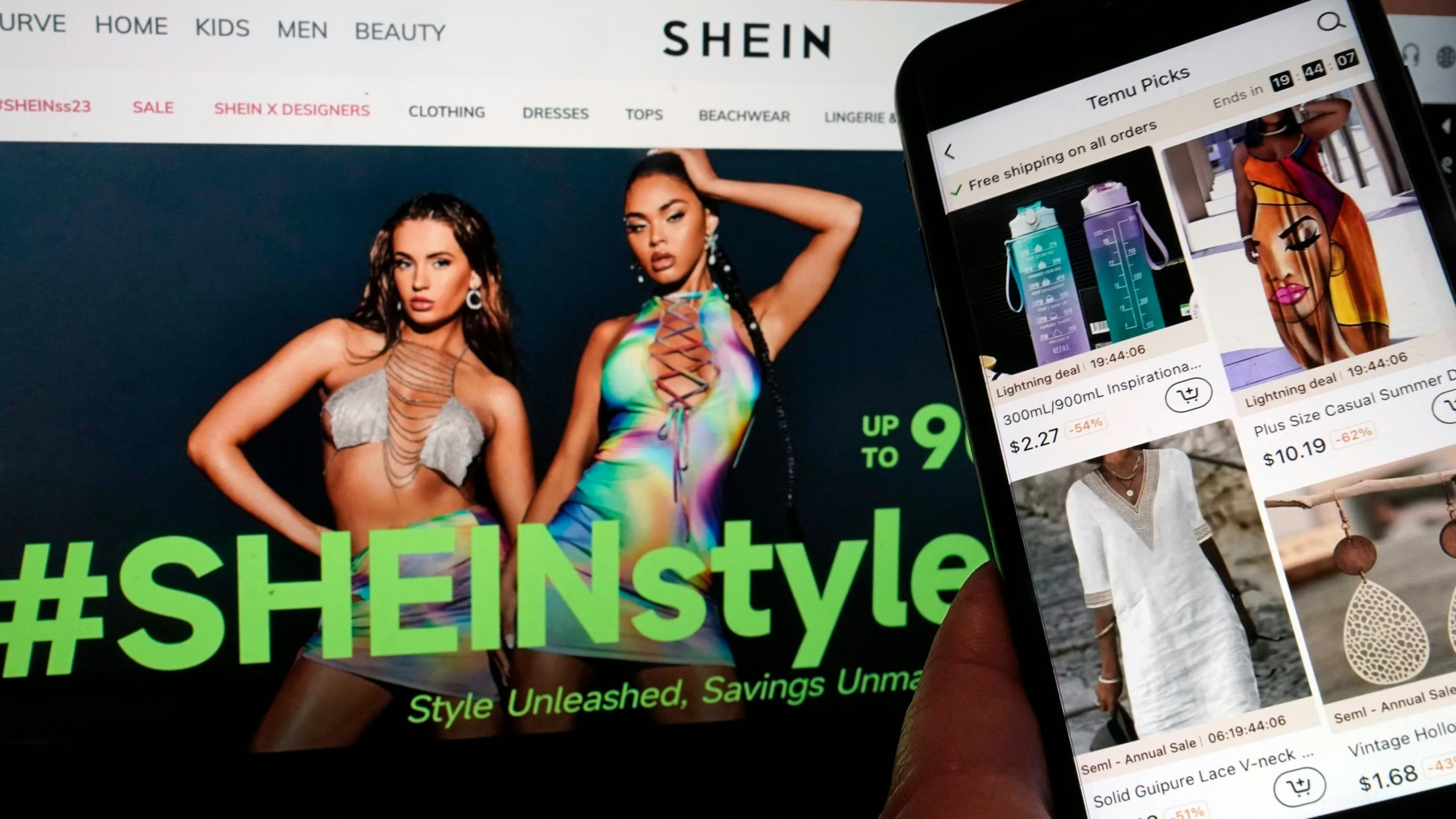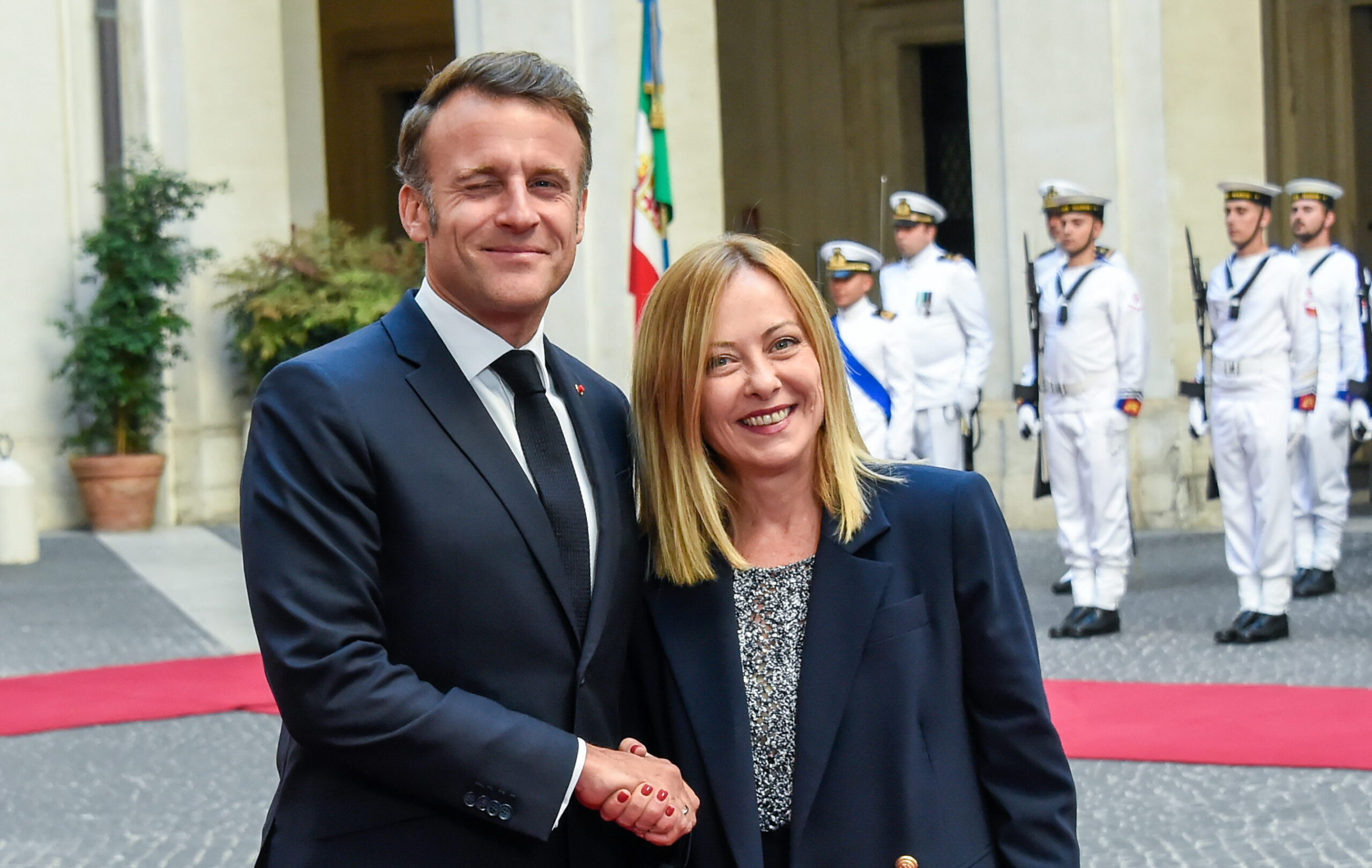Siamo quasi al giro di boa di Ferragosto, passato il quale inizia il rientro dalle vacanze ma già si intravedono segnali di un dibattito, quello sulla scuola italiana, che si preannuncia acceso. A segnarlo è un punto di svolta che ha messo al centro il suo rito di passaggio più emblematico: l’esame di Stato.
Da un lato ci sono state le proteste di alcuni studenti che, in aperta polemica con le modalità di valutazione, si sono rifiutati di sostenere i colloqui orali; dall’altro, dalle dichiarazioni del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, circa la volontà di ripristinare la storica denominazione di “Esame di Maturità”, potenziandone il carattere valutativo. In questo clima di rinnovata tensione tra tradizione e istanze di cambiamento, il confronto si è arricchito con un dialogo a distanza, sulle pagine del Corriere della Sera, tra Giovanni Lo Storto, già Direttore Generale dell’Università Luiss Guido Carli fino al 2024, e lo stesso Ministro Giuseppe Valditara, che appare incentrato sulla vera missione della scuola: un luogo di obbedienza o un motore per la crescita del talento e della responsabilità?
Questo dibattito ci offre l’occasione per inquadrare la riforma annunciata dal Ministro — volta a ripristinare la denominazione di “Esame di Maturità” e a rafforzare il valore selettivo — non come un semplice ritorno al passato, ma come una preziosa opportunità per riflettere su cosa significhi davvero la parola “maturità” in una scuola moderna che voglia essere autenticamente di tutti, nessuno escluso.
La proposta solleva infatti interrogativi cruciali sulla sua compatibilità con il diritto all’inclusione. Qualsiasi riforma deve infatti misurarsi con il concetto di LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni), ovvero, come definito dal rapporto finale pubblicato nel dicembre 2024 dal CLEP – Comitato Tecnico Scientifico sui Livelli Essenziali delle Prestazioni, organismo presieduto dal Prof. Sabino Cassese, incaricato di individuare e definire i LEP come quelle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale per superare i divari territoriali.
Proprio il rapporto CLEP classifica in modo inequivocabile il “sostegno agli alunni con disabilità” come un “LEP a beneficio individuale”, una prestazione fondamentale la cui quantità e qualità devono essere misurabili e garantite.
Questa prospettiva àncora il dibattito a un presupposto non negoziabile: il pieno rispetto degli impegni giuridici che l’Italia ha assunto a livello internazionale, prima ancora che nazionale. L’iniziativa ministeriale non può prescindere dalla piena attuazione della CRPD (Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità), la quale impone l’obbligo di garantire un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli. Questo principio è rafforzato dagli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione, che impegnano lo Stato a rimuovere ogni ostacolo che limiti di fatto la piena partecipazione alla vita scolastica. Sulla stessa direttrice si pone la visione dell’ex Ministro dell’Istruzione, la Senatrice Mariastella Gelmini, che non ha dubbi sulla direzione da seguire che definisce “netta”: «Nessun passo indietro sui diritti, dunque, ma avanti per una scuola che sappia garantire a tutti gli studenti, inclusi quelli con disabilità, la possibilità di partecipare pienamente e autonomamente alle attività educative e alla vita scolastica, superando barriere architettoniche, didattiche e relazionali che purtroppo ancora permangono». Una posizione quella della Senatrice Gelmini che OSPERDI – Osservatorio Permanente sulla Disabilità – Ente del Terzo Settore, sostiene convintamente.
Cogliere questa occasione significa allargare il concetto stesso di maturità oltre la sola dimensione nozionistica. L’ex Ministro dell’Istruzione, il Prof. Marco Bussetti, rispetto alla proposta del suo successore, con attenzione al tema della disabilità, fa osservare che «Cambiare un termine non significa rinunciare alla vocazione inclusiva della scuola, né, tanto meno, alla sua missione educativa, culturale e civica» e ci offre una distinzione chiave, affermando che «Parliamo, in ogni caso, di una “maturità” scolastica e formativa. La maturità personale, intesa come equilibrio e consapevolezza di sé, rappresenta invece un traguardo individuale e non spetta alla scuola certificarlo». La visione offerta apre lo spazio a una valutazione più ricca, che tenga conto anche delle competenze non cognitive, come rimarcato dalla senatrice Gelmini, la quale ricorda che «l’apprendimento resta fondamentale, ma la scuola di oggi deve saper valorizzare anche l’empatia, il problem solving, la creatività, la capacità di fare squadra». Sono queste le peculiarità indispensabili ai giovani per prepararsi alle sfide della vita.
Ma è proprio qui, nel passaggio dall’aspirazione alla realtà, che i dati del rapporto ISTAT del 18 marzo 2025 sulla scuola e disabilità, diventano un monito ineludibile. Se la maturità è intesa come capacità e piena autonomia, chi rischia di restare escluso da questo traguardo?
L’ISTAT ci informa che nelle scuole italiane sono presenti quasi 359.000 alunni con disabilità. La loro condizione è eterogenea: il problema più diffuso è la disabilità intellettiva, che nella scuola secondaria di secondo grado riguarda ben il 52% di questi studenti; seguono i disturbi dello sviluppo psicologico (35%) e i disturbi dell’apprendimento e dell’attenzione (quasi un quinto). Per questa vasta e complessa popolazione studentesca, il rischio di esclusione è concreto: il 53% di loro segue un percorso differenziato che non porta al conseguimento del diploma. Il sistema che dovrebbe sostenerli, tuttavia, mostra crepe profonde: il 57% degli alunni cambia insegnante di sostegno ogni anno , il 27% dei docenti non ha una formazione specifica e la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) subisce un ritardo per un quarto degli studenti delle superiori.
Per questi studenti, più che per altri, l’esame di maturità non può essere un traguardo isolato, ma deve rappresentare il culmine di un percorso di accompagnamento verso il proprio progetto di vita e di autonomia possibile. Così assumono un valore fondamentale i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e l’ISTAT evidenzia come questi percorsi possano rappresentare “un’occasione per sviluppare l’autonomia e le competenze lavorative di base”. L’Istituto di Statistica, tuttavia, segnala che anche qui emergono divari territoriali: le esperienze dirette in azienda, cruciali per questo scopo, coinvolgono il 61% degli studenti al Nord ma la percentuale si riduce drasticamente scendendo lungo la penisola, a favore di percorsi prevalentemente scolastici al Mezzogiorno (49%).
Potenziare questi percorsi di orientamento diventa quindi un tassello imprescindibile per tradurre l’ideale di “maturità” in un progetto di vita concreto per ogni studente.
La vera sfida della riforma proposta dal Ministro Valditara, quindi, è coniugare la valorizzazione del merito con la garanzia dell’equità. Roberto Speziale, Presidente di ANFFAS – Associazione Nazionale Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo, centra il punto nodale per gli studenti con disabilità intellettive, affermando che «è nostro fermo convincimento che il merito debba essere misurato tenendo conto del progresso di ciascun alunno rispetto agli obiettivi del suo PEI». Questa non è una richiesta di minor rigore, ma di una valutazione più intelligente e personalizzata. La sua preoccupazione si concentra sulla necessità di garanzie concrete, chiedendosi: «Si riuscirà a garantire, senza ambiguità, la centralità del PEI (ndr Piano Educativo Individualizzato) quale riferimento vincolante per la definizione delle prove e per la valutazione dell’elemento della “maturità”?».
La strada da percorrere, suggerita dalle diverse voci, sembra dunque quella di un potenziamento reciproco: la reintroduzione del termine “Maturità” può diventare il motore per rafforzare i processi inclusivi, a patto che questi ultimi siano visti come la condizione necessaria per una valutazione seria e completa di ogni studente. Significa investire per colmare le lacune evidenziate dai dati, assicurando, come auspicato da Bussetti, «una formazione adeguata agli insegnanti di sostegno» e attivando «tutti i provvedimenti necessari per garantire un numero sufficiente di docenti specializzati».
Il bivio per la scuola italiana, dunque, ci è chiaro. Il ritorno all’Esame di Maturità può rappresentare una leva simbolica e culturale di grande valore, ma il suo successo si misurerà sulla sua capacità di diventare un catalizzatore per il potenziamento di una scuola realmente inclusiva. L’obiettivo non è criticare un’etichetta, ma riempirla di un significato nuovo e universale, assicurando che il raggiungimento della “maturità” — intesa come capacità e piena autonomia nell’affrontare le sfide della vita — diventi un traguardo possibile per ogni studente. Perché, in fondo, una scuola davvero matura è una scuola che, per usare le parole dell’ex Ministro Bussetti, «non lascia indietro nessuno».