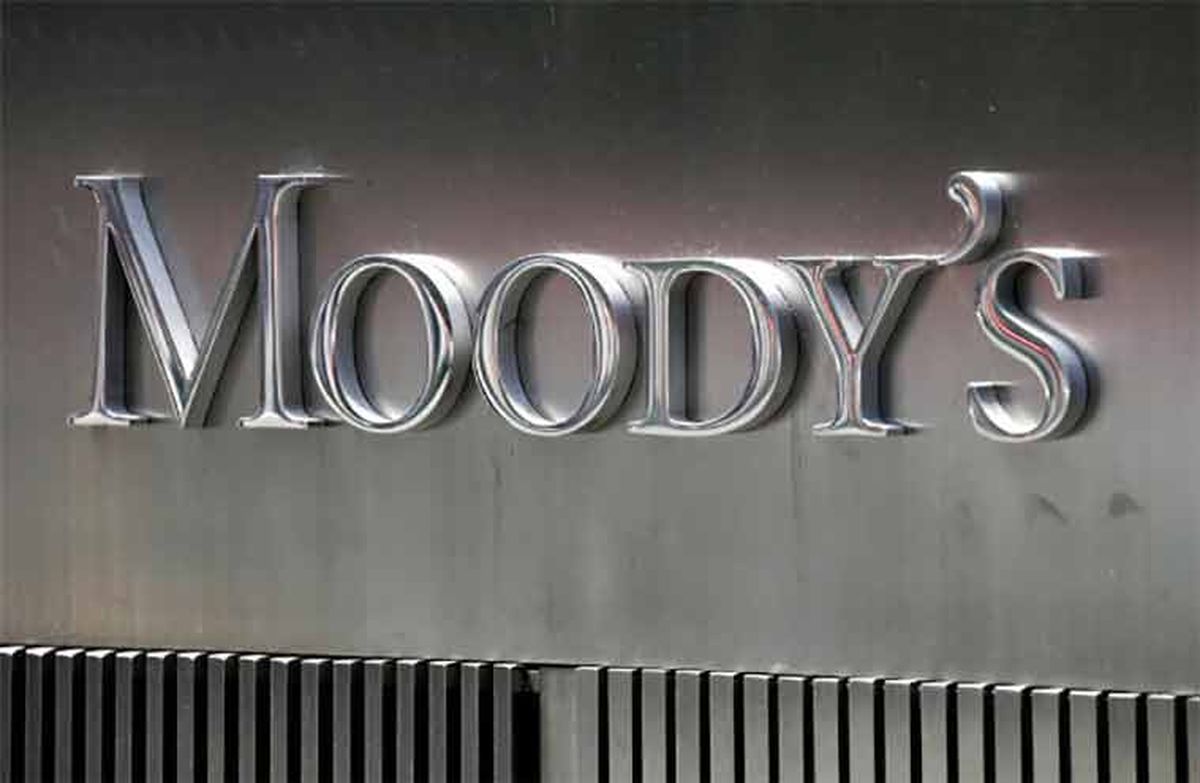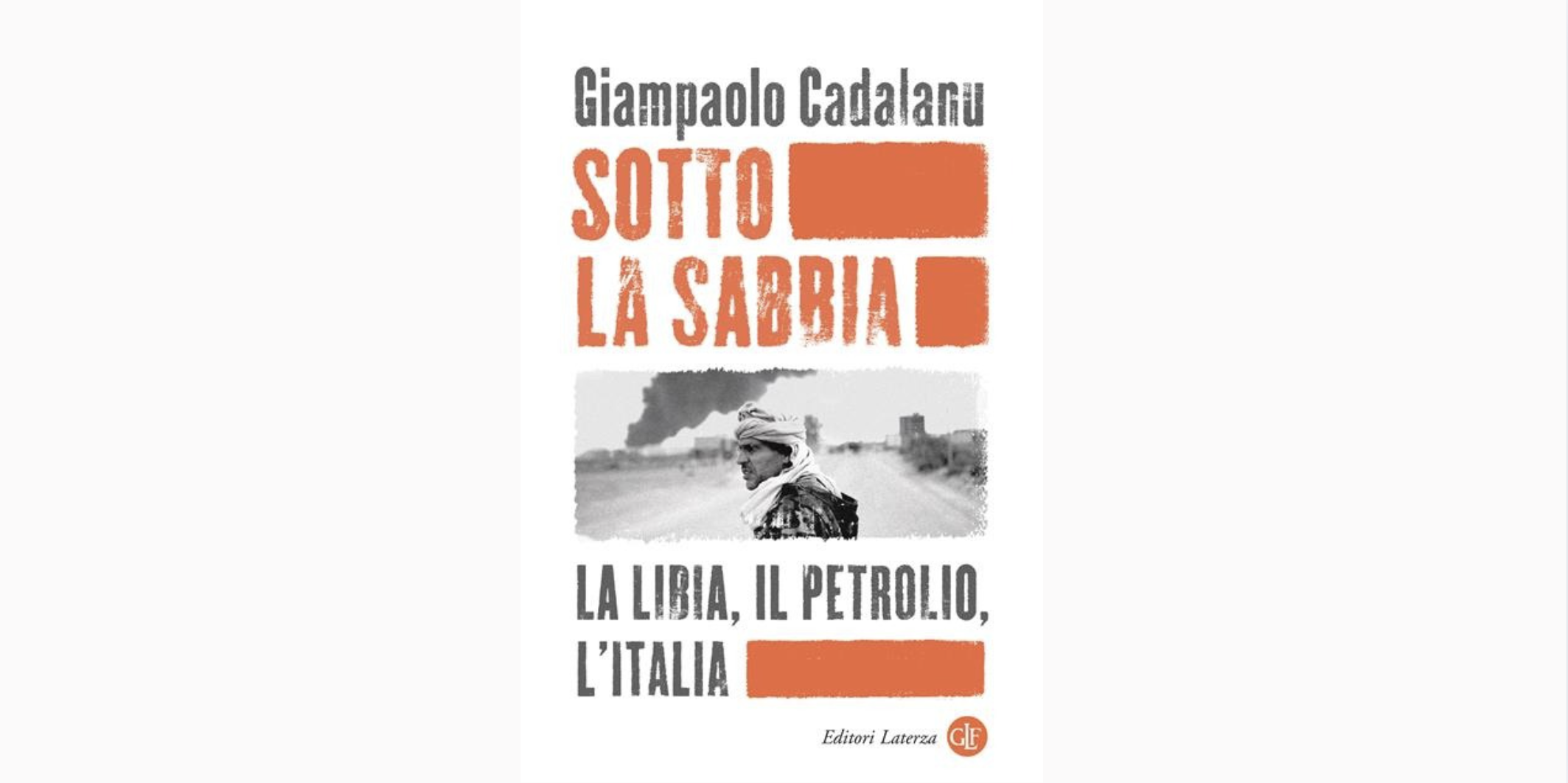C’è un elementare principio che, salvo eccezioni, si applica nel mondo degli affari. Si stendono tappeti rossi ai clienti e si sfrutta la concorrenza tra i fornitori.
Evidentemente a Bruxelles non hanno capito che, con 198 miliardi di surplus commerciale delle merci con gli USA (a fronte di 147 miliardi col resto del mondo), gli USA sono il loro principale cliente e qualsiasi azione ritorsiva verso le decisioni di Trump può solo diventare un boomerang.
Purtroppo non è però la prima volta che la UE dimostra un’eccezionale capacità di farsi del male da sola. La disputa sulle relazioni commerciali con gli USA, con dazi e contro-dazi minacciati, applicati e sospesi, rischia di essere l’ennesimo episodio della serie.
Infatti, in un’intervista rilasciata il 10 aprile al Financial Times Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, ha dichiarato che – qualora i negoziati con il presidente Donald Trump per porre fine alla sua guerra dei dazi contro l’Europa fallissero – è pronta a utilizzare misure commerciali drastiche contro gli Stati Uniti, inclusa l’imposizione di dazi su aziende digitali americane come Amazon, Google e Facebook. In tal caso, l’UE potrebbe espandere il conflitto commerciale al settore dei servizi, introducendo, ad esempio, un’imposta sui ricavi pubblicitari digitali.
Von der Leyen ha sottolineato che le misure esatte dipenderanno dai negoziati, ma potrebbero includere dazi sul commercio di servizi, un settore in cui gli Stati Uniti vantano un surplus significativo con l’UE. Queste azioni però rischiano di essere un clamoroso ennesimo boomerang. Perché non bisogna dimenticare che tale surplus Usa verso la UE (108 miliardi nel 2023, contro un disavanzo della bilancia commerciale delle merci pari a € 198 miliardi nel 2024) è determinato dall’eccellenza tecnologica degli Usa che rende tali servizi relativamente insostituibili. Come si insegna al primo anno di economia, quando la domanda è rigida, l’effetto di qualsiasi misura penalizzante per i fornitori Usa di quei servizi, sarebbe un immediato e netto aumento dei prezzi per imprese e famiglie europee.
Tali servizi sono così essenziali che le Big Tech Usa godono pure di un regime fiscale di estremo favore. Infatti la von der Leyen dovrebbe sapere che tale surplus è anche l’effetto della presenza nella Ue di (almeno) tre paradisi fiscali come Irlanda, Lussemburgo e Olanda, dove tutte le Big Tech Usa hanno insediato filiali, società controllate e stabili organizzazioni.
Soprattutto Irlanda e Lussemburgo vivono dell’interscambio di servizi con gli USA, con una incidenza sul PIL rispettivamente del 45% e del 27% (contro il 4% dell’intera UE). Colpire i servizi Usa significherebbe ridurre sul lastrico quei Paesi.
Nike, McDonald, Google, Apple, Amazon, Microsoft, tutte le più prestigiose banche d’affari e società farmaceutiche hanno sfruttato per anni un ingegnoso e molto complesso sistema di pianificazione fiscale aggressiva (un modo elegante per definire l’evasione fiscale delle grandi imprese). In sintesi, le società con sede in quei tre Paesi, a vario titolo facenti capo alle grandi corporation Usa, erano titolari dei diritti di sfruttamento dei brevetti, marchi commerciali, software e qualsiasi altro bene di natura simile, a fronte dei quali pagavano somme molto modeste alla concedente USA, quasi sempre soggetta a un regime fiscale più oneroso. Le due stabili organizzazioni di Apple in Irlanda, prima del contenzioso che ha portato la società di Cupertino a versare 13 miliardi di dollari al governo di Dublino, praticamente non pagavano tasse su decine di miliardi di ricavi.
Un colossale sistema per spostare gli utili – facendo leva su royalties e compensi per lo sfruttamento di marchi e brevetti – dagli Usa nei paradisi fiscali interni alla UE, con adeguato sostegno di triangolazioni con altri paradisi fiscali in giro per il mondo come le isole Cayman e le Bermuda. Il tutto sotto lo sguardo vigile (si fa per dire) del precedente Presidente della Commissione Jean Claude Juncker. Meccanismi minuziosamente descritti da ultimo, in modo magistrale, nel libro “Romanzo fiscale” di Philip Laroma Jezzi.
Stesso schema, con varianti ancora più ingegnose, per le altre Big Tech Usa. In altre parole, i servizi che attualmente compriamo dagli USA, per la gran parte non sono altro che i compensi per lo sfruttamento di tutto il patrimonio di innovazioni tecnologiche della Silicon Valley, dell’industria finanziaria di Wall Street e dei brevetti delle Big Pharma statunitensi. Flussi di pagamenti quasi sempre assistiti da regimi fiscali di favore, verso i quali la Commissione ha chiuso gli occhi per anni. Salvo svegliarsi tra 2020 e 2021 con l’accordo in sede OCSE/G20 per un livello di imposizione minima fiscale globale per i gruppi multinazionali di imprese, a cui poi ha fatto seguito le Direttive “primo e secondo pilastro” per tradurre quell’accordo in atti legislativi. Non a caso, uno degli accordi stracciato da Donald Trump con un ordine esecutivo nei primi giorni di mandato.
Ai pagamenti per servizi, si affianca poi un significativo flusso di pagamenti per i profitti (cosiddetti redditi primari, derivanti dagli investimenti diretti e di portafoglio Usa nella UE) che ritornano oltreoceano. Ben 74 miliardi nel 2023, che contribuiscono a riequilibrare il conto corrente della bilancia dei pagamenti.
Ma reagire al problema del saldo della bilancia commerciale delle merci, sollevato da Trump, pensando di agire sul surplus Usa dei servizi, significa confondere la profonda diversità esistente con il flusso delle merci, in termini di manovrabilità e sostituibilità, soprattutto nel breve periodo. Come spararsi nei piedi.
Come sarà possibile ribaltare tutto questo articolato sistema senza privare i cittadini Ue di servizi essenziali a costi ragionevoli è un mistero, la cui soluzione dovrebbe albergare nella testa della von der Leyen. Sperando che ne abbia almeno una.
La quale però, a stretto giro, ha già ricevuto dinieghi e perplessità in occasione dell’Eurogruppo e del Consiglio Ecofin tenutisi nel fine settimana. Il ministro delle finanze tedesco, Jörg Kukies, ha sottolineato la dipendenza dell’UE dai servizi digitali americani, come cloud e intelligenza artificiale, evidenziando la difficoltà di trovare alternative. Kukies ha invitato a un approccio “differenziato e cauto”, pur riconoscendo la necessità di preparare contromisure.
Sull’altro fronte, il presidente Emmanuel Macron ha invece suggerito di colpire i servizi digitali e il commissario UE all’economia, Valdis Dombrovskis, ha ribadito l’importanza di considerare i servizi digitali nelle contromisure commerciali.
Ma sono Irlanda, Lussemburgo e in parte l’Olanda che – senza le articolazioni europee delle società Usa diventerebbero delle lande desolate – si sono messe decisamente di traverso.
Se a Bruxelles sono ancora convinti che agire sui servizi forniti dalle Big Tech Usa sia una buona strategia negoziale verso Trump, si preparino allora a dare adeguate risposte ai cittadini irlandesi e, se riuscissero a superare questo non facile ostacolo, anche a tutti i cittadini della UE.