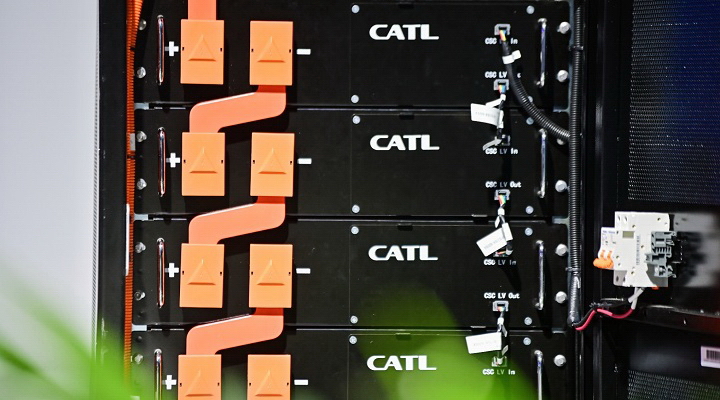È notizia di oggi il raggiunto accordo per la prima fase del piano rilanciato dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che prevede la realizzazione in più step di 21 punti. Questo primo risultato è focalizzato sul ritorno degli ostaggi, vivi e morti, il cessate il fuoco e il parziale ritiro dal territorio di Gaza da parte dell’esercito israeliano. Un risultato atteso, che arriva dopo due anni di guerra e soprattutto dopo il terribile eccidio del 7 ottobre 2023, avvenuto per mano dei terroristi palestinesi di Hamas. Un lungo lavoro di diplomazia, dove la politica internazionale è tornata al centro del dibattito mondiale e che ha impegnato, oltre al Governo degli Stati Uniti e Israele, anche gli Stati arabi dal Qatar all’Arabia Saudita e la Turchia.
Al di là delle prospettive di pace che apre e che speriamo si possano tutte concretizzare, pone nell’ambito della società israeliana, palestinese e occidentale la questione dell’elaborazione del lutto per le troppe morti causate.
Una questione di non facile lettura e interpretazione visto il risultato, sotto gli occhi di tutti, dell’uso distorto e strumentale che è stato fatto in questi due anni del tema della Shoah. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale e la scoperta dei campi di concentramento, il mondo inorridito ha iniziato un lungo e doloro percorso di riflessione su quanto accaduto. Ogni Stato ha intrapreso una sua diversa strada verso la costruzione di una Memoria, che potesse servire da antidoto per un “mai più”.
Conosciamo beni tutti l’iter per la definizione della “Giornata della Memoria” a livello internazionale, così come “i viaggi” per portare i ragazzi delle scuole nei luoghi dell’orrore. Una partecipazione sempre in crescita e aperta anche a chiunque avesse voluto davvero sapere. La creazione di siti di Memoria, il finanziamento di ricerche sul tema, monumenti, targhe e persino “pietre di inciampo”.
Ottant’anni di storia ripercorsi con uno scopo ben preciso, porre al centro la questione dell’antisemitismo e trovare gli anticorpi per scongiurare il suo ritorno sotto qualsiasi forma.
Ma si sa il fuoco spesso si nasconde sotto la cenere.
È bastato l’eccidio del 7 ottobre per far affiorare in maniera violenta e dirompente quel senso di colpa, mai sopito e mai realmente elaborato da parte della società occidentale, che si è trasformato nel più duro attacco allo Stato ebraico e alle Comunità ebraiche sparse nel mondo. Un capovolgimento di senso, che ha trovato la sua realizzazione nelle parole, per citarne qualcuna, quali “genocidio”, “campi di concentramento”, “sterminio” e “pulizia etnica”, solo per citarne qualcuno.
Alla luce di tale contesto, non si può non domandarsi quale sarà il percorso che intenderà intraprendere l’Occidente per descrivere l’inenarrabile del 7 ottobre.
Già qualcuno ha parlato di istituire una “Giorno della memoria”, magari poi si passerà a proporre anche dei viaggi nei luoghi colpiti. E con che risultato? E soprattutto con quale finalità?
Sono domande di difficile risposta, alla luce della facile distorsione della storia quando ci si avvicina a questioni legate al sottile filo dell’antisemitismo.
È uscito proprio il 7 ottobre il nuovo libro dello storico Ilan Pappè, dal titolo “La fine di Israele”, che affronta il tema, dal suo punto di vista, del collasso del sionismo e della fine dello Stato ebraico così come noi lo conosciamo. Senza entrare troppo nel contenuto del libro, basta soffermarsi un momento sul capitolo “Come ridefinire la collettività ebraica nel nuovo Stato?”, per trovarsi di fronte a un’interpretazione della nuova società che si vorrebbe in Israele.
Scrive Pappè: “In un simile scenario ottimistico, gli ebrei israeliani si riconcilieranno con i vicini e accetteranno di occupare una posizione simile a quella degli altri gruppi etnoculturali come gli alawiti, i drusi, i maroniti e le altre numerose comunità del Levante. A me sembra probabile che questo sarebbe di gran lunga preferibile all’altra opzione disponibile: emigrare e ricominciare la vita altrove, in una cultura totalmente diversa. Una delle precondizioni basilari per la riuscita di questo nuovo assetto è che nessun gruppo religioso o etnico pretenda che la propria identità venga equiparata a quella dello Stato”.
Quindi, la fine della Seconda guerra mondiale ha visto l’attuarsi del lungo percorso del sionismo con la nascita dello Stato d’Israele e ora la fine della guerra a Gaza dovrebbe comportare la sparizione dello Stato d’Israele come Stato ebraico, luogo in cui elaborare il lutto dei rapiti morti.
Scorrendo un po’ indietro la storia della questione palestinese, si ritrova una dichiarazione rilasciata da un dirigente di Al-Fatah, al Cairo, durante la Conferenza di Solidarietà con i popoli arabi, 25-27 gennaio 1969, in cui veniva riconosciuto il diritto degli ebrei di vivere in Palestina; quindi, rifiutando la formula per cui andavano “buttati a mare”, si asseriva l’esistenza di uno Stato arabo, democratico e plurirazziale. Emergeva l’idea di uno Stato senza alcuna egemonia e nel quale le diverse componenti etnico-religiose avrebbero vissuto nella totalità dei diritti civili. Un dibattito sull’idea palestinese di Stato arabo democratico che ha impegnato negli anni la galassia dell’OLP e che era focalizzato sulla creazione di uno Stato indipendente, soprattutto dagli Stati arabi e sull’autodeterminazione del popolo palestinese.
Una lettura, seppur figlia di un diverso contesto storico, vicina a quanto dichiarato sopra da Pappè.
Un’interpretazione che però dovrebbe poter meglio fare i conti anche con chi, già nel passato, non aveva accettato l’idea di una presenza ebraica nel territorio e del terrorismo ne aveva fatto la sua bandiera, da Settembre Nero, al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP), ad Abu Nidal o al Fronte del Rifiuto, per arrivare a oggi ad Hamas, figlia della propaganda iraniana.
Quello che in definitiva si vorrebbe proporre, dati anche gli slogan urlati nelle piazze, è un’elaborazione di un lutto nazionale in uno Stato non più ebraico, dove gli ebrei israeliani non si sa che posto occuperebbero e soprattutto se ancora ne avessero uno, con un Occidente ubriaco di propaganda e finalmente libero dal suo senso di colpa per la Shoah, senza averne mai fatto davvero i conti.
Se questa è la prospettiva, forse, il percorso per chiedere una “giornata della Memoria per il 7 ottobre” avrebbe bisogno di maggiore ponderazione, per non ritrovarsi tra altri ottant’anni al punto di partenza.