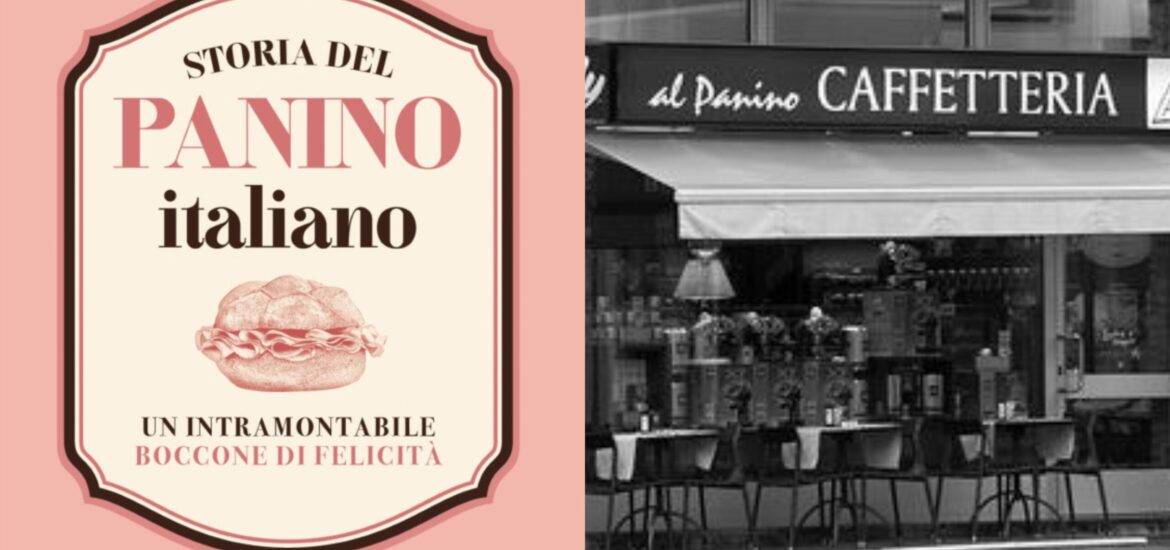Negli anni Cinquanta, l’emigrazione da sud a nord nell’Italia del boom economico aveva creato una massa di spopolati, privi di alloggio e di famiglia. Il pane, che i contadini conoscevano appena mangiando tutti i giorni polenta, era la risorsa essenziale in città, e bisognava accompagnarlo con qualsiasi cosa, di solito con un bulbo di cipolla o se, si era fortunati, con la fetta di mortadella del salumiere. Questa identità primaria del panino conviveva con una seconda identità puramente occasionale: nelle famiglie benestanti pane, burro e marmellata per i bimbi; e, per un picnic, nella sporta non un panino ma un sandwich. Leggenda o storia, la nascita in Europa di un panino con ingredienti di lusso porta il nome di John Montagu, quarto conte di Sandwich (1718-1792). Giocatore incallito, se lo faceva preparare e servire al tavolo durante le sue interminabili partite a carte. Questo panino -due fette di pane prive di crosta e in mezzo carne fredda e formaggio- denominato appunto “sandwich”, si era talmente diffuso che presto viene accolto dai ristoranti di hotel lussuosi per essere addentato da facoltosi e voraci clienti.
Come racconta Alberto Cappati nella sua divertente e dotta “Storia del panino italiano” (Slow Food Editore, 2024), nella borghesia ricca e nella convivialità nobiliare dell’Ottocento, sandwich dal condimento pregiato figuravano principalmente nei buffet e nel rito del tè. Mentre il diminutivo di pane aveva una sua aura spensierata e fanciullesca, ed era ben noto ai lettori di “Pinocchio” in cui, per colazione, “la Fata aveva fatto preparare dugento tazze di caffè e latte e quattrocento panini imburrati di sotto e di sopra”. E poi, a connotare la classe dei consumatori, c’era la forma del pane: intero, con la crosta, era del popolo, senza crosta era dei borghesi; tagliato verticalmente (a cassetta) era signorile, tagliato orizzontalmente popolare.
Obiettivo invece di chi, negli anni Trenta, voleva rendere italiano il sandwich sarà di cambiargli nome e di adeguare il companatico. Sono anni in cui tra l’Inghilterra e l’Italia fascista i rapporti erano difficili, e il pane italiano doveva dimostrare il suo valore gastronomico. Ecco allora che nella “Cucina futurista” (1932) Filippo Tommaso Marinetti e il poeta-pittore Fillìa (pseudonimo di Luigi Colombo) propongono di sostituire il termine sandwich con “traidue”: “Due fette rettangolari di pane: una spalmata di paste d’acciughe, l’altra di pasta di bucce di mele tritate. Tra le due fette di pane, salame cotto”. Più tardi il “traidue” verrà ribattezzato “tramezzino” da Gabriele D’Annunzio, come attesta il “Dizionario moderno” di Alfredo Panzini pubblicato da Hoepli nel 1935.
Quarant’anni più tardi, nel 1976, il Corriere della Sera registra il neologismo “paninaro”, che designava i frequentatori di un locale meneghino di piazzetta Liberty, “Al Panino”. Negli anni fra il rapimento di Aldo Moro e la Milano da bere, rappresentano una avanguardia (o retroguardia) giovanile che abbina il panino all’abbigliamento jeans Armani, felpe Best Company, cinture El Charro, giaccone Moncler, scarponcini Timberland. Mangiavano hamburger, ascoltavano i Duran Duran e inventavano un inedito e rocambolesco linguaggio, che si diffonde in tutto il paese grazie, nel 1980, a un periodico mensile disponibile in edicola, “Paninaro. Fumetti, attualità, moda, costume”; e grazie, nel 1983, alla trasmissione televisiva “Drive In” con il comico Enzo Braschi.
Dalla seconda metà degli anni Settanta, il panino occupa un posto crescente nella distribuzione, nei consumi, nel mangiare “fuori e svelto”. Poiché le bande di giovani si riuniscono in centro, nei quartieri dei negozi di abbigliamento, il fenomeno assume caratteri non tanto politici, quanto sociali e economici. Il termine paninaro rappresenta, agli occhi di chi ha conosciuto in quell’epoca San Babila e sansabilini, la destra fascista contrapposta ai “cinesi” in eschimo, la reazione qualunquista dei figli di papà alla vecchia sinistra extraparlamentare, la riappropriazione del simbolo proletario per eccellenza -il pane- eventualmente rimpiazzato con un signorile toast o una femminea tartina.
Più avanti il panino dovrà vedersela con l’hamburger di McDonald’s. Quest’ultimo esprime, con un pane senza radici autoctone, con la carne trita non identificabile ma gustosa, l’irrompere della globalizzazione nel mercato del cibo. I paninari, osserva Capatti, hanno invece il merito di aver collocato il panino fra gli “oggetti” di consumo con un marchio culturale italiano, e di aver contribuito a fissare una tipologia di locali e di giovani consumatori. Due mondi inconciliabili? Non proprio se si pensa ai panini preparati da Gualtiero Marchesi nel ristorante dei suoi genitori, vicino ai mercati generali milanesi: il Grattacielo, a strati, lo Smilzo, leggermente imburrato con la ventresca di tonno, il Curvo, a base di carne di manzo cruda, e il Gobbo alla frutta secca, foderato di lattuga.
Non è tutto, perché il grande chef darà a McDonald’s due sue creazioni dai nomi musicali, Vivace e Adagio. Il primo con spinaci, bacon e carne bovina. Il secondo con una mousse di melanzane, ricotta e carne. Nel contempo, proliferano le offerte tradizionali, focacce e piadine prevalentemente industriali. Seguiranno le bruschetterie e le piadinerie. Scarsa fortuna avranno gli hot dog, mentre le crêpes distribuite a Parigi in botteghini da marciapiede non faranno la loro apparizione nelle strade delle nostre città. Si affermeranno invece i kebab in virtù di una manodopera immigrata a basso costo.
Buon appetito.