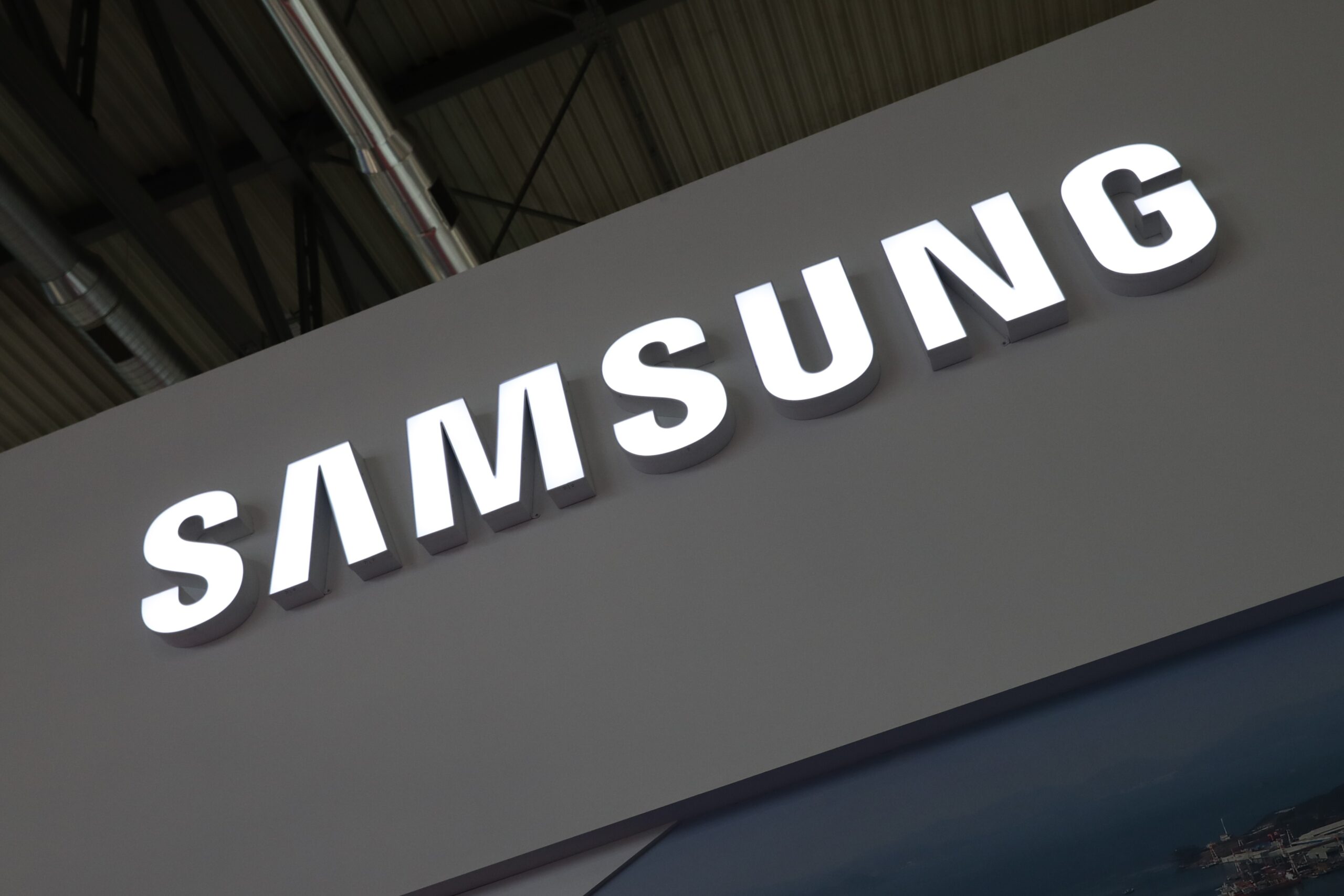Nel libro Le potenze del capitalismo politico. Stati Uniti e Cina, pubblicato di recente per la casa editrice La Nave di Teseo nella collana “Krisis” diretta da Massimo Cacciari e Natalino Irti, cerco di leggere il conflitto tra le due potenze attraverso la storia del capitalismo. E pongo l’attenzione sul concetto di “capitalismo politico”. Con quest’espressione, indico la compenetrazione di economia e politica, che nella nostra epoca si sviluppa attraverso diversi strumenti: l’uso politico del commercio, della finanza e della tecnologia, la partecipazione statale nelle imprese e più in generale i rapporti tra apparati burocratici e aziende, le sanzioni, le barriere agli investimenti esteri.
I conflitti del capitalismo politico si estendono anche al ruolo delle organizzazioni internazionali: organizzazioni in genere finanziate dagli Stati e che quindi risentono dei loro conflitti, soprattutto quando avvengono – almeno in superficie – alcuni cambiamenti dei rapporti di forza rispetto all’epoca della loro nascita. Questa è la dinamica che stiamo osservando, di recente, nell’Organizzazione mondiale del commercio e nell’Organizzazione mondiale della sanità. Non dobbiamo pensare che questi conflitti siano legati solo allo stile di Donald Trump, ma rispondono a tendenze più profonde.
DECISIONI ECONOMICHE E SICUREZZA NAZIONALE
L’espressione “capitalismo politico” viene da Max Weber, uno dei più grandi pensatori politici di tutti i tempi, peraltro di attualità perché morto purtroppo per l’influenza spagnola un secolo fa, il 14 giugno 2020. Weber, studioso della storia, della genesi e dello “spirito” del capitalismo (sulle sue tesi polemizzava, tra l’altro, un giovane Amintore Fanfani), scrive di un “accoppiamento” tra capitalismo e burocrazia avvenuto nel primo Novecento. Nel nostro tempo, dobbiamo porre l’attenzione soprattutto su due burocrazie: la prima può essere definita una “burocrazia armata”, e può essere identificata con gli apparati militari e di sicurezza (anche in ambito civile) degli Stati Uniti; la seconda può essere identificata con la “burocrazia celeste”, il mandarinato della storia della Cina, studiato da un geniale sinologo come Étienne Balazs, e oggi incarnato dal Partito Comunista Cinese, che non parla mai di “capitalismo”, anche se lo pratica.
Si tratta di burocrazie molto estese: solo il Pentagono ha circa 3 milioni di dipendenti e secondo alcune stime ha programmato circa 100 miliardi di dollari di investimenti in ricerca e sviluppo. Il Partito Comunista Cinese conta circa 90 milioni di membri.
Gli strumenti del capitalismo politico, che ho descritto sopra, mostrano che alcune importanti decisioni in ambito economico vengono prese non per ragioni di mercato, ma per ragioni di “sicurezza nazionale”.
In Cina questo è evidente: i privati forniscono un apporto fondamentale alla crescita economica cinese ma il Partito-Stato, oltre a gestire un insieme molto ampio di partecipazioni nelle imprese (con una quota di controllo o anche solo “segnaletica”, nel caso di imprese quotate), può porre indirizzi e vincoli allo sviluppo delle imprese, per esempio nella collaborazione dei giganti digitali privati come Alibaba e Tencent ai programmi governativi. Inoltre, nessuna impresa può varcare le linee rosse del Partito Comunista Cinese, per esempio sulle libertà politiche. Nessun imprenditore, per quanto ricco, può farsi la sua “start-up politica”. Il Partito non tollera la crescita di “oligarchi con caratteristiche cinesi”.
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, non vi è naturalmente un Partito-Stato, perché si tratta di un sistema in cui esistono le libertà politiche, ma non per questo mancano le espressioni del capitalismo politico, attraverso gli apparati governativi che garantiscono la continuità delle scelte imperiali statunitensi. Tra i fenomeni più rilevanti vi sono i controlli delle importazioni, delle esportazioni e degli investimenti esteri, attraverso apparati governativi come il Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) e il Bureau of Industry and Security (BIS), che abbiamo imparato a conoscere proprio per la loro opposizione a investimenti cinesi o per l’inserimento di aziende del Celeste Impero, tra cui Huawei, all’interno delle loro “liste nere”.
Bisogna sempre considerare l’importanza della sicurezza nazionale, un’ombra che cammina con la storia del capitalismo. D’altra parte, lo stesso Adam Smith parla a lungo delle esigenze della difesa e dell’arte della guerra. Quando gli Stati combattono nell’arena economica, quando ci sono le crisi, questo è più evidente. In realtà è sempre così, per chi sa guardare oltre la superficie.
LA FRONTIERA TECNOLOGICA
Cosa succede, nel difficile contesto in cui viviamo? I conflitti tra le potenze del capitalismo politico si approfondiscono e si estendono. Assistiamo a un allargamento della “sicurezza nazionale” da parte di numerosi Stati, a un approfondimento dei confini. È prematuro parlare di “fine della globalizzazione”, visto che la cosiddetta “globalizzazione” è anzitutto l’infrastruttura militare, commerciale e tecnologica del primato degli Stati Uniti. Ma i conflitti, oltre che su alcuni elementi commerciali (pensiamo alla “geopolitica delle mascherine” o alla “geopolitica dei respiratori”, di cui ho scritto su Limes), si approfondiscono proprio sulla frontiera tecnologica.
La pandemia ha sottolineato, una volta di più, la pervasività del digitale nelle nostre vite, per l’organizzazione del lavoro, dell’istruzione, persino della dimensione affettiva. Ma non esiste il “digitale” in astratto: parliamo anzitutto di aziende che caratterizzano il capitalismo statunitense e quello cinese. Qui si gioca una partita molto importante del conflitto. Pensiamo alla crescita di Amazon, alle impressionanti assunzioni dell’azienda di Jeff Bezos nella pandemia (circa 175.000), alla forza di Microsoft nel cloud. Le aziende digitali degli Stati Uniti tendono sempre più a sottolineare la propria identità nazionale, anche per paura di essere colpite dai regolatori: è ormai tramontata quell’epoca ingenua in cui Google e Facebook si raccontavano come doni per connettere liberamente l’umanità. Per loro è ora centrale l’abbraccio lobbistico con Washington.
Pensiamo poi ai campioni cinesi, anche mettendo da parte il “caso” Huawei che resta di stretta attualità nei rapporti tra gli Stati Uniti e gli alleati, e di cui discuto a lungo nel mio libro, ricostruendo la lunga storia delle vicende che riguardano l’azienda fondata da Ren Zhengfei. In questo frangente, oltre a giganti digitali cinesi come Alibaba e Tencent, abbiamo sempre più che a fare con aziende che si muovono nel crinale del rapporto tra le due potenze.
Un esempio è Zoom, che ha dominato le videochiamate degli ultimi mesi: è la creazione di un cinese emigrato negli Stati Uniti, Eric Yuan. Zoom dispone ancora oggi di server cinesi per la sua operatività, ed è impegnata in una campagna battente di legittimazione. In pochi giorni, da inizio maggio 2020, l’azienda ha realizzato tre mosse: a) ha cooptato nel consiglio di amministrazione il generale McMaster, già consigliere per la sicurezza nazionale di Trump; b) ha acquisito un’azienda su servizi di sicurezza, Keybase; c) ha annunciato assunzioni di ingegneri e apertura di centri di ricerca negli Stati Uniti.
Lo scontro tra Stati Uniti e Cina resterà la questione centrale della nostra epoca. Per analizzarlo con la lente del capitalismo politico, occorre una vera consapevolezza del ruolo politico della tecnologia, e serve anche una certa cautela, per porre i problemi in una prospettiva storica. Non è il caso di utilizzare formule come “la Cina sta vincendo”, o “è colpa/merito di Trump”. Dobbiamo concentrarci sugli aspetti strutturali, per trovare una bussola in questo tempo conflittuale.
(L’analisi di Alessandro Aresu per il Quadrimestrale di Start Magazine (luglio-novembre 2020) su “Che mondo sarà – Ipotesi sull’era post pandemica”