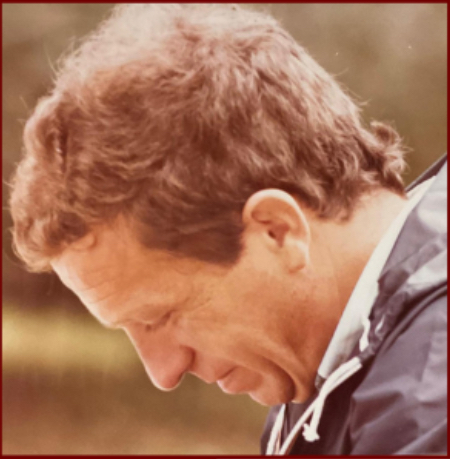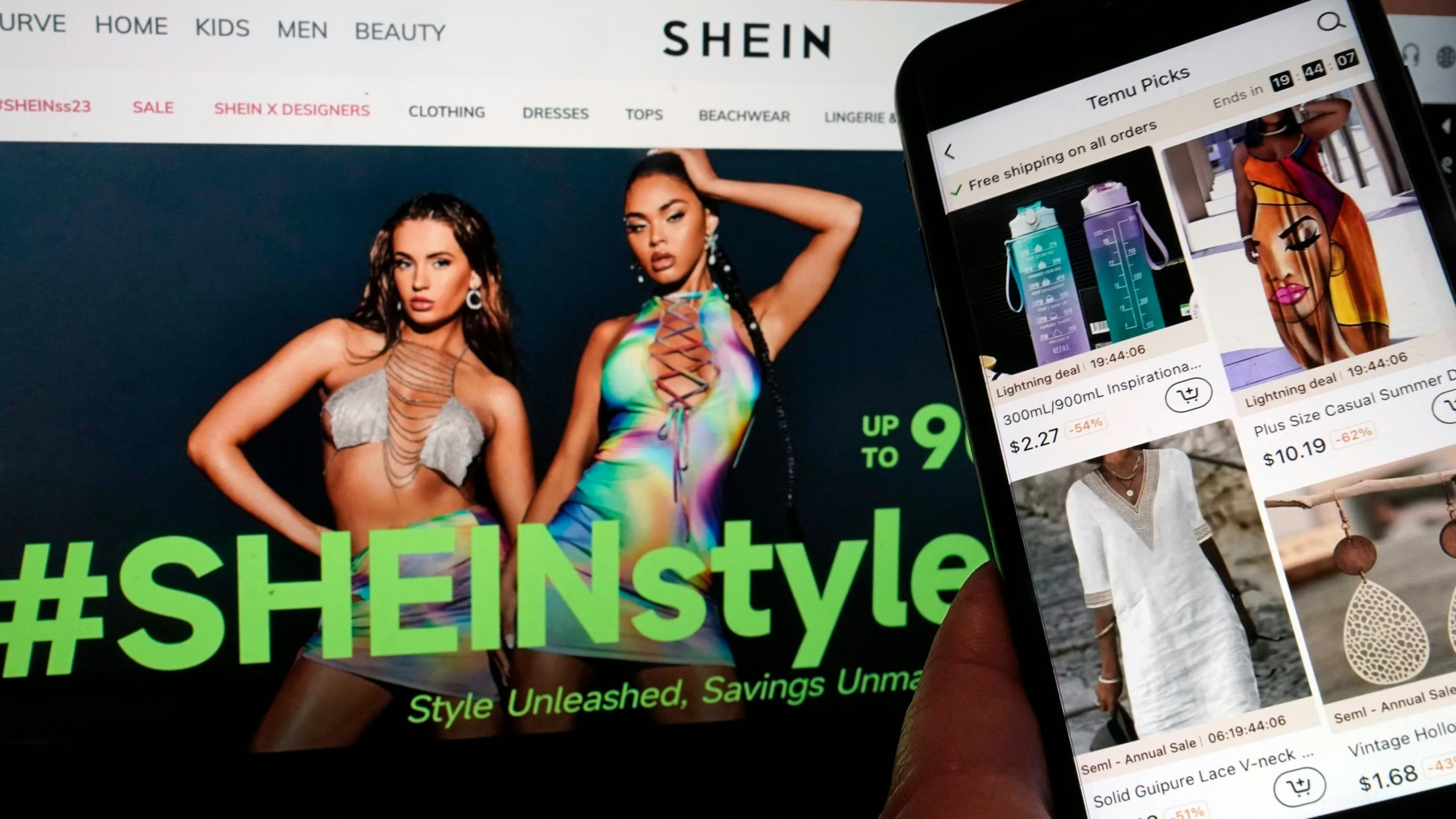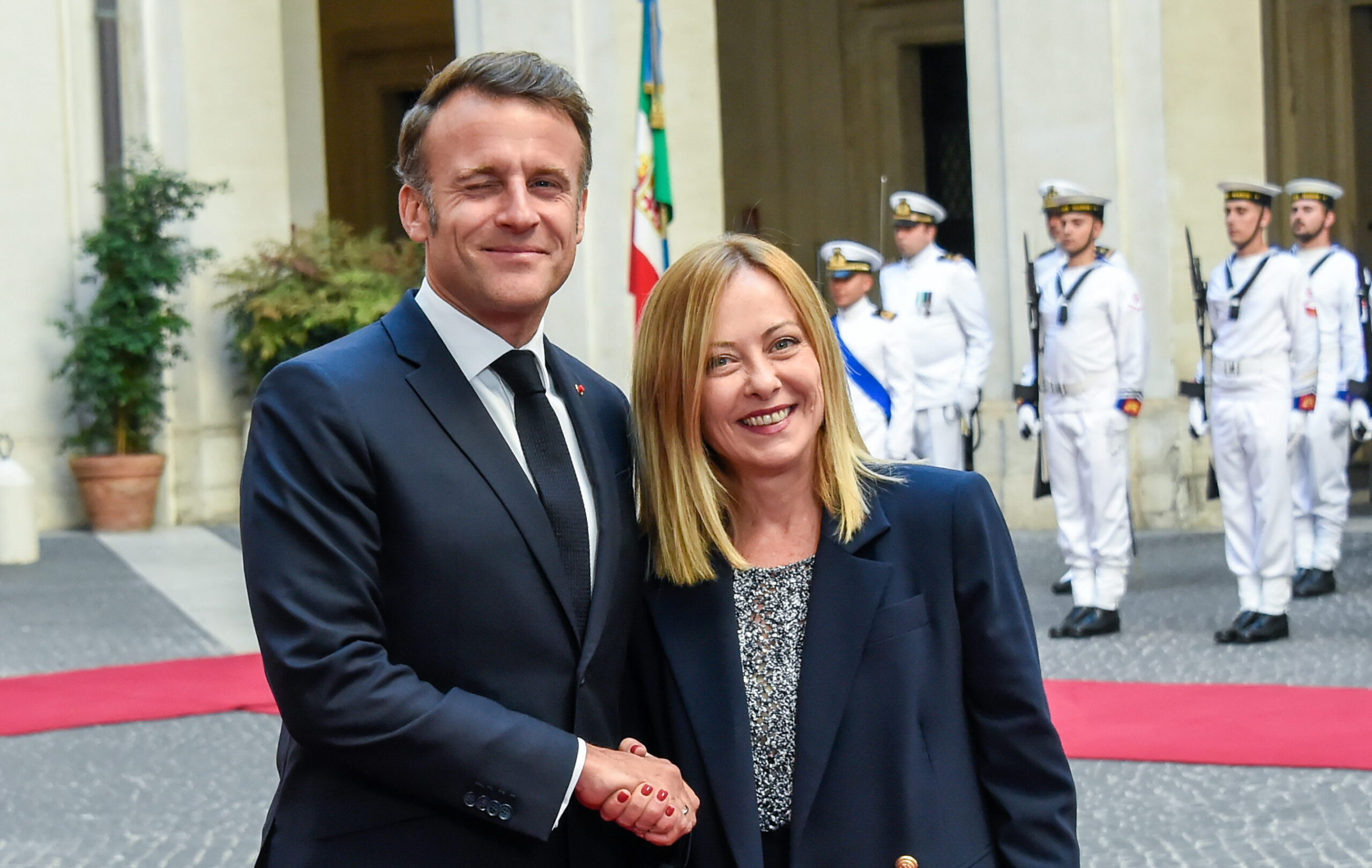Caro direttore,
presentando il prossimo Festival di Sanremo, Carlo Conti ha annunciato che le canzoni in gara non parleranno più di guerra e immigrazione. Parleranno soprattutto di famiglia, delle relazioni e dei sentimenti che sbocciano e si consumano nel focolare domestico. Sui media degli ultimi giorni la notizia ha avuto uno spazio, se non superiore, almeno pari alla sanguinosa guerra civile in Siria e alla crisi democratica della Georgia. È un segno dei tempi, puntualmente registrati dal sismografo più sensibile del nostro sentimento nazionalpopolare.
Prima la pandemia, poi l’invasione dell’Ucraina, i conflitti mediorientali e la viltà dell’Europa nei confronti dell’autocrazia russa: il terzo decennio del terzo millennio non è certo iniziato sotto i migliori auspici. E ne stiamo pagando lo scotto nel discorso pubblico. “El sueño de la razón produce monstruos”, recita il titolo dell’acquaforte di Francisco Goya. È così. Dietro al successo dell’astrologia, dello spiritismo, del cospirazionismo, del complottismo, delle più strampalate teorie scientifiche, si cela la tendenza ad alienare una libertà considerata troppo pesante e generatrice di angoscia.
Ci si aggrappa perciò a idee irrazionali, che consentono di attribuire la responsabilità di ciò che accade a potenze oscure. Da qui quel malessere che un tempo solo le élite culturali conoscevano, e che oggi è un fenomeno di massa. Da qui le canzonette consolatrici di Sanremo. In un libro pubblicato per la prima volta in Francia nel 2003 e ristampato in italiano da Dedalo (“Storia del mal di vivere. Dalla malinconia alla depressione”, 2023), lo storico Georges Minois si chiedeva se non fossimo di fronte “a una sorta di bivio […] fra l’idiozia e la depressione, fra un avvenire di imbecilli felici o di intellettuali depressi”.
Nel nostro paese, vent’anni dopo, quel dilemma non è stato ancora sciolto.