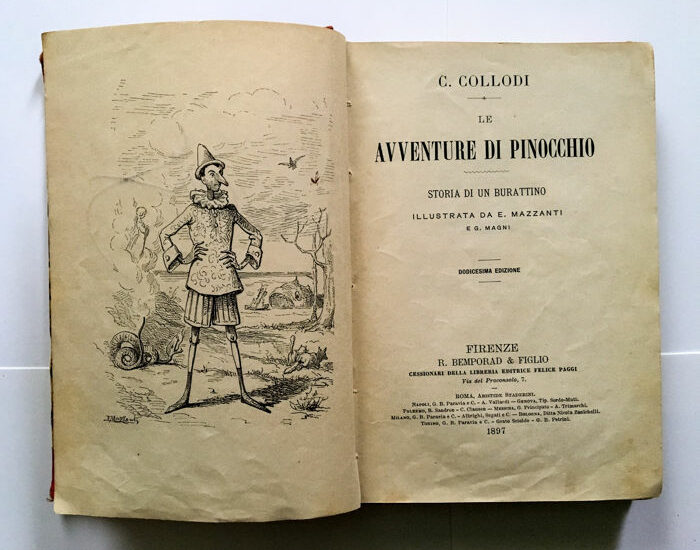“I classici sono libri che quanto più si crede di conoscerli per sentito dire, tanto più quando si leggono davvero si trovano nuovi, inaspettati, inediti” (Italo Calvino). In questo senso, “Le avventure di Pinocchio” (pubblicato per la prima volta nel 1883) è sicuramente un classico. Perché, pur senza sottrarre al mito e alla fiaba i loro diritti, consente di scoprire come il protagonista dell’opera di Carlo Collodi sia anche una piccola enciclopedia dei caratteri e dei nostri vizi nazionali.
Noi italiani, si dice, in un modo o nell’altro ci salviamo sempre. E, come ha scritto Antonio Faeti, Pinocchio “transita anche lui da una Caporetto domestica a un’Adua burattinesca a un Otto Settembre esistenziale” (Pinocchio”, in “L’identità degli italiani”, a cura di Giorgio Calcagno, Laterza, 1998). Si brucia i piedi, ma gli vengono rifatti, tradisce le affettuose aspettative del suo creatore ma cade in un imbroglio perché spera di farlo ricco.
Noi italiani, si dice, siamo molto attaccati alla famiglia. E infatti si chiamano “famiglie” le centrali mafiose e i clan camorristici. Pinocchio, allora, ci propone una riflessione inquietante sulla famiglia: un babbo falegname e derelitto come il San Giuseppe del presepio, una madre madrina sorella sorellina che si atteggia a Madonna, uno zio putativo come mastro Ciliegia, un parente in incognito come Mangiafoco. Sembrano quei terribili gruppi familistici, piangenti e tremebondi, che affollano i salotti di certe trasmissioni televisive (da “Chi l’ha visto?” a “C’è posta per te”, per non fare nomi).
Pinocchio, poi, è un’esplicita parodia del pessimo rapporto che i suoi concittadini in carne e ossa hanno con i libri. Si libera, appena può, di un sillabario che il suo genitore aveva ottenuto cedendo una giacca, è testimone di un programmatico lancio di libri ai pesci, si rivela misteriosamente alfabeta (lui che a scuola non c’era mai stato) solo per leggere una lapide funeraria.
Ben conficcato nell’etnia italica, Pinocchio fugge, erra, cammina, si ritrova come i nostri emigranti: può vivere, come loro, perfino nel ventre della balena. Come osserva acutamente Faeti, trasformista e bugiardo nell’apparenza, Pinocchio è sincero nel fondo. È, in sostanza, l’esempio di un modello laico e devozionale. È la divinità lignea di un Paese che è sempre lì lì per cambiare, di un luogo del mondo sempre alla vigilia di eterne metamorfosi, sempre con il rischio di risvegliarsi diversi, sì, ma con l’aggiunta di un paio d’orecchie d’asino.
Del resto, la terrificante fauna sociale che circonda il nostro eroe nasce proprio dal ghigno profetico dell’autore, il quale ci suggerisce che di Gatti, di Volpi, di Serpenti ne avremo sempre. Un bel Gattopardo, con in bocca un toscanello e con il mezzo litro di Chianti sul tavolo, forse avrebbe opportunamente completato il bestiario di Carlo Lorenzini.
Infine, Pinocchio ne ha fatti tanti di sacrifici, per cambiare. Ha voluto diventare un ragazzino per bene, si è mortificato come uno schiavo o come un salariato agricolo che subisce le angherie del caporalato (sempre italianissimo, comunque). Forse assomiglia agli italiani del futuro, non solo a quelli del passato.