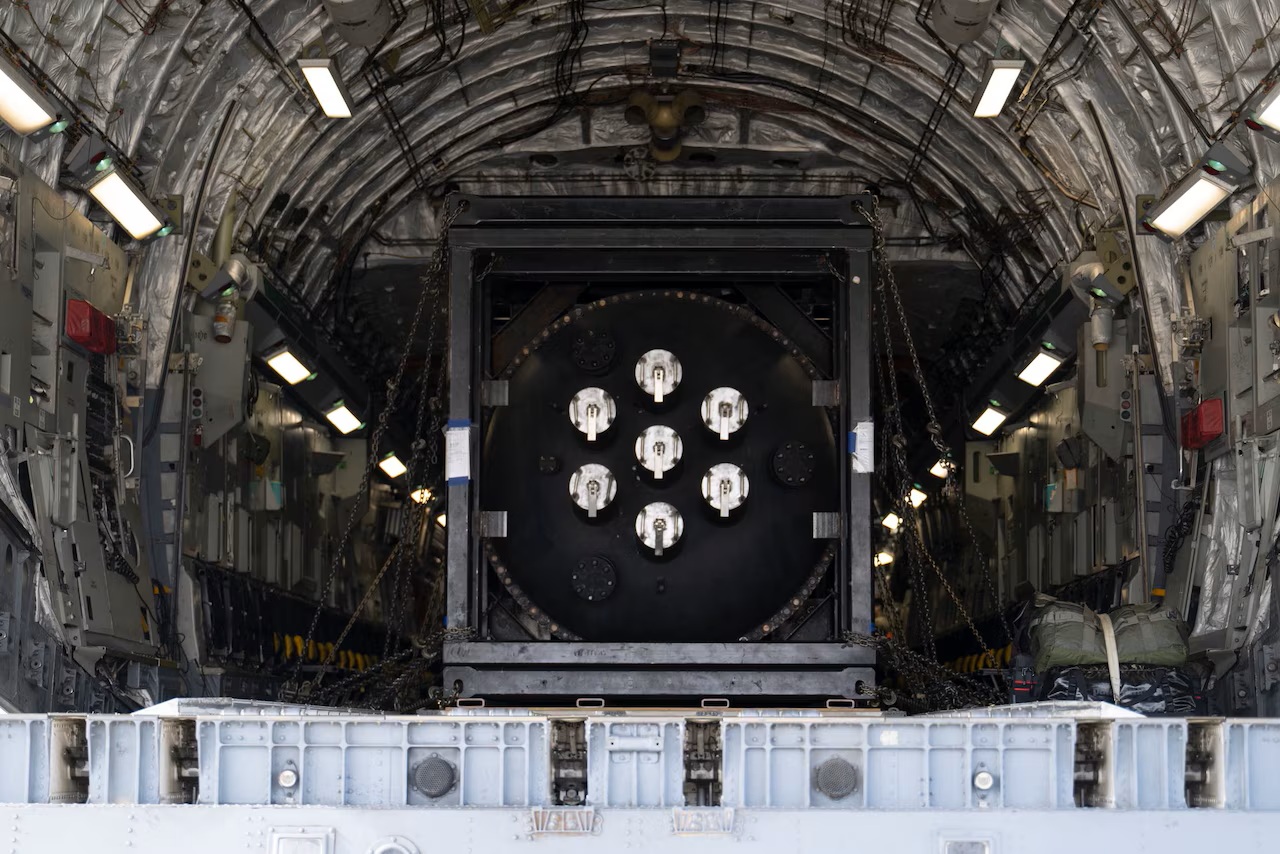Per la prima volta dalla nascita del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina (Ukraine Defense Contact Group, UDCG), noto anche come Ramstein group – alleanza di 54 nazioni, cui aderiscono tutti i 32 Stati membri della Nato e altri 23 Stati che non fanno parte dell’Alleanza Atlantica, che sostiene l’Ucraina inviando attrezzature militari per aiutarla a difendersi dall’invasione russa del 2022 – gli Stati Uniti non parteciperanno alla riunione dei 50 Paesi prevista per l’11 aprile a Bruxelles. Il Segretario alla Difesa americano Pete Hegseth non sarà presente al summit ed il Pentagono non invierà neppure un rappresentante, come avvenuto regolarmente in tutti i precedenti 26 incontri del gruppo. L’assenza degli Usa evidenzia, ancora una volta, il capovolgimento della politica estera della Casa Bianca e la riduzione dell’impegno degli Stati Uniti negli sforzi di coordinamento della difesa dell’Ucraina, in un momento critico della guerra.
Una decisione che rappresenta anche un’ennesima concessione al presidente Putin, mentre l’aggressiva strategia dei negoziatori russi ha fatto arenare le trattative e raffreddato gli entusiasmi dell’inesperto immobiliarista Steve Witkoff, che privo di qualsiasi formazione diplomatica non può adeguatamente difendere gli interessi dell’Ucraina, ma si è prodigato a rilanciare i contenuti più caratteristici della propaganda russa, allegando attestati di stima e legittimazione politica per il Capo del Cremlino. Nella sua intervista rilasciata al Tucker Carlson show non ha dato alcun riferimento sull’andamento delle negoziazioni in corso con il team del presidente Putin, che non vuole la pace, ma soltanto la capitolazione di Kyiv. Eventi che delegittimano la leva diplomatica americana e mettono in discussione gli Stati Uniti come partner affidabile.
Un’assenza al meeting di Bruxelles che contiene anche un chiaro messaggio agli alleati europei: l’amministrazione del presidente Trump sta valutando la possibilità di rinunciare al comando delle forze Nato in Europa.
Strategia che il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, sta portando avanti anche attraverso la rimozione di tutti gli alti ufficiali del Pentagono ed i Capi di tutte le Agenzie di sicurezza nominati dal presidente Biden, che hanno supervisionato le operazioni in Europa e permesso alle Forze armate ucraine di resistere in questi tre anni all’invasione russa. Ultimi licenziamenti in ordine di tempo, quella dell’Ammiraglio della Marina statunitense, Shoshana Chatfield, dal suo incarico di rappresentante degli Stati Uniti presso il comitato militare della Nato; e quello del colonnello Susannah Meyers, comandante dell’821° Space Base Group statunitense che supervisiona la base spaziale di Pituffik, che è stato rimosso dal comando per “perdita di fiducia” dopo aver difeso l’unità dell’Alleanza Atlantica durante la visita del vicepresidente JD Vance. La “perdita di fiducia” è scaturita dall’aver fatto sventolare nella base, tutte insieme, le bandiere americana, danese e groenlandese.
Il già noto scetticismo del presidente Trump nei confronti della Nato e la sua ferma opposizione all’adesione dell’Ucraina all’Alleanza, sollevano preoccupazioni tra gli alleati sulla sostenibilità a lungo termine della cooperazione transatlantica in materia di difesa. Il tycoon-presidente ha sempre criticato la Nato, definendola obsoleta e contestando (giustamente) i mancati contributi finanziari degli Stati membri. La sua resistenza all’adesione dell’Ucraina alla Nato si allinea al suo più ampio scetticismo nei confronti degli impegni di sicurezza degli Stati Uniti in Europa.
È importante ricordare il fondamentale ruolo che gli Stati Uniti hanno svolto nella definizione dell’ordine globale dopo il 1945, attivando il Piano Marshall nel 1948 che ha permesso di ricostruire l’Europa devastata dalla guerra, e costituendo la Nato nel 1949 per scoraggiare l’aggressione sovietica e garantire la sicurezza europea. Da allora, la presenza militare nelle basi statunitensi dei vari Paesi alleati ha garantito la stabilità e dissuaso gli avversari. Una leadership che si è rivelata stabilizzante anche nelle istituzioni internazionali: gli Stati Uniti hanno contribuito alla creazione dell’ONU, del FMI e della Banca Mondiale per promuovere la stabilità e la crescita economica.
Oggi, tutto ciò viene rinnegato dall’amministrazione Trump e dal partito repubblicano, con politiche del tutto sovrapponibili a quelle del Cremlino, che stanno contribuendo a smantellare l’ordine del secondo dopoguerra che ha mantenuto l’Europa stabile e gli Stati Uniti dominanti. Un’inversione di rotta della politica estera americana che crea maggiore frammentazione ed instabilità in Occidente, e rende più difficile la gestione di minacce ibride e di potenziali futuri conflitti (ad esempio, aggressione russa, guerra cibernetica, terrorismo).
Lo scetticismo del presidente Trump nei confronti degli impegni di sicurezza degli Stati Uniti in Europa deriva da diversi fattori chiave, che includono:
- “America First” – preferisce dare a tutte le questioni una priorità strategica interna, anche se si tratta di tematiche internazionali che coinvolgono altri Stati ed impegni di sicurezza globale.
- Scetticismo verso le istituzioni multilaterali – in generale diffida delle organizzazioni internazionali, considerandole burocratiche e inefficaci. Alle alleanze diplomatiche e militari formali a lungo termine preferisce i negoziati bilaterali e soprattutto personali a tu per tu con i leader mondiali, compreso Vladimir Putin, dove può mettere sul tavolo la forza degli Stati Uniti e bypassare i vincoli dei Trattati internazionali ed alcune prerogative del Congresso e della Corte Suprema degli Stati Uniti. Trattative che delegittimano la diplomazia e minano le strutture tradizionali delle alleanze.
- Approccio imperialista alle relazioni tra Stati – enfatizzazione di analisi unilaterali costi-benefici, minaccia di annessioni di territori alleati, per interessi esclusivamente economici.
- Priorità economiche rispetto alle alleanze strategiche – Trump tende a vedere le relazioni internazionali attraverso una aberrata lente economica, concentrandosi sugli squilibri commerciali piuttosto che sugli impegni militari strategici.
- Erosione dell’alleanza transatlantica – vede la NATO come un salasso finanziario del quale gli Stati Uniti sostengono ingiustamente l’onere finanziario, soprattutto per la difesa europea. Considera gli impegni della Nato come obblighi costosi che non portano benefici diretti agli Stati Uniti, mentre i “parassiti” Paesi europei sfruttano le risorse che non versano all’Alleanza per “fregare” i cittadini americani che spendono per proteggerli con la loro potenza militare. Il presidente Trump si oppone ad ogni allargamento della Nato e considera la sua espansione una provocazione nei confronti della Russia e un peso per le risorse della difesa statunitense. Il rifiuto del presidente Trump all’adesione dell’Ucraina alla Nato, sottintende il medesimo disconoscimento russo di quello Stato, in quanto soggetto di diritto internazionale dotato di propria indipendenza e personalità giuridica, che esercita un potere autonomo nell’ambito delle relazioni internazionali ed il diritto all’autodeterminazione ed alla difesa del suo popolo. Inoltre, attraverso le minacce di annessione del Canada e della Groenlandia, le richieste ai Paesi europei di “contribuire con il 5% del proprio Pil”, dichiarazioni di non sentirsi vincolato al rispetto dell’Art. 5 del Trattato nei confronti di chi non paga, di ritirarsi dalla Nato, crea dubbi quotidiani sulla postura degli Stati Uniti ed indeboliscono l’Alleanza Atlantica.
RISCHIO DI UN VUOTO DI POTERE
Prima del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, anche altri presidenti americani hanno ripetutamente invitato l’Europa ad assumersi la responsabilità primaria della propria sicurezza. Ora, Washington ha persino minacciato il ritiro delle truppe statunitensi dall’Europa, costringendo gli alleati a considerare accordi di sicurezza alternativi. Una ulteriore riduzione della presenza militare degli Stati Uniti in Europa, comporterebbe un deterioramento della forza di deterrenza della Nato, che potrebbe incoraggiare l’aggressione russa nell’Europa orientale. Anche dal punto di vista economico e commerciale, con il ritiro americano Russia e Cina sfrutterebbero le divisioni tra le nazioni Ue per espandere la loro influenza, e la Casa Bianca perderebbe certamente alcuni alleati chiave nella definizione della politica di sicurezza globale, minando la coesione occidentale.
È GIUNTO IL MOMENTO CHE L’EUROPA SIA IN GRADO DI DIFENDERSI DA SOLA
Tutte le decisioni intraprese in queste prime settimane di presidenza Trump, oltre ad indebolire l’influenza degli Stati Uniti nelle questioni di sicurezza europee, stanno costringendo gli alleati a riconsiderare Washington non più come un alleato affidabile ma come un avversario e persino una minaccia, e a rivalutare la loro strategia di difesa.
A questa diversa postura strategica degli Stati Uniti rispetto alla sicurezza europea, deve obbligatoriamente corrispondere la definitiva realizzazione dell’autonomia strategica europea: la retorica russa, condivisa dalla Casa Bianca, costringe l’Europa a considerare alternative, che stanno facendo intravedere la potenziale creazione di un blocco politico-militare e nucleare indipendente guidato da Francia, Regno Unito e Germania (al quale spero si aggiunga presto anche l’Italia). La situazione è cosi deteriorata, che a seguito del recente scandalo “Signal-gate” che ha visto i capi di Pentagono, Dipartimento di Stato, Casa Bianca e Servizi segreti pubblicare tutte le informazioni relative all’attacco aereo e missilistico contro gli Houthi in Yemen, il premier britannico Starmer sta addirittura cercando di convincere gli altri membri del gruppo “Five Eyes” – Canada, Nuova Zelanda e Australia (tutti facenti parte del Commonwealth) – ad escludere gli Stati Uniti dall’alleanza per lo scambio di informazioni di intelligence tra i Servizi segreti dei cinque Paesi.
Tutti gli alleati stanno mettendo in dubbio l’affidabilità di Washington, ricercando soluzioni ai potenziali cambiamenti negli assetti e nelle dinamiche dell’Alleanza Atlantica, sviluppando strutture militari proprie, in grado di agire indipendentemente dagli interessi statunitensi. Anche l’Ue, scossa dal terremoto trumpiano sta reagendo con il Piano ReArm Europe/Readiness 2030, con l’espansione di strutture esistenti come il Fondo europeo per la difesa (EDF) e la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e con una maggiore cooperazione industriale nel settore della difesa (EDIRPA). Tutti programmi che prevedono una migliore integrazione militare mediante Comandi militari congiunti e maggiore coordinamento degli acquisti per la difesa, per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti in caso di future incertezze della Nato, il rafforzamento dell’autonomia strategica europea ed una maggiore reattività alle minacce alla sicurezza regionale. Certamente si tratta di un percorso non facile, per costruire una deterrenza collettiva indebolita dalla diminuzione della presenza e potenza militare degli Stati Uniti, che richiede enormi investimenti finanziari e sfide logistiche, ed il superamento di potenziali punti di tensione tra gli Stati europei.
Il contesto geostrategico che si sta delineando richiede un’alleanza di difesa ristrutturata e con postura di sicurezza proattiva, che potrebbe assomigliare all’Unione Europea Occidentale (UEO), un’organizzazione militare costituita all’epoca della Guerra Fredda, che pur non prevedendo ancora la costituzione di una organizzazione internazionale, diede vita ad un patto di autodifesa collettiva tra i 5 Stati contraenti: Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito. Certamente il consenso sulla Politica di Difesa e Sicurezza Comune (PSDC) all’interno dell’Europa rimane incerto, dati gli interessi nazionali divergenti, ma se la Nato si indebolisce con le politiche di Trump, l’Unione Europea deve comunque affrontare le diverse sfide strategiche.
Come stiamo constatando in questi giorni, le politiche del presidente Trump hanno implicazioni di portata globale, stanno creando nuove dinamiche conflittuali, che invece di portare la “pace in 24 ore” in Europa ed in Medioriente, hanno provocato un’escalation in quei due conflitti regionali in corso ed innescato una guerra economica mondiale imponendo dazi indiscriminati a tutti, mentre vuole eliminare le sanzioni alla Russia. Decisioni, spesso inspiegabili e contraddittorie che stanno creando tempeste finanziarie e spingendo gli alleati europei verso accordi di sicurezza e commerciali alternativi.
Il Trattato Atlantico, composto da solo 14 articoli prevede una flessibilità intrinseca su tutti i fronti, e dalla sua stipula – il 4 aprile 1949 – ad oggi, nonostante l’evoluzione del contesto di sicurezza e l’aumento dei suoi Membri – dai 12 fondatori agli attuali 32 – il Trattato originale non ha mai dovuto essere modificato.
L’auspicio è che il sistema politico-istituzionale degli Stati Uniti d’America impedisca al suo 47esimo presidente di passare alla storia anche per aver demolito la più longeva e potente Alleanza di difesa collettiva dell’Occidente.