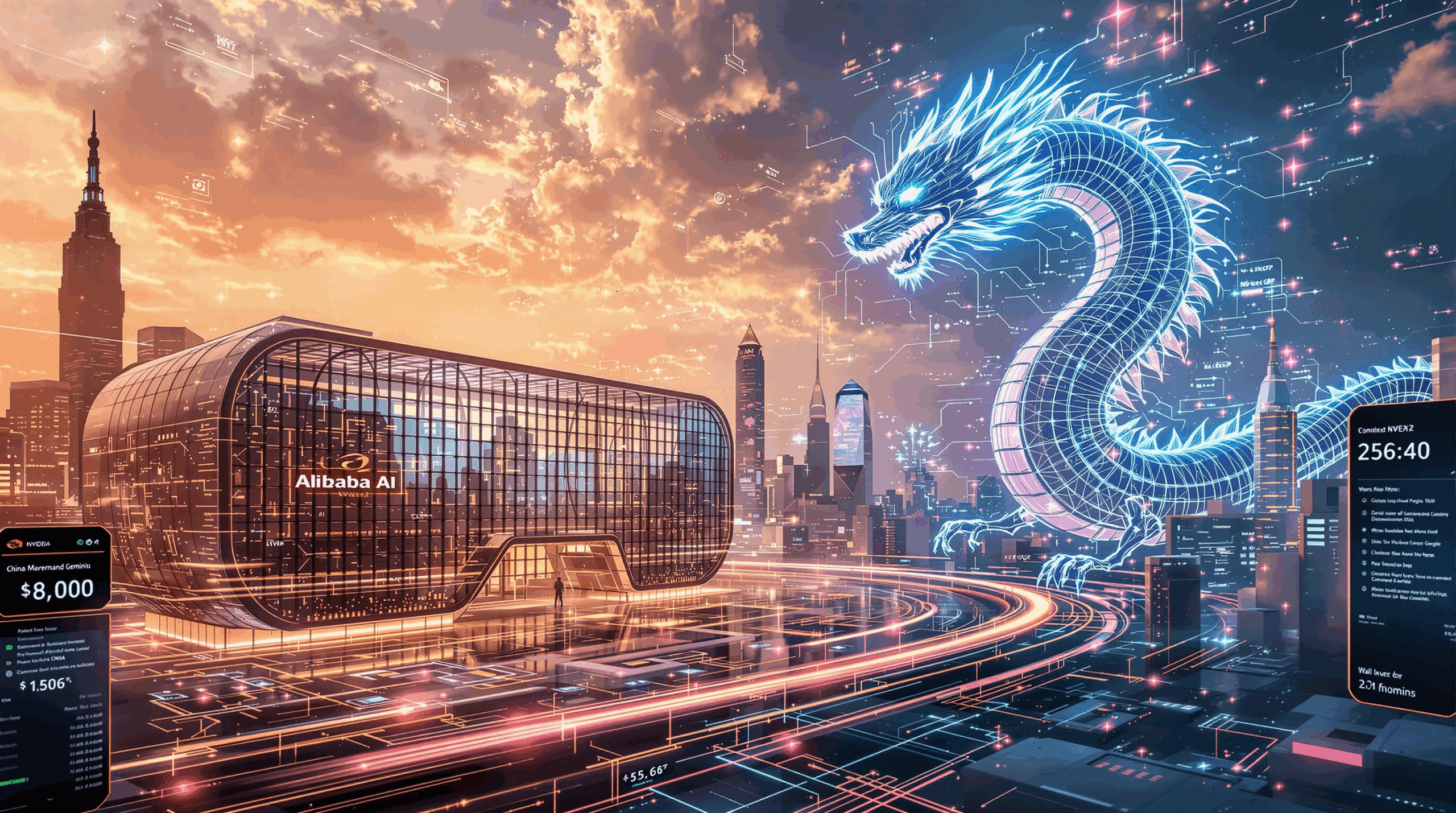Per molti versi siamo tornati all’antifascismo militante. Non a quello che segnò gli anni della nascita della Costituzione repubblicana, ma quello degli “anni di piombo”. Gli anni della caccia al “nero” da parte dei gruppi della sinistra-sinistra. E della simmetrica risposta dei movimenti neo-fascisti. Una continua escalation destinata a portare lutti e dolori da entrambe le parti. Quei tempi non devono ritornare. E non solo per motivi di carattere etico: bastano i morti del Covid. Ma perché le tesi, che ne sorreggono l’impianto, sono fuorvianti. Impediscono di guardare al domani, cullandosi sugli archetipi del passato. Diciamo subito che populismo e sovranismo non c’entrano con il fascismo. Donald Trump non è Hitler. Matteo Salvini non è il nuovo Duce e Giorgia Meloni non è Claretta Petacci.
Non è così. Soprattutto non deve essere così. Guai quindi ad evocare, come tenta di fare Pier Luigi Bersani, lo spirito della “guerra fredda”, nella individuazione dei nemici di sempre, seppure con indosso nuove uniformi: da un lato la sinistra, con il suo multilateralismo e la sua proiezione europeista; dall’altro la destra sovranista e populista. Variante storica del vecchio fascismo. “Dobbiamo porre fine a questa guerra incivile – ha detto Joe Biden nel suo giuramento – che mette il rosso contro il blu, il rurale contro l’urbano, il conservatore contro il liberal”. Per comprendere tutti insieme le contraddizioni di quel nuovo mondo che si apre di fronte a noi. Chi insiste nel manicheismo non riesce a vedere le ragioni specifiche di certe divergenze, che non c’entrano con le divisioni del ‘900, ma hanno vita propria. Sulla quale è necessario indagare. “Non per affrontare – è sempre Joe Biden che parla – le sfide di ieri, ma le sfide di oggi e di domani”.
Agli inizi del secolo scorso, il mondo conobbe la prima fase della globalizzazione. Cercarono di interpretarla studiosi e uomini politici. Da Hobson, cui si devono i primi studi sulla natura dell’imperialismo, al socialdemocratico Hilferding, così duramente attaccato – anche sul piano personale – da Lenin. Divergenti le rispettive valutazioni. Il primo vedeva un capitale finanziario ormai padrone del Mondo, destinato a superare confini e tradizioni nazionali. Il secondo parlava, invece, di un capitale monopolistico, figlio dell’intreccio inestricabile tra banche e grandi industrie, a base nazionale e fortemente competitivo: grazie al suo legame profondo con l’organizzazione, anche militare, dello Stato.
Fu il conflitto tra i Paesi, che avevano adottato quel modello, a dare origine alla Grande guerra: prima semplice conquista coloniale, quindi scontro totale. Finì come finì: 16 milioni di morti, 20 milioni di feriti e mutilati. Cui sommare la decina di milioni di persone – il numero esatto non si conosce – uccise dalla “spagnola”, quell’epidemia che somiglia così da vicino alla peste del Covid-19. Allora il contagio si diffuse nel meticciato e nella promiscuità delle trincee, oggi con l’intensificazione degli scambi e dei movimenti indotti dalla pacifica globalizzazione. Cambia l’ordine dei fattori, ma identico è stato il risultato finale.
La Grande guerra si concluse con un disastro. La rivoluzione d’ottobre divise, per quasi un secolo, il vecchio continente. Gli Impero centrali furono spazzati via. La Germania costretta al pagamento di quelle riparazioni di guerra, che alimentarono un senso di frustrazione generale: il brodo di coltura che portò alla nascita del nazismo. La Gran Bretagna e la Francia si cullarono nel loro sciovinismo. L’Italia messa all’angolo, con la sua “vittoria mutilata”, in attesa che Benito Mussolini prendesse il potere. Mentre gli Stati Uniti, che della guerra erano stati i veri vincitori, non compresero, come scriverà più tardi Charles Kindleberger, la necessità del dover esercitare la loro leadership mondiale.
La seconda globalizzazione ha avuto più la faccia di Hilferding che non quella di Lenin. È stata soprattutto la grande finanza internazionale a guidare il processo. A spostare le ingenti masse di capitali verso la periferia del mondo dove maggiori erano le occasioni di profitto, per via di una mano d’opera a basso costo ed una produzione libera dai condizionamenti – a partire da quelli ambientali – vigenti nei Paesi a più antica civilizzazione. La fortuna dei Brics si spiega soprattutto così. Un gigantesco ombrello finanziario – 10/15 volte il Pil mondiale – è stato la stampella di un capitale apolide, in grado di vivere di vita autonoma. Senza dover più dipendere dall’involucro statuale, che aveva caratterizzato la prima globalizzazione.
Si spiega così la sofferenza stessa degli Stati Uniti: forse le vittime più illustri dei grandi cambiamenti geopolitici intervenuti. Nel 1980 la Cina pesava sul Pil mondiale per il 2,3 per cento e gli Usa per il 21,5. Nel 2020 rispettivamente per il 19,7 e per il 14,9 per cento. Nei grandi vasi comunicanti dell’economia mondiale, una parte crescente del surplus (Paul Sweezy) era stata trasferita dalle vecchie metropoli verso le periferie del mondo, distruggendo l’antico benessere della classe media occidentale. Sempre più impaurita ed impoverita, mentre una ristretta minoranza, in loco, godeva dei benefici della globalizzazione.
Come rispondere a questi fenomeni? Lasciamo perdere i riferimenti al populismo: a sinistra visto come il fumo negli occhi. Dimentichi tuttavia che il leninismo fu contaminazione di Marx con il populismo russo.
E che lo stesso Joe Biden, nel suo intervento, ha citato volutamente “We the people”. Che è anche il “grido” con cui si apre la Costituzione americana. Parliamo invece del sovranismo. Di quel tentativo di reagire ai guasti indotti da una globalizzazione malata, di cui questa stessa impostazione è stata figlia bastarda. Donald Trump negli Usa, Marine Le Pen in Francia, Bernd Lucke in Germania, Nigel Farage in Gran Bretagna, Giorgia Meloni in Italia non sono angeli maledetti. Ma solo coloro che hanno fondato la loro prospettiva politica sul lato oscuro della globalizzazione.
Può essere un ritorno agli anni ’20, la strada maestra per fronteggiarne la crisi? Le chiusure di allora contro le ferite della guerra. Quel rintanarsi dei singoli Stati in sé stessi, fino a regredire nelle forme più cupe dell’autarchia. Difficile credervi, nel mondo di internet e della comunicazione integrale. E quindi? La soluzione non può che essere altra. Quella di un controllo che finora non è stato nemmeno tentato. Che cerchi di garantire lo sviluppo delle tecnologie che la globalizzazione ha, indubbiamente, favorito, evitando, tuttavia, il dominio dei più potenti e le loro voglie di supremazia. Da questo punto di vista difendere i grandi interessi nazionali non significa altro che voler contribuire, nelle forme che saranno possibili, ad un nuovo multilateralismo, più aperto, più democratico, verrebbe da dire. Che, partendo dal basso, sia superamento dell’esperienza passata.
In Italia questa strada passa inevitabilmente per un’Europa diversa. Che ancora deve nascere. E di cui, forse per la prima volta, con il Recovery Fund, si ode un vagito. Ne consegue che l’Europa non può essere una discriminante, come dice Bersani, perché la lotta per cambiarla deve essere comune. Superando la falsa alternativa rappresentata da una semplice icona, cui sottomettersi senza discutere; per poi scadere nella caricatura di una sorta di reincarnazione del Terzo Reich, (copyright di Alberto Bagnai) contro il quale scendere in campo.