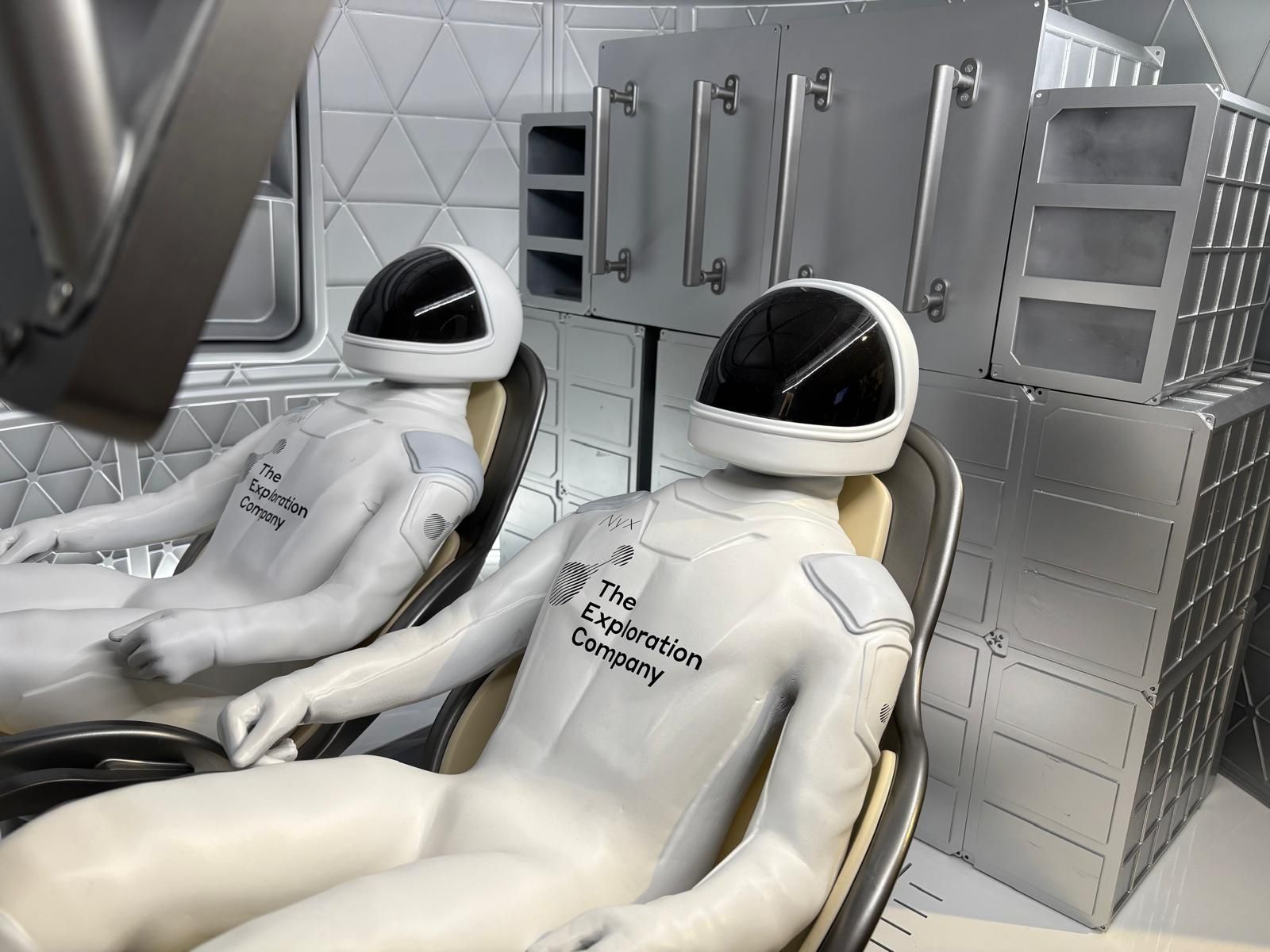Per quanti sforzi vorrà o potrà compiere il presidente del Senato Ignazio La Russa di procurare più voti della maggioranza di centrodestra alla riforma costituzionale del premierato – o del “balconato forte”, come l’ha definito Stefano Rolli in una vignetta sulla Stampa – sarà ben difficile evitarle il passaggio referendario. Che è risultato fatale alle riforme tentate in passato da Matteo Renzi, tentato adesso dall’appoggio, e da Silvio Berlusconi. Sarà difficile non solo per la debolezza, diciamo così, del mediatore che si è proposto. Il quale sarà pure legittimamente la seconda carica dello Stato, toccandogli la supplenza del presidente della Repubblica in caso di impedimento, ma è pur sempre divisiva anche per fatti e polemiche sopraggiunte alla sua elezione, l’anno scorso.
UNA RIFORMA DIVISIVA
Ancor più divisivo, per come sono già schierate le forze politiche, è il contenuto della riforma, anzi della “madre di tutte le riforme” secondo Giorgia Meloni, in qualche modo aggravato dai tentativi già cominciati di coinvolgere nelle polemiche, contro il desiderio o le intenzioni dell’interessato, il presidente in carica della Repubblica. Di cui si sono persino prospettate le dimissioni, a riforma eventualmente approvata in Parlamento e ratificata dall’elettorato, un po’ per presa d’atto obbligatoria o opportuna di un nuovo quadro istituzionale e un po’ per reazione a un cambiamento in cui sarebbe implicito, se non addirittura cogente, un giudizio negativo su come anche lui avrebbe esercitato il suo mandato al Quirinale, come il predecessore Giorgio Napolitano ed altri. E ciò anche nella gestione insindacabile delle nomine a senatore a vita per alti meriti che non a caso ora si vogliono non ridurre ma abolire. “Una riforma che la fa finita con i re al Quirinale”, ha titolato in apertura del cantiere il giornale La Verità, ritenendo di esprimere anche l’opinione più recondita della premier Meloni, molto critica con i presidenti di turno della Repubblica prima di arrivare a ridosso di Palazzo Chigi.
IL VANTAGGIO DI MELONI
Diversamente però dalla pur esperta del ramo Alessandra Ghisleri, che ha appena certificato o pronosticato da sondaggista un “tiepido” appoggio popolare alla riforma varata dal governo, penso che stavolta il passaggio conclusivo del referendum potrà risultare meno rischioso del passato: tutt’altro che “lo schianto” previsto, anzi auspicato ribaldamente da Giuseppe Conte. Innanzitutto perché la Meloni ha furbescamente separato – al contrario di Renzi nel 2016 – la fortuna personale sua e del governo dal risultato della verifica nelle urne. E in secondo luogo perché stavolta votando no l’elettorato rinuncerebbe alla prerogativa che gli viene offerta di contare davvero, eleggendo in modo diretto e vincolante il capo del governo, insieme col Parlamento.
Sì, so bene che nel 1991 in un altro referendum l’elettorato rinunciò al voto di preferenza di cui disponeva nell’elezione dei deputati. Ma era una posta oggettivamente inferiore a questa. E vorrei sapere quanti degli elettori superstiti di quella scelta siano ancora convinti di avere fatto la cosa giusta, e di non avere invece clamorosamente sbagliato, visto l’uso fatto dai partiti della fiducia risposta nella loro capacità di selezionare i candidati facendone in partenza la graduatoria. Cioè, di nominarli.
IL PARERE DI ZAGREBELSKY
Che le cose questa volta possano andare diversamente dal passato, tra Parlamento e referendum, nel percorso di una riforma costituzionale pur politicamente divisiva, credo che lo abbia capito o avvertito anche l’ottantenne presidente emerito della Consulta Gustavo Zagrebelsky – un’autorità in materia – scrivendo del premierato elettivo proposto dal governo in modo ironico, mostrandosi per finta o davvero più giovanilmente ottimista che pessimista per età. Lo ha fatto con una tale efficacia che, pubblicandone l’articolo, la Repubblica – dichiaratamente ostile a quello che aveva già definito su tutta la prima pagina “l’assalto alla Costituzione” – ha voluto precisarne la natura appunto ironica e ricordare, col compianto Norberto Bobbio, che “gli ottimisti non sempre sono fatui, ma i fatui sono sempre ottimisti”.
D’altronde, proprio Zagrebelsky come antidoto alla riforma ha preferito non gli scenari apocalittici evocati nel 2016, quando lui contrastò nella campagna referendaria la riforma Renzi, ma il rinsavimento dei partiti minori, destinati all’irrilevanza politica con l’elezione diretta del presidente del Consiglio e il rischio di elezioni anticipate in caso di crisi. Ma ad essi – i partiti minori – la Meloni ha già pagato un prezzo confessato con un certo rammarico nella conferenza stampa di illustrazione della riforma. È il prezzo del cosiddetto premier bis, o “subordinato” come si diceva nella prima Repubblica, quando all’apertura di una crisi di governo si prospettavano più soluzioni. E si finiva sempre per ripiegare, appunto, sulla subordinata a danno della prima.
In particolare, ai partiti minori di una maggioranza si è concessa la possibilità che in caso di crisi il presidente della Repubblica – a dispetto della rappresentazione che se ne fa come di un degradato a funzioni decorative – cerchi di salvare la legislatura nominando un altro presidente del Consiglio fra i parlamentari eletti nello schieramento uscito vincente dalle urne. Un premier paradossalmente più forte dell’altro perché esso sì provvisto della deterrenza elettorale, non potendosi più sottrarre il capo dello Stato in un’altra crisi allo scioglimento anticipato delle Camere. Una gabbia perfetta, direi senza ironia, per un premierato all’italiana, come è stato realisticamente definito, considerando le abitudini e i caratteri dei nostri partiti, vecchi e nuovi.