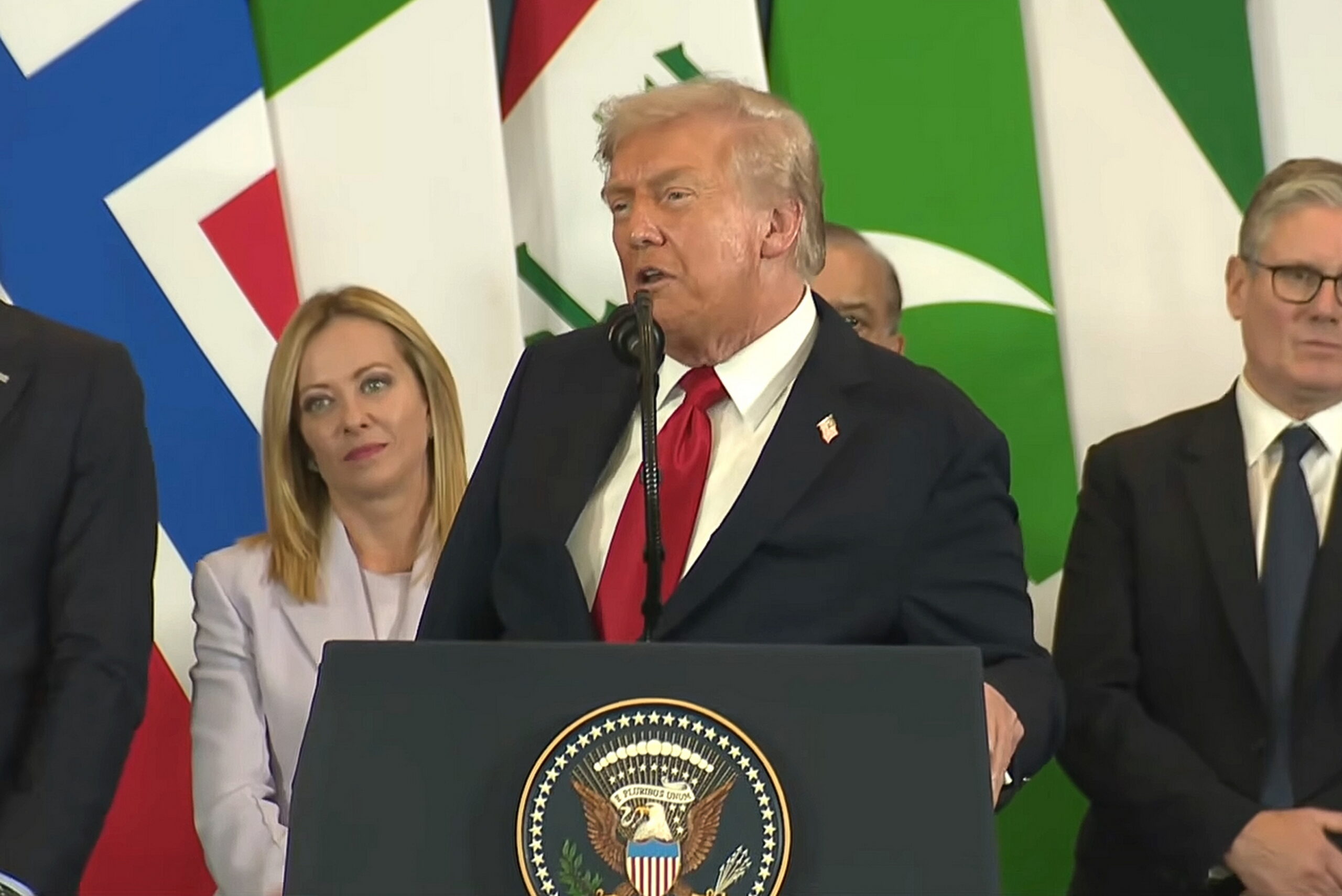La Brexit è fatta ma nessun dramma, please. Forse avremo un’Unione più coesa, mentre nel Regno Unito si rinnoverà quell’esperimento nazionale le cui origini risalgono all’Alto Medioevo, ai normanni e alla dinastia dei Plantageneti, che gettarono le fondamenta del sistema politico e amministrativo inglese. Come ha osservato Claudio Martinelli in un libro esemplare, da cui sono tratte queste note, (“Diritto e diritti oltre la Manica. Perché gli inglesi amano tanto il loro sistema giuridico”, il Mulino, 2014), la “common law” ha costituito un ordinamento originario e autoctono, legato ad una cultura delle relazioni tra suddito e potere molto diversa da quella continentale.
Un ordinamento vissuto come pilastro della vita civile e come baluardo a difesa delle libertà individuali. Di conseguenza, le sue istituzioni godono di una forte autorevolezza, a cominciare dalle “corti di common law”, luoghi in cui si esercita la “rule of law”, ovvero il primato della norma sul capriccio del potere, l’uguaglianza di fronte alla legge praticata basata su un patrimonio di antichi valori e principi giuridici resi effettivi dalla giurisprudenza. I poteri pubblici, compreso il sovrano, creatore e garante di un’organizzazione giudiziaria unitaria sul territorio del regno, vengono percepiti come strumenti per la difesa dei diritti, come protezione delle sfere di libertà e rimedio giurisdizionale contro i comportamenti antigiuridici.
Lo Stato è visto quindi come arbitro della giustizia e non come contraltare della vita civile e sociale. Ha scritto Roger Scruton, uno dei più influenti pensatori del conservatorismo anglosassone, che “Una giurisdizione acquisisce la sua validità o da un passato antichissimo o da un contratto fittizio tra persone che già condividono una terra. Prendiamo il caso degli inglesi. Una giurisdizione consolidata, definita dal territorio, ci ha incoraggiato a stabilire i nostri diritti e i nostri privilegi, e fino dai tempi dei sassoni ha sancito una responsabilità reciproca fra ‘noi’ e il sovrano, che è il ‘nostro’ sovrano. […] La nascita della nazione inglese — come forma di appartenenza — non può essere in alcun modo considerata un prodotto dell’universalismo illuministico, della rivoluzione industriale o delle necessità amministrative di una burocrazia moderna. Non solo esisteva prima di tutte queste cose, ma le ha anche forgiate facendone i suoi potenti strumenti” (“Manifesto dei conservatori”, Cortina, 2007).
Questa tradizione giuridica è strettamente legata alla dimensione insulare, altro punto cruciale per comprendere la sua saldezza. Abitare un’isola ha storicamente rivestito per gli inglesi una doppia valenza. Innanzitutto la lotta per il dominio del territorio, accompagnata da un ancestrale complesso di superiorità nei confronti delle altre popolazioni autoctone. Una sorta di “colonialismo interno”, spesso responsabile di vessazioni terribili nei confronti dei popoli vinti. Cionondimeno, al di là di ogni giudizio etico, si trattò di un fattore molto rilevante per la formazione della coscienza nazionale.
Ma un’importanza forse ancor più decisiva — sottolinea Martinelli — ha avuto il secondo profilo della dimensione insulare, e cioè la convinzione, plasmata dalla storia, di essere ripetutamente chiamati a difendere l’integrità del territorio dalle minacce esterne, provenienti in particolare dal Vecchio continente. Beninteso, anche l’Inghilterra, come tutte le altre moderne nazioni europee, è il risultato di una storia di invasioni e conflitti. Tuttavia, esaurita l’età medievale, delineate le sue istituzioni e stabilizzati i suoi confini, essa trova nella difesa contro le mire espansionistiche di molti sovrani europei una ragione di orgoglio e identità nazionale. Una difesa non solo affidata alla forza militare, ma fortificata dall’orgoglio popolare di preservare l’Isola e le sue tradizioni di libertà dalla sopraffazione del potere assoluto.
Se non si accolgono questi concetti non si riesce a capire l’attaccamento, conservatore nel senso più alto del termine, verso la monarchia, espressione dei valori e dei simboli attorno ai quali è andata formandosi la nazione soprattutto nei momenti più critici della sua storia, come quello della lotta di Elisabetta I contro l’Invecible armada spagnola. Un richiamo morale al sacrificio per la loro conservazione che arriva, senza soluzione di continuità, fino al celebre discorso “lacrime e sangue” tenuto da Winston Churchill durante la Seconda guerra mondiale, che convinse il popolo della necessità di una strenua resistenza a Hitler.
E un ragionamento analogo vale, infine, per la dimensione religiosa. Il “Supremacy Act” con cui Enrico VIII nel 1534 opera lo scisma dal Papato di Roma istituendo la Chiesa d’Inghilterra è del tutto privo di sostanza teologica ed è invece estremamente carico di motivazioni politiche che, ancora una volta, attengono alla pretesa inglese di non subire condizionamenti di sorta da parte di poteri esterni alle istituzioni della nazione. Il reale scopo del sovrano era circoscrivere il potere dei corpi sociali che erano in stretto collegamento con la Chiesa di Roma e spesso si mostravano refrattari a riconoscere come sola autorità politica quella del Re.
In questo modo la nuova confessione assurge al ruolo, che tuttora detiene, di “established church”, ovvero di Chiesa costituzionale, vero e proprio status di istituzione fondante lo spirito nazionale e l’architettura dello Stato, molto di più e di diverso rispetto ad una qualunque Chiesa di Stato; contemporaneamente l’anglicanesimo comincia ad entrare nella forma mentis degli inglesi come irrinunciabile completamento delle loro specificità e parte integrante della cultura, da difendere contro minacce e insidie al pari del territorio e delle altre istituzioni. Un’acquisizione che si rivelerà di capitale importanza nel secolo successivo, durante il lungo braccio di ferro del parlamento anglicano contro la dinastia Stuart.
Il Seicento rappresenta il momento decisivo per lo sviluppo della tradizione inglese, vero e proprio spartiacque in cui la cultura britannica respinge il rischio dell’omologazione e quindi della negazione della propria storia. Il tema cruciale è appunto l’ascesa al trono della dinastia Stuart, favorita dall’assenza di eredi alla morte di Elisabetta Tudor. Nel 1603 si forma l’unione personale tra i due regni: lo Stuart Giacomo VI di Scozia diventa anche Giacomo I d’Inghilterra e dunque due nazioni da sempre in lotta si ritrovano sotto la stessa Corona. Ma ovviamente la storia non si cancella con una cerimonia di incoronazione e il conflitto prosegue sotto forme diverse. Gli inglesi percepiranno sempre gli Stuart come una dinastia sostanzialmente straniera, portatrice di valori e costumi non sovrapponibili ai loro, ma ciò che più conta animata sul piano politico da volontà assolutistiche, che guardava alla Francia di Luigi XIV come il modello da seguire e imitare, con cui cercare un’alleanza militare e ideale.
Come si vede, “un concentrato di fattori in palese antitesi con le dinamiche storiche che avevano portato gli inglesi a diventare un popolo e a formare una nazione. Per giunta, con il tempo, gli Stuart matureranno e accentueranno sempre più una vicinanza spirituale e politica con il cattolicesimo di Roma e con la figura del Papa, revocando così in dubbio la constituency anglicana dello Stato su cui stavano regnando” [Martinelli]. Ve ne era abbastanza per scatenare un conflitto con il parlamento e le “corti di common law”. L’alleanza tra questi pilastri dello Stato imporrà agli Stuart un braccio di ferro lungo quasi un secolo, che troverà una soluzione definitiva solo con la Seconda Rivoluzione del 1688-89.