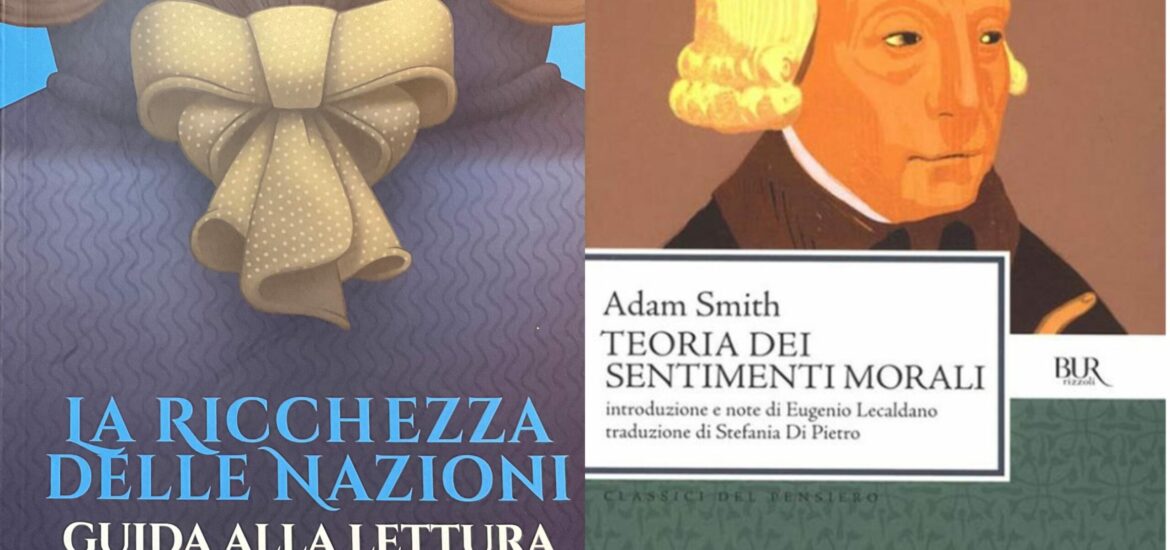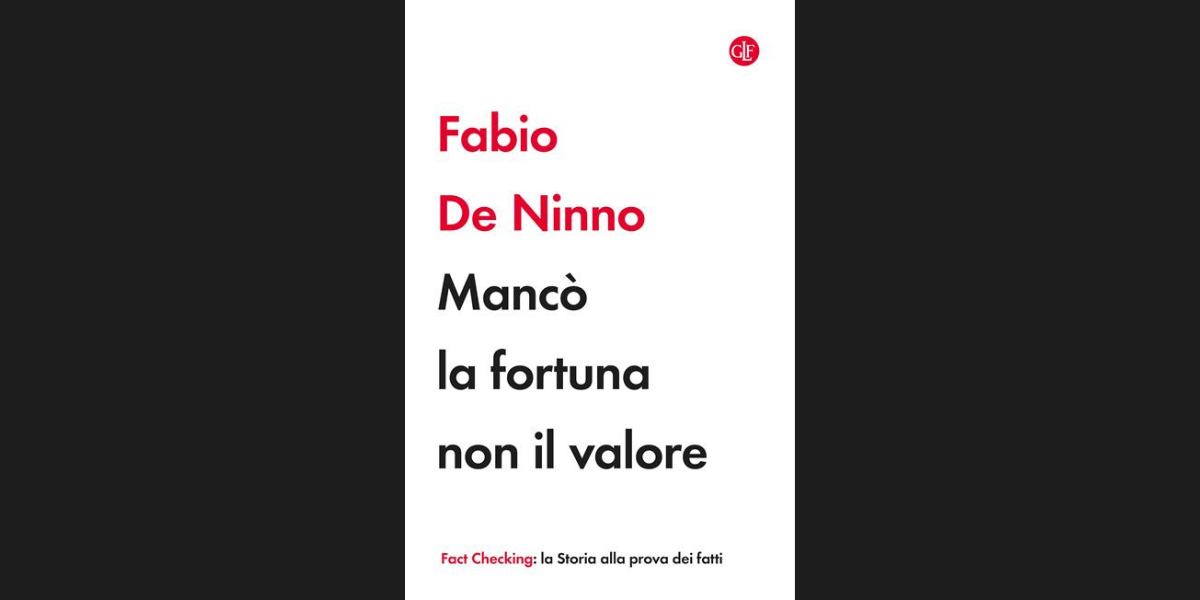Questo testo riprende, con alcune note aggiuntive, una recensione pubblicata sul quotidiano Italia Oggi il 9 febbraio 2024 (Mi.Ma)
Adam Smith è stato un gigante del pensiero occidentale e La Ricchezza delle nazioni (d’ora in poi, La Ricchezza) è uno dei grandi libri che hanno contribuito a plasmarlo. Tuttavia, non nasconde la sua età. Diversi storici hanno messo in evidenza lo scarto temporale -seppur minimo- che lo separa dal decollo vero e proprio della rivoluzione industriale. John Kenneth Galbraith ha scritto che “se Smith avesse visto le fabbriche fumanti, le macchine, la concentrazione massiccia degli operai che fecero la loro comparsa alla fine del XVIII secolo, sarebbero stati questi fenomeni, e non la manifattura di spilli e la divisione del lavoro, a colpire la sua attenzione” (Storia dell’economia, Rizzoli, 1990). Ciononostante, è un libro che continua a suscitare una forte curiosità, come argomenta con impareggiabile chiarezza Maria Pia Paganelli nel suo ultimo saggio (La ricchezza delle nazioni. Guida alla lettura, IBLlibri, dicembre 2023).
Smith nasce a Kirkaldy, in Scozia, il 5 giugno 1723. Figlio di un controllore delle dogane, nella scuola parrocchiale apprende i primi rudimenti di latino e greco. Nel 1737 si iscrive al Glasgow College, dove frequenta i corsi di tre professori d’eccezione: il filosofo Francis Hutcheson, il matematico Robert Simson, l’astronomo Robert Dick. Nel 1740 è studente del Balliol College, dotato di una delle migliori biblioteche di Oxford. Nel 1748 è a Edimburgo, dove tiene un ciclo di conferenze sulla retorica. Nel 1751 occupa la cattedra di Logica all’università di Glasgow.
Nel 1759 pubblica la Teoria dei sentimenti morali, che diventa rapidamente un best seller. Ormai famoso, nel 1761 fonda con l’amico David Hume l’Edimburgh Poker Club, che si batte per l’abolizione delle leggi protezionistiche, in particolare di quelle sul grano. Grazie alla fama acquisita, viene assunto come tutore del giovane duca di Buccleuch, uno dei maggiori latifondisti scozzesi. Nel 1763 lo accompagna in un Grand Tour in Svizzera e in Francia. A Ginevra incontra il “veneratissimo” Voltaire. Dopo un lungo soggiorno nella “attiva e ricca” Bordeaux e nella “pigra e modesta” Tolosa, raggiunge Parigi. Nella capitale francese, si vede spesso con d’Holbach e Helvetius. A Versailles conosce François Quesnay, medico personale di Luigi XV e capofila della scuola fisiocratica.
Tornato in patria nel 1766, la famiglia del duca gli concede una generosa pensione come compenso dei suoi servigi. Smith può così ritirarsi nel borgo natio e dedicarsi alla stesura definitiva della Ricchezza. La tiratura della prima edizione (3.500 copie), stampata a Londra nel marzo 1776, si esaurisce in pochi giorni. Preoccupati dalle crescenti tensioni con le colonie del Nord America, culminate nella Dichiarazione di indipendenza del luglio dello stesso anno, molti sudditi di Giorgio III erano ansiosi di leggere le sue valutazioni sulle prospettive dell’impero britannico. Sebbene le sue finanze gli consentissero ormai un’esistenza confortevole, nel 1777 si trasferisce a Edimburgo per assumere l’incarico di commissario alle Dogane. Prima di morire, il 17 luglio 1790, aveva chiesto ai suoi esecutori testamentari, il chimico Joseph Black e il geologo James Hutton, di bruciare tutti i suoi manoscritti, almeno diciotto tomi.
Nell’Introduzione della Ricchezza, un paio di pagine in cui riassume il suo l’impianto, Smith afferma che il lavoro è il “fondo” che fornisce “i mezzi di sussistenza e di comodo” consumati da una nazione. La principale fonte della ricchezza è dunque il lavoro, non l’oro né la terra (che peraltro non viene menzionata). La sua polemica è rivolta anzitutto contro i mercantilisti, i quali invece ritenevano che la ricchezza derivasse dall’accumulazione dei metalli preziosi. Mentre è il fondo del lavoro che consente l’acquisto dei beni di prima necessità e di quelli di “comodo”, ossia di lusso. Le persone, ad esempio, desiderano non solo una teiera di rame, ma una d’argento. Infine, è la nostra capacità di consumare che ci rende ricchi. Una tesi anche questa indigesta ai mercantilisti, che volevano premiare le produzioni interne costose e scoraggiare le importazioni estere a buon prezzo. Soltanto la ricchezza creata dal lavoro umano, insomma, ci consente di vivere e anche di vivere bene.
L’intransigente difesa smithiana del libero mercato, l’unico -al di là dei suoi limiti e difetti- in grado di assicurare prosperità e giustizia, è in buona parte figlia del movimento dei club della Scozia settecentesca. I club erano circoli in cui si incontravano periodicamente le élite borghesi per dibattere argomenti all’ordine del giorno, politici, economici e culturali. Diversamente dai “salon” francesi, erano rigorosamente maschili. I soci appartenevano ai ceti più disparati: imprenditori, scienziati, avvocati, letterati, accademici. Quasi tutti, ovviamente Smith incluso, erano o diventeranno personalità più o meno illustri dell’Illuminismo scozzese.
Il movimento dei club era il sintomo di profonde trasformazioni sociali e istituzionali seguite all’unione con l’Inghilterra nel 1707. Grazie ad essa, la Scozia ottiene l’accesso ai vasti mercati d’oltremare, compreso quello delle colonie della Corona. Glasgow diventa così il porto più importante per il commercio mondiale del tabacco. Inoltre, le manifatture di lino e la raffinazione dello zucchero, la produzione del ferro e l’estrazione del carbone, la pesca e le attività conciarie, si espandono a macchia d’olio anche grazie al sostegno di un sistema bancario ormai competitivo e sofisticato.
L’unione con l’Inghilterra fu però anche l’inizio di gravi tensioni politiche. Le Highlands (regioni montuose) si sentivano orfane della dinastia Stuart, deposta nel 1688. Più di una insurrezione armata tenta di riportarla sul trono. La più temibile scoppia nel 1745. Le milizie di Charles Edward Stuart riescono a spingersi senza incontrare resistenza fino a Derby, distante qualche decina di miglia da Londra. Verranno sconfitte dall’esercito di Giorgio II solo l’anno successivo, a Culloden. Questo episodio turba profondamente Smith, per giunta costretto a subire lo scherno dei suoi compagni di studio a Glasgow.
La Scozia, infatti, era ancora considerata un paese di “montanari a culo nudo”, come lo chiamava Hume. Ma quella ribellione era anche un monito, poiché poche migliaia di quei “montanari nudi e inermi” -qui le parole sono di Smith- erano riusciti ad arrivare indenni alle porte della capitale di un impero planetario. In ogni caso, anche dopo la battaglia di Culloden continuarono a coesistere due Scozie: le anglofone Lowland (le regioni di pianura), di religione protestante e politicamente whig; e le Higland, tribali e di lingua gaelica, ostili allo stato britannico e alle sue leggi, di religione cattolica o episcopale, politicamente tory, che le classi dirigenti più illuminate volevano “migliorare”.
Proprio alla ideologia del “miglioramento” si ispirarono tutti i tentativi di modernizzare le tecniche di produzione, applicando in ogni suo campo il metodo sperimentale delle scienze fisiche. Lo stesso metodo, fondato su un sapere rigoroso e sull’esperienza concreta, per Smith andava adottato nello studio della natura umana. Infatti, il titolo originale per esteso della Ricchezza recita: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Significa che non è un trattato, non consta di principi rigidi e non ha niente di dottrinario. È un’indagine, un’indagine in cui vengono formulate ipotesi controllate con i dati e le informazioni che la storia mette a disposizione.
Come sottolinea Paganelli, non fortuitamente Smith viene considerato con attenzione e rispetto dagli economisti sperimentali odierni. L’economia sperimentale è un ramo relativamente nuovo della teoria economica, che studia sul campo i comportamenti e la condotta delle persone in carne ed ossa. Uno dei suoi pionieri, il Nobel per l’economia Vernon Smith (2002), ha seguito la strada aperta dal suo eminente omonimo. Smith voleva capire in che modo i paesi diventano ricchi, ben sapendo che nei paesi poveri si muore ingiustamente: “Questi popoli vivono in una povertà così orribile da essere talvolta costretti […] a sopprimere direttamente o ad abbandonare all’inedia o alle bestie feroci i loro bambini, i loro vecchi e coloro che sono affetti da malattie”. La questione che egli pone Smith è quindi una questione morale.
Al filosofo scozzese si deve la scoperta del meccanismo della “mano invisibile”, mediante il quale la cura del proprio interesse da parte “del macellaio, del birraio o del fornaio” si trasforma inaspettatamente in un beneficio per l’intera società. Ma di Smith è anche questa frase: “Per quanto egoista si possa ritenere l’uomo, sono chiaramente presenti nella sua natura alcuni principi che lo rendono partecipe delle fortune altrui, e che rendono per lui necessaria l’altrui felicità, nonostante da essa egli non ottenga altro che il piacere di contemplarla”.
È l’incipit della Teoria dei sentimenti morali, un’opera che appartiene a quel filone di pensiero che Locke a Hume, da Shafstebury a Hutcheson, pur tra notevoli differenze e sfumature, cercava di opporre il lato benevolente, altruistico e disinteressato della natura umana alla concezione pessimistica, intrisa di invidia e egoismo, inaugurata da Hobbes, condivisa in parte dal Mandeville della Favola delle api, e richiamata in qualche misura anche dal macellaio, birraio e fornaio smithiani.
Tuttavia, Smith colloca al centro della sua filosofia morale proprio quella spontanea tendenza degli individui a mettersi nei panni degli altri, da cui deriva la sua figura di osservatore “simpatetico e imparziale”. La giustizia, l’umanità, la generosità, lo spirito pubblico sono per lui requisiti imprescindibili di una pacifica convivenza sociale. Ciò non gli impedisce di considerare la “prudenza”, di cui un accorto perseguimento dei propri interessi è una parte, la più importante delle virtù cardinali. L’ambizione più alta di Smith era comprendere come questa virtù umana, umanissima, poteva contribuire all’incremento del benessere generale e, insieme, al corretto funzionamento delle libertà di mercato. Ambizione che solo un libro pieno di idee, di intelligenza critica e di senso morale era in grado di lasciare in eredità ai posteri.