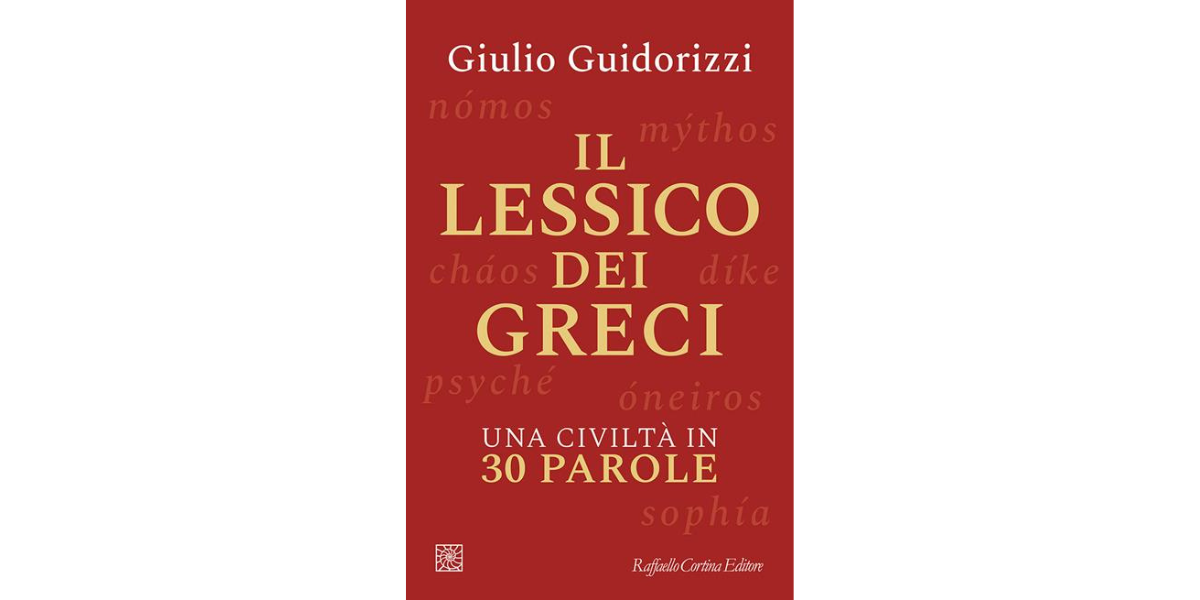Il suo nome qualche volta è evocato per rivendicare i quarti di nobiltà che ha la dottrina della “pace a qualunque costo”. Negli articoli degli intellettuali più irriducibili del pacifismo etico, invece, viene spesso citato per legittimare una sorta di obiezione di coscienza all’invio di armi in Ucraina. Il nome è quello di Immanuel Kant, l’autore di Zum ewigen Frieden, noto in Italia con il titolo improprio, ma ormai canonico, Per la pace perpetua. È considerato uno dei suoi testi più celebri e suggestivi, un autentico capolavoro d’ineguagliabile eleganza e straordinaria originalità. Tuttavia, come dimostra un saggio di Marco Duichin (di cui sono debitrici queste note), nel corso di oltre due secoli ha prodotto una bibliografia sconfinata in cui si possono trovare le interpretazioni più disparate. È stato infatti letto come un edificante appello pacifista, un appassionato manifesto rivoluzionario, un imprescindibile punto di riferimento nel dibattito teorico sulle relazioni internazionali (Alla pace del cimitero, Firenze University Press, disponibile anche in pdf).
In una lettera del 13 agosto 1795, a quattro mesi dalla ratifica della pace separata di Basilea tra il regno di Prussia e la Francia rivoluzionaria (5 aprile 1795), accolta da Kant con “intima gioia” e salutata da molti osservatori come la premessa di una pace definitiva e completa tra le potenze europee, l’anziano filosofo annunciava all’editore Friedrich Nicolovius l’imminente invio di un manoscritto intitolato, appunto, Zum ewigen Frieden. Già il 4 ottobre, il volumetto vedeva la luce a Königsberg (oggi Kaliningrad) in una prima tiratura di duemila copie, che andò rapidamente esaurita e fu seguita da un’immediata ristampa. Il volumetto, redatto secondo i classici moduli dei trattati internazionali di pace, con tanto di articoli preliminari, definitivi e segreti, di supplementi di garanzia e persino d’una clausola di salvaguardia con cui Kant intendeva tutelarsi dalla censura prussiana, si apriva con un breve ma cruciale preambolo, che reiterava nell’esergo il titolo dell’opera, curiosamente ispirato all’iscrizione satirica posta sull’insegna di una locanda olandese, ove era dipinto un cimitero.
Celebrato da molti contemporanei tedeschi come un modello insuperabile sul tema dell’agognata “pace perpetua”, lo scritto di Kant, talvolta indebitamente assimilato al chimerico Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe (1713) dell’abate di Saint-Pierre, suscitò una vastissima eco, riscuotendo un largo successo di pubblico anche al di fuori dei confini germanici. Guardato con sospetto negli ambienti conservatori inglesi come un testo “giacobino”, pericolosamente orientato a favore della Francia rivoluzionaria con cui la Gran Bretagna era ancora in guerra, fu soprattutto nei circoli d’oltralpe vicini a Emmanuel-Joseph Sieyès a ricevere apprezzamenti entusiastici.
Come ricorda Duichin, per consuetudine Zum ewigen Frieden venne così accostato a quel nutrito filone di opere che, a partire da alcuni scritti a carattere retorico-esortativo e filantropico-religioso apparsi nel XVI e XVII secolo, come la Querela pacis di Erasmo da Rotterdam (1517), culminerà in una cospicua messe di trattati settecenteschi sul tema della “pace perpetua”, doveIn virtù di questa parentela, malgrado le differenze abissali che lo separano da tali opere, è stato spesso visto come un vero e proprio manifesto pacifista, talora sbrigativamente elevato al rango di modello del pacifismo etico, in cui la condanna umanitaria della guerra va di pari passo con l’edificante appello a favore di un’ecumenica convivenza fra uomini d’ogni razza e nazione.
Ma a differenza dell’integralismo pacifista, ancorato all’assunto erasmiano che “la pace più ingiusta è migliore della più giusta delle guerre”, ovvero che la pace è il bene supremo, da anteporre incondizionatamente a ogni altro valore (libertà inclusa), Kant respinge decisamente l’idea di una pace realizzata a qualsiasi prezzo, anche a costo di essere edificata sul “cimitero della libertà”. E, pur riconoscendo nella guerra un “flagello del genere umano”, non la considera però un “male così incurabile” come la ben più temuta “tomba di un dominio unico”. Egli infatti mette in guardia contro i rischi di una pace universale e durevole realizzata “sotto un solo sovrano”, destinata a sfociare nel “più orribile dispotismo”. Non sorprende perciò che Zum ewigen Frieden, già all’indomani della sua apparizione, sia stato accolto con favore negli ambienti progressisti e francofili, con diffidenza e sospetto negli ambienti conservatori e assolutisti, dalle cui pagine sembrava trapelare addirittura un implicito appoggio alla violenza che la Francia prometteva di scatenare contro l’Antico regime europeo.
Se però l’immagine settecentesca di un Kant pacifista risulta in larga misura improbabile, la speculare tesi di un Kant giacobino è priva di fondamento. La sua “pace della ragione”, basata sul riconoscimento del “contrasto pacifico tra i popoli”, ha sicuramente ben poco in comune con l’ingenua utopia pacifista che vagheggia l’estinzione di ogni conflitto. Del resto, fatta salva la sua indiscussa simpatia per la Francia repubblicana, i moniti e i timori espressi dal filosofo in diversi luoghi di Zum ewigen Frieden riguardavano proprio il ricorso indiscriminato alla guerra “pacificatrice” teorizzata dall’ala più radicale dei rivoluzionari francesi, convinti assertori dell’idea che, sull’altare della pace futura, potesse essere giustificato qualunque mezzo, persino una guerra di sterminio.Il progetto kantiano di sostituzione della guerra con il diritto, insomma, è sideralmente distante sia dal fondamentalismo rivoluzionario e messianico, per il quale tutti i mezzi sono leciti pur di ottenere la pacificazione finale degli stati europei sotto il dominio francese, sia dalla “pace dell’amore” di Robespierre: di un amore, però, destinato a trionfare pienamente solo dopo aver eliminato con la forza coloro che lo soffocano.
Diversamente da Robespierre, la pace perpetua di Kant non è il frutto dell’amore fra gli uomini, né deve giovare al loro benessere e alla loro felicità, ma “è unicamente conforme al diritto”: essa non è affatto “uno stato finale etico-religioso” né “un paradiso terrestre”, bensì la pura “regolazione giuridica degli antagonismi”. Animati da un’ideologia filantropica, messianica, apocalittica, espansionista e certa della sua rettitudine, i giacobini francesi miravano invece alla eliminazione di ogni antagonismo e all’instaurazione universale di una pace perenne -ossia definitiva e assoluta- attraverso una guerra rivoluzionaria che avrebbe inaugurato, grazie a un ultimo “spasmo di violenza”, una nuova èra di beatitudine. La connessione tra pace perpetua, felicità dei popoli ed età dell’oro, intesa come condizione ideale per il tranquillo godimento dei beni terreni, è del tutto estranea al pensiero kantiano, ma sembra piuttosto riecheggiare, come aveva intuito l’ex-montagnardo Danton, arcaiche e mai completamente dimenticate credenze folkloriche nel leggendario “Paese di Cuccagna”: quel luogo mitico ove il benessere, l’abbondanza e il piacere sono alla portata di tutti. Per quanto paradossale possa apparire, il pacifista Kant al contrario paventava – non meno del “bellicista” Hegel – gli effetti rovinosi di una “lunga pace”, in cui il predominio del “basso interesse personale”, della “viltà” e della “mollezza” avrebbe corrotto “il carattere e la mentalità del popolo”.
Risale a un eminente studioso del pensiero kantiano, Vittorio Mathieu, la proposta di rendere con Alla pace perpetua, anziché con il consueto – ma fuorviante – Per la pace perpetua, il titolo italiano del volumetto, tenendo giustamente conto del prologo, nel quale Kant si riferisce all’insegna di un’osteria. E’ curioso che nel tradurre questo titolo, ha notato Mathieu, si persista tuttora nell’errore nonostante che “Kant stesso spieghi l’origine di zum: Zum ewigen Frieden, ossia Alla pace perpetua, secondo un uso corrente in area germanofona, ove le preposizioni contratte zum e zur introducono notoriamente i nomi di osterie, locande e alberghi […] che suonerebbero in italiano come ‘Al cervo d’oro’, ‘Al luccio d’oro’…” (La rivoluzione francese e la libertà di Kant, pdf-Filosofia.it).
L’uso della preposizione zum da parte di Kant segna, insomma, la distanza che il filosofo intende marcare rispetto alla letteratura a lui contemporanea, mediante un titolo che riprende deliberatamente il sarcasmo con cui erano accolti i molteplici progetti di pace fioriti nella seconda metà del Settecento sotto la spinta del filantropismo illuministico. E, a differenza di quanto si potrebbe pensare, anche l’ewig che risuona nel titolo originario non allude affatto positivamente alle caratteristiche del nuovo ordine che il progetto kantiano vorrebbe instaurare: non si tratta, infatti, di una “pace destinata a perpetuarsi”, bensì proprio dell’ewigen Frieden, della “pace eterna” che si è soliti attribuire all’aldilà, alla condizione atemporale dei defunti e alla quiete del cimitero.
L’autore delle tre Critiche dunque adotta, quale titolo ed esergo del suo scritto, una locuzione che assomiglia più a un solenne monito che a un fiducioso auspicio: qualcosa che evoca la “pace dei cimiteri” più che quella raggiunta con il conseguimento della concordia tra gli uomini. Lungi dall’essere una mera boutade per spiazzare o beffare il lettore, l’immagine evocata da Kant non è neppure un’estemporanea invenzione nata dalla sua fertile penna, ma costituisce l’ennesima variazione su un emblematico tópos a carattere “cimiteriale” le cui radici affondavano in una tradizione aneddotica che circolava già da tempo negli ambienti colti europei. La suggestiva metafora della pace perpetua come cimitero figura per la prima volta in un testo di Gottfried Leibniz risalente all’autunno 1688, redatto in aperta polemica contro l’espansionismo francese, accusato dall’inventore del calcolo differenziale (insieme a Isaac Newton) di voler realizzare la “paix perpétuelle” sotto forma “d’un esclavage à la Turque”, che la renderebbe simile a un “cimetière” (Réflexions sur la déclaration de la Guerre). Ciò dischiude un’inedita chiave di lettura di Zum ewigen Frieden, il cui titolo, ispirato alla pessimistica concezione leibniziana, resta tuttora al centro di un curioso equivoco che si riflette già nella sua prima traduzione italiana (1885), e che non verrà più modificata.
Solitamente interpretato come un fervente appello pacifista, il sarcastico motto utilizzato da Kant per intitolare e introdurre il suo trattatello non è altro, in realtà, che il calco fedele di una prosaica insegna commerciale straniera (“Alla pace eterna”), menzionata da Leibniz e riecheggiata dai suoi epigoni francesi, per mostrare che pace e morte si identificano. E per sottolineare – in accordo con il fosco monito inciso sul sepolcro dello storico e diplomatico olandese Lieuwe van Aitzema, suo possibile ispiratore – che la ricerca ostinata della pace sulla terra non conduce in nessun luogo o, tutt’al più, può condurre solo alla quiete tombale del cimitero. D’altro canto, conclude Duichin, la celebre immagine cimiteriale di Leibniz, corredata dall’epigrafe “À la Paix Perpétuelle” che tanto impressionò Kant, non sembra esprimere una preoccupazione infondata alla luce della sinistra dichiarazione programmatica del giacobino Jean-Baptiste Carrier (1756-1794), deputato alla Convenzione Nazionale, riferita da Hyppolite Taine: “Faremo della Francia un cimitero, piuttosto che non rigenerarla a modo nostro”.
*Il Foglio