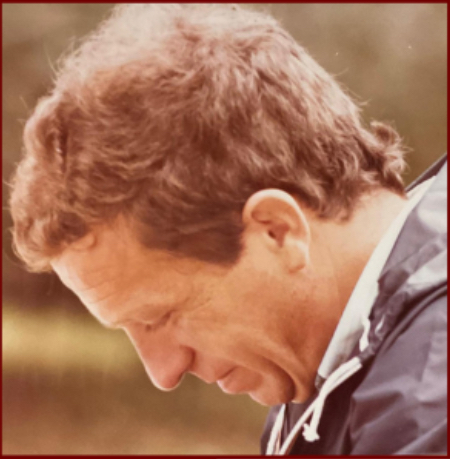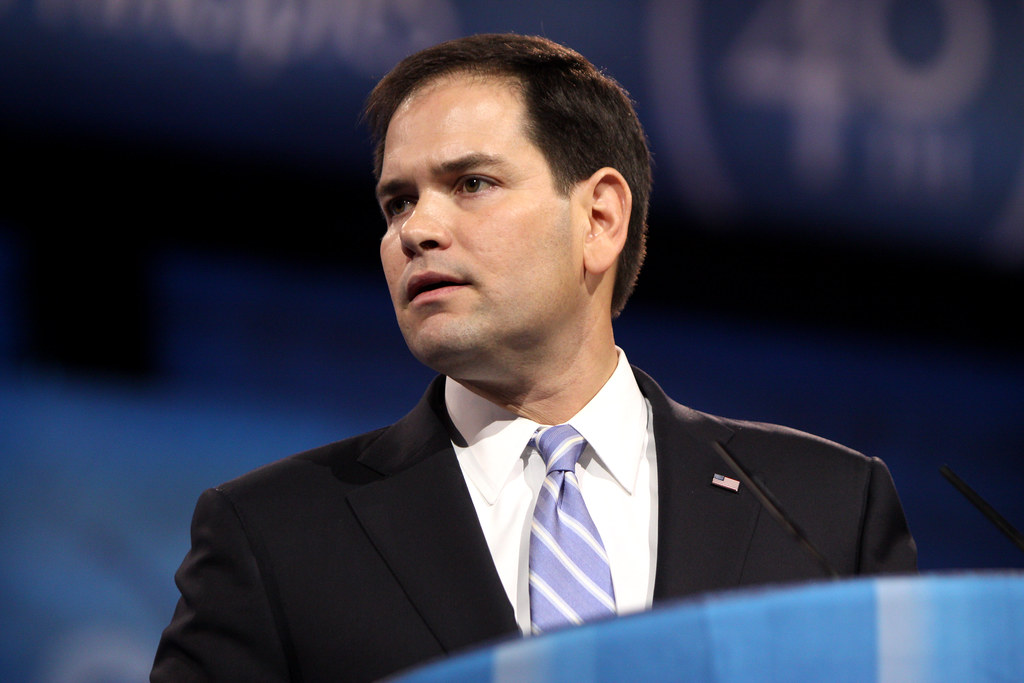Caro direttore,
l’omelia pronunciata dal cardinale decano Giovanni Battista Re alle esequie di Papa Francesco è stata letta come un richiamo a non abbandonare la rotta tracciata dal suo pontificato. Non per caso i passaggi più applauditi dell’omelia sono stati il ricordo del viaggio di Jorge Bergoglio a Lampedusa e la sua indefettibile lotta per la pace (il “bene assoluto”) e contro la guerra (il “male assoluto”).
Questo male assoluto non sembra però sradicabile dalla storia umana. Ciò ripropone anche ai non credenti che si considerano crocianamente cristiani (come chi scrive), una questione che fu avanzata per primo, nella sua formulazione più radicale, da Epicuro (341-270 a.C) con la sua famosa “equazione”: “La divinità o vuole abolire il male e non può; o può e non vuole; o non vuole né può; o vuole e può. Se vuole e non può, dobbiamo ammettere che sia impotente, il che è in contrasto con la nozione di divinità; se può e non vuole, che sia invidiosa, il che è ugualmente estraneo all’essenza divina; se non vuole e non può, che sia insieme impotente e invidiosa; se poi vuole e può, la sola che conviene alla sua essenza, da dove dunque provengono i mali e perché non li abolisce?”.
È nota la risposta a queste obiezioni che ha finito col prevalere nella teologia cristiana, nella versione di Origene (185-254) e in quella di Agostino (354-430): il male non è altro che assenza di bene (“privatio boni”). Ma è stato soprattutto Agostino a insistere sulla corruzione congenita che deriva, per trasmissione, dal peccato originale dei “protoplasti” (ossia dei “progenitori”, Adamo e Eva). Corruzione congenita che è madre di un male morale da cui soltanto la grazia insondabile del Signore libera i predestinati.
L’età moderna conosce tre grandi teodicee: quella di Leibniz, di Spinoza e di Malebranche (“teodicea”, letteralmente “giustizia divina”, indica il tentativo di scagionare Dio dall’esistenza del male nel mondo). Pur partendo da presupposti diversi, giungono a un identico risultato: Dio non avrebbe potuto creare un mondo diverso da quello attuale. Le teodicee moderne pretendevano, dunque, di rendere il male pienamente intellegibile e giustificabile.
In un breve scritto pubblicato nel 1791, “Sul fallimento di tutti i tentativi filosofici in teodicea”, Kant considera esecrabile che Dio giudichi con regole diverse da quelle degli uomini, e che quel che appare male a noi sia per lui legittimo. Secondo l’autore delle tre “Critiche”, è la sofferenza e l’indignazione di Giobbe che emozionano; le “parole in difesa di Dio”, invece, irritano e non consolano. La demolizione kantiana della teodicea, la Shoah e gli orrori del “secolo breve”, hanno contribuito alla crisi delle dottrine che negano la realtà del male o del “Dio-tappabuchi (l’espressione è del pastore luterano Dietrich Bonhöffer, impiccato dai nazisti nel 1945), ovvero l’idea di un male strumentale che serve a far meglio risplendere la bontà di un Creatore sapiente “alchimista”, che trae il bene dal male.