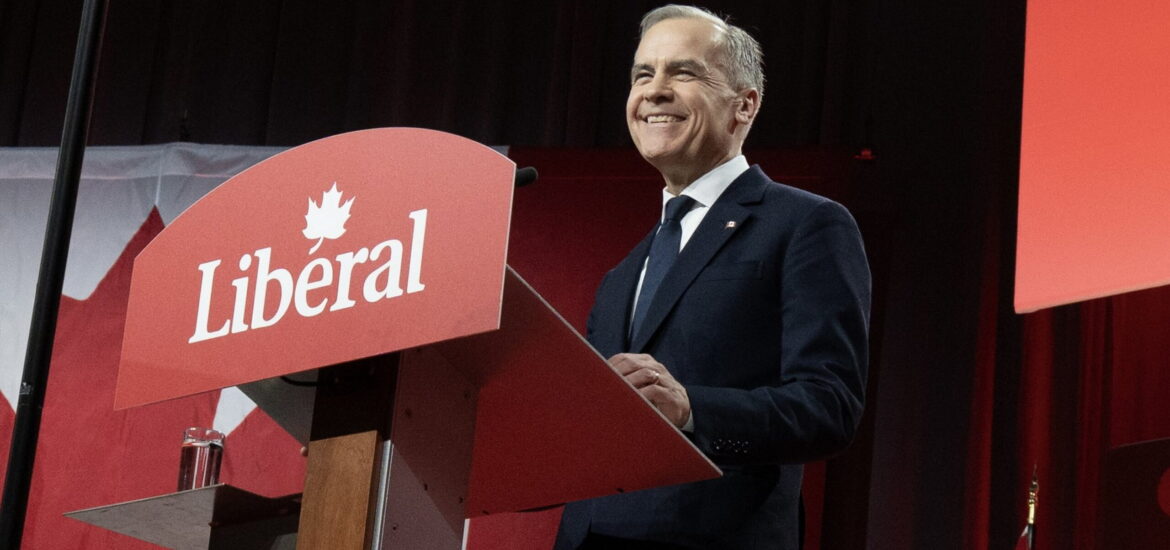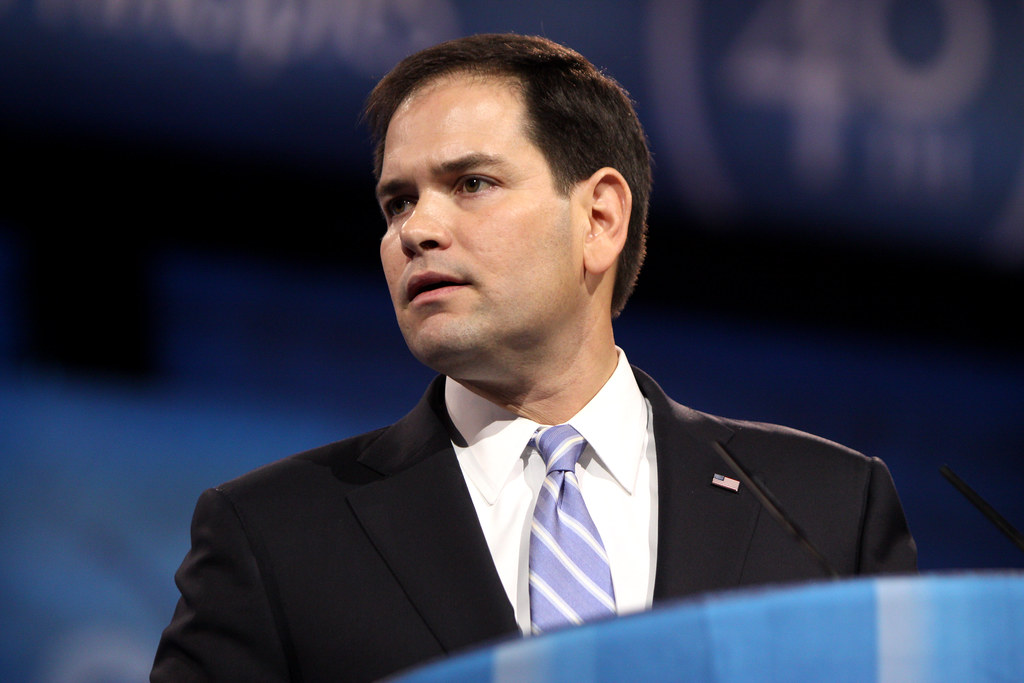A condizione di non essere troppo pignoli, si può sostenere che le relazioni italo-canadesi siano vecchie di 500 anni. Giovanni Caboto, un veneziano finanziato dalla Corona inglese, fu il primo europeo a sbarcare sulle coste del Nord America dai tempi dei Vichinghi, 5 anni dopo l’arrivo di Colombo ai Caraibi. Di lì a poco, Giovanni da Verrazzano, fiorentino a libro-paga del re di Francia, Francesco 1°, a sua volta chiamò Francesca, in onore dello sponsor, un pezzo di continente compreso tra la Florida e il New Foundland, poi più modestamente “cartografato” come Nuova Gallia.
Era l’alba di un nuovo ordine mondiale, fondato sulle capacità marinare, ma Italia e Canada diventarono Nazioni, quasi in contemporanea, molto più tardi. Il boom nelle relazioni bilaterali arrivò all’inizio del Novecento, quando migliaia di immigrati italiani vennero in Nord-America inseguendo “il sogno di un futuro migliore” e si trovarono a dissodare le pianure centrali, a maneggiare pale e dinamite nelle miniere e a costruire la ferrovia.
Questo imponente flusso (mezzo milione di ingressi da inizio secolo sino agli anni ’60 del Novecento) fu inaridito, durante il Ventennio, da un temporaneo riflesso xenofobico canadese e dalla opposizione del Fascismo, che nell’emigrazione vedeva una vergogna nazionale.
Il punto è che sono gli Italiani che hanno trasformato Montreal in una grande città e Toronto in una metropoli. Sono loro che hanno scavato la metropolitana, costruito i primi grattacieli e la Union Station, che oggi è lo snodo fondamentale del trasporto pubblico e la cui facciata in stile Beaux-Arts deve molto all’expertise eccezionale dei muratori del Bel Paese.
Mettete sotto la lente d’ingrandimento l’ondata migratoria nei primi vent’anni del Dopoguerra, quella che spinse 250 mila italiani a fare le valigie per trasferirsi in Canada: vedrete il padre di Sergio Marchionne, Concezio, in viaggio dall’Abruzzo per andare a fare il manovale a Toronto e garantire un’istruzione di alto livello al figlio, che lo ripagò con una laurea in filosofia, una in legge e un Master in Business Administration.
Vedrete Lino Saputo, a 15 anni, andare in bicicletta per Montréal per vendere formaggio, dopo aver investito i suoi risparmi, 500 dollari, e convinto i genitori a riprendere l’attività casearia che aveva a Montelepre, nella Sicilia profonda. Oggi Saputo Inc. è una delle più grandi aziende lattiero-casearie al mondo, con un patrimonio netto familiare stimato di 5,5 miliardi di USD, che investe anche in una cosa molto italiana come il calcio, visto che attraverso il figlio, Joey Saputo, la famiglia è proprietaria del Bologna FC e del CF Montréal.
Più o meno negli stessi anni, Luigi Aquilini, da Travagliato, Brescia, iniziava a lavorare come manovale a Vancouver. Grazie alla sua visione imprenditoriale, passò dalla costruzione all’acquisto di immobili, gettando le basi per un impero che oggi include la squadra di hockey dei Vancouver Canucks e vasti investimenti immobiliari.
Furono parte di quell’ondata migratoria anche i genitori, marchigiani di Genga, di David Lametti, ex-ministro della Giustizia e Attorney General del governo Trudeau, professore universitario alla McGill, un’autorità mondiale sul tema della proprietà intellettuale.
Un decennio di immigrazione era bastato per far scattare un interruttore sociologico: i figli degli immigrati italiani abbracciavano le professioni liberali senza dovere necessariamente continuare l’occupazione paterna o l’impresa di famiglia.
Oggi, quasi un milione e mezzo di canadesi rivendicano le loro origini italiane, ma il legame tra Canada e Italia può avere un impulso nuovo col ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e lo stravolgimento del commercio globale che ne è conseguito.
Non si parla d’altro da mesi: l’America di Trump vuole ridisegnare non solo la trama del suo tessuto sociale, ma anche l’ordine politico-economico mondiale, sfidando, nella lotta per l’egemonia, la potenza emergente della Cina, nelle riedizione più attuale dell’alternativa di Tucidide, che nella Storia mette di fronte il Vecchio e il Nuovo Impero.
Per molti, un disegno velleitario e intriso di ideologia che porta l’America a scaricare i suoi alleati di sempre, per avvicinarsi ai suoi nemici storici. Che mette nel mirino non solo l’Europa, con l’indietro tutta delle logiche che avevano ispirato il Piano Marshall e la nascita della Nato, ma anche il Canada, pianificandone il collasso economico per forzare la sua annessione come 51° Stato, in una riedizione dell’Anschluss dell’Austria da parte della Germania nazista nel ’38.
Di fronte alla prospettiva della disgregazione dell’attuale ordine mondiale, un esito possibile è quello della nascita di “un nuovo ordine mondiale meno uno”, con gli Stati Uniti isolati e il resto del Mondo tatticamente aggregato per contenere l’antagonismo di Washington. Con un asse Canada-Europa, in cui l’Italia gioca un ruolo di primo piano.
La guerra in Ucraina e le minacce al Canada hanno avuto anche un impatto sui mercati globali dell’energia perché mettono in discussione i vantaggi della contiguità geografica che rendevano “naturale” che l’Europa fosse rifornita a buon mercato dalla Russia e l’America dal Canada. Di questo ha beneficiato l’America che è diventata il principale fornitore di GNL (gas naturale liquefatto) per l’Europa, anche se risulta mediamente più caro del 15-20% rispetto a quello russo.
L’anno scorso, durante il G7 in Puglia, Giorgia Meloni e Justin Trudeau firmarono la “Roadmap Italia Canada per una cooperazione rafforzata”. E’ un documento da leggere per avere una comprensione delle potenzialità di una partnership più stretta tra i due Paesi. Tra le varie ed eventuali, c’è l’idea di sbloccare e accelerare le esportazioni di GNL dal Canada verso l’Italia/UE attraverso contratti a lungo termine e investimenti congiunti nelle infrastrutture canadesi. Di dare impulso a Ricerca & Sviluppo congiunti nella lavorazione dei minerali critici del Canada (litio, nichel, cobalto). Di collaborare nelle tecnologie militari avanzate (droni, sicurezza artica, sistemi navali) e nell’Intelligenza Artificiale.
Mark Carney, il nuovo primo ministro canadese che ha vinto le elezioni federali a fine aprile con una piattaforma anti-trumpiana, ha detto a chiare lettere che la relazione privilegiata USA-Canada “è finita”. La sua prima missione diplomatica si è svolta in Europa e lo ha portato a incontrare Starmer, Macron e Von der Leyen, rinsaldando i legami storici con Regno Unito e Francia, ma anche con l’Europa, una mossa che lancia un chiaro segnale all’amministrazione Trump. L’ipotesi di un Canada 28° membro dell’Unione Europea non è più relegata alla fantapolitica in un mondo in subbuglio come quello che abbiamo di fronte.
Di certo il Canada ha la necessità impellente di diversificare i mercati di sbocco e le catene di approvvigionamento, attivando partnership commerciali alternative rispetto alle tradizionali relazioni con gli USA, e questo apre un mondo di opportunità per l’Europa, e in particolare per l’Italia, secondo esportatore UE in Canada dopo la Germania. La domanda da un trillion di USD (tanto vale l’interscambio commerciale annuale USA-Canada) è se i 450 milioni di consumatori dell’Unione Europea siano davvero un’alternativa concreta per Ottawa per ridurre la sua vulnerabilità rispetto alle politiche protezionistiche di Washington e la sua dipendenza dai 335 milioni di consumatori americani.
(1.continua)