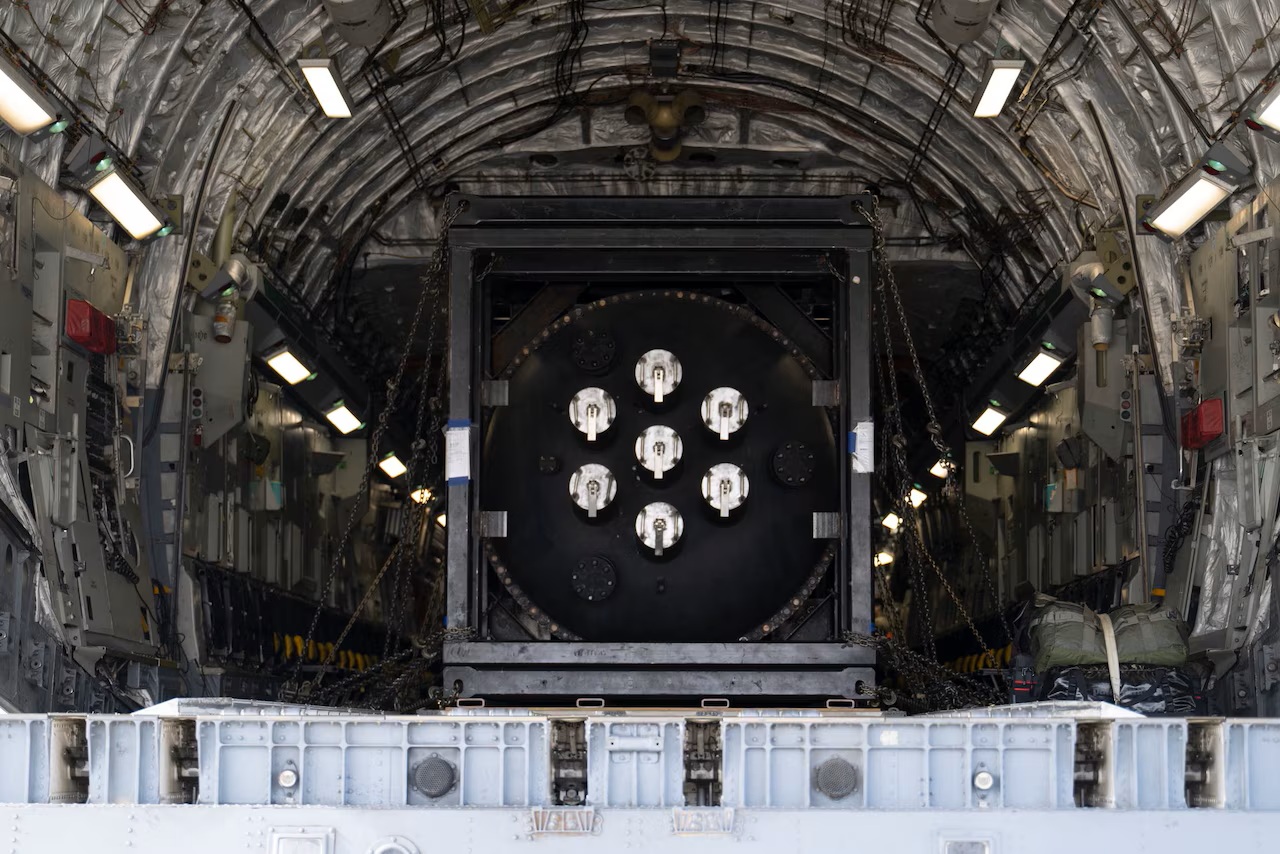In attesa di conoscere l’esito dell’incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump che si terrà oggi pomeriggio a Washington, e dunque anche le possibili evoluzioni della guerra commerciale, dell’alleanza transatlantica, del conflitto in Ucraina, è venuto forse il momento di ragionare sulla totale irrilevanza delle opposizioni e del loro posizionamento su ciascuno dei temi summenzionati, vale a dire su tutte le questioni centrali della politica mondiale. La spiegazione più semplice di questo triste stato di cose ha un nome e cognome: Elly Schlein.
Ma è una risposta molto parziale. In fondo, Schlein ha solo portato a compimento un processo cominciato molto prima, con Nicola Zingaretti, e solo apparentemente interrotto da Enrico Letta, che del resto è stato proprio Zingaretti a incoronare, così come, a sua volta, è stato Letta a organizzare il rientro e il passaggio di testimone, diciamo così, con Schlein (anche grazie, va detto, all’insipienza dei riformisti).
Può darsi che Mario Lavia esageri nel parlare ormai di partito unico Pd-Avs-M5s, ma certo la convergenza del Pd sulle posizioni dei due alleati, al di là delle distinzioni di lana caprina, è ormai difficilmente contestabile: dalla difesa europea, su cui il Pd si è isolato rispetto all’intero Partito del socialismo europeo, ai referendum contro il Jobs Act (ogni volta che mi tocca scrivere «Jobs Act», come fossimo in America, penso che l’idea di abrogarlo forse non sia così sbagliata, ma non divaghiamo).
Lo stesso termine convergenza appare in verità riduttivo. Forse sarebbe più appropriato parlare di conversione, con tanto di abiura, come nel caso dei referendum su una legge promossa dal Pd ai tempi di Matteo Renzi, che ora la nuova segretaria chiede agli italiani di abrogare, ignara evidentemente di quell’elementare principio della morale kantiana che imporrebbe di agire come se la propria condotta potesse essere elevata a legge universale (se ogni nuovo segretario del Pd promuove un referendum contro le leggi approvate dal precedente, siamo a cavallo). Ed è semplicemente fantastico – per il suo valore pedagogico, intendo – che nella stessa occasione Giuseppe Conte non si degni nemmeno di appoggiare il referendum sulla cittadinanza, che andrà al voto assieme a quello sul Jobs Act, limitandosi a lasciare in materia «libertà di coscienza» (espressione che in tale contesto, ovviamente, non ha alcun senso).
Tutto questo è deprimente e certo non porterà lontano né il Pd né la futura coalizione di centrosinistra, comunque finisca per configurarsi. Ma in un certo senso potremmo dire che la crescente irrilevanza di un simile posizionamento politico è anche la conseguenza della crescente irrilevanza del Pd, come dimostra il fatto che il posto di segretario sia ormai da tempo, di fatto, una specie di secondo lavoro, un impegno part time o un ripiego, da svolgere con la mano sinistra in attesa di occasioni migliori. Zingaretti si è dimesso da segretario dicendo che si vergognava del suo partito nel 2021, per candidarsi in parlamento alle elezioni del 2022, dimettendosi due anni dopo per candidarsi al parlamento europeo. Letta, che aveva lasciato il partito per andare a insegnare in Francia, torna da segretario, richiamato da Zingaretti, combina tutto il casino che ricorderete alle elezioni del 2022, dopodiché, visto il risultato, si dimette da segretario e pure da parlamentare, praticamente appena eletto, e se ne ritorna in Francia a fare l’intellettuale.
Non prima, s’intende, di avere portato a degna conclusione l’operazione Schlein assieme a Dario Franceschini (l’unico, bisogna dargliene atto, che perlomeno si dedica a questo lavoro a tempo pieno). L’impressione è insomma che il Pd, almeno finora principale partito dell’opposizione, abbia subito nel corso del tempo una sorta di auto-declassamento, e anche per questo sia ormai del tutto incapace di esercitare non dico un’egemonia, ma neanche la benché minima funzione di direzione politica.