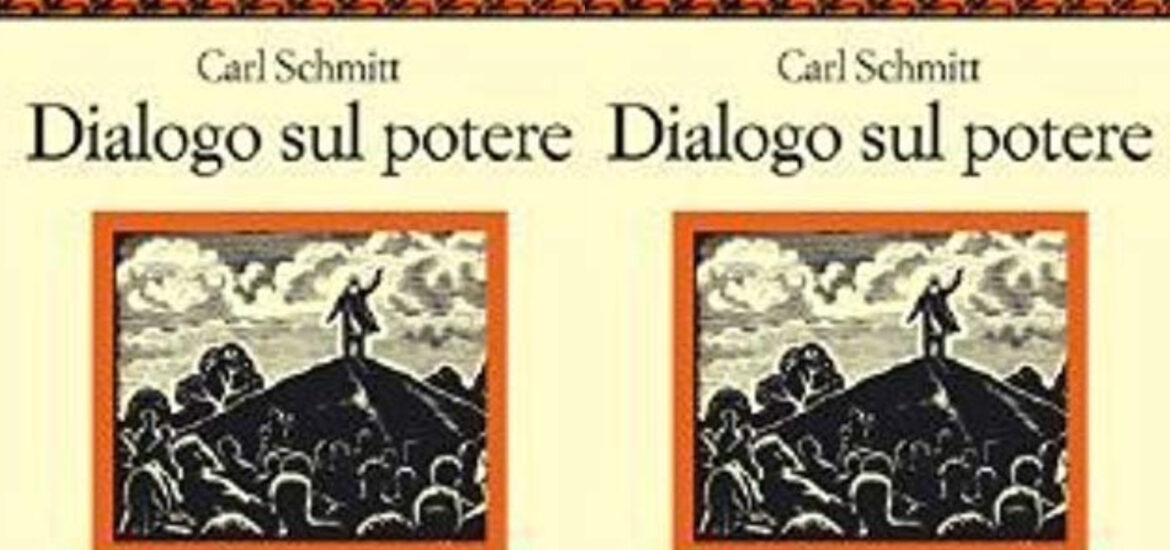Diceva Italo Calvino che solo nelle letture disinteressate possiamo imbatterci in un libro che diventa il “nostro” libro. Per l’autore dell’indimenticabile trilogia di favole araldiche, disinteressate sono quelle letture non imposte da un editore che ti sollecita con impaziente nervosismo la recensione dell’ultima ristampa, dell’ultimo romanzo o dell’ultima inchiesta sociologica. In questo senso, i “miei” libri sono per lo più biografie di personaggi famosi ma anche ignoti al grande pubblico: rivoluzionari e traditori, usurai e banchieri, pacifisti e guerrafondai, scienziati e ciarlatani, filosofi e condottieri, eretici e cortigiani, statisti e arruffapopoli. Una galleria di ritratti dai mille colori, in cui spiccano figure femminili che hanno lasciato un’impronta indelebile sulla loro epoca.
La mia predilezione per la biografia nasce sui banchi di scuola, dall’incontro con le “Vite parallele” di Plutarco. L’origine del genere biografico si può datare all’inizio del IV secolo a.C., quando Isocrate compone “Evagora” e Senofonte “Agesilao”. Allo stesso periodo risale la distinzione tra biografia “peripatetica” e biografia “alessandrina”. Entrambe con esplicite finalità apologetiche, la prima privilegiava le vite di governanti e condottieri, la seconda le vite di dotti (il maggior esempio è il “De viribus illustris” di Svetonio).
Nel I secolo d.C. Plutarco rivoluziona i due modelli, separandoli dalla letteratura encomiastica. La biografia diventa così rappresentazione dei vizi e delle virtù dell’uomo. “Non scrivo delle opere di storia, ma delle vite”, dichiara l’erudito di Cheronea nel proemio alle biografie di Alessandro e Cesare. “Spesso -aggiunge- un breve fatto, una frase, uno scherzo, rivelano il carattere dell’individuo più di quanto non facciano le battaglie”. Il gusto per il particolare aneddotico ha molta parte nella biografia plutarchea, anche se non sovrasta il nucleo essenziale di valori etici su cui viene costruito il carattere del protagonista.
Allora, lo confesso: mi incuriosiscono molto proprio i testi che assegnano un rilievo a quei fatti ed episodi spesso trascurati dall’analisi storiografica, apparentemente marginali e talvolta avvolti nell’alone misterioso dell’avventura, dell’esotismo, del mito (erano i pilastri della biblioteca giovanile di Calvino). So che, a questo punto, gli storici di professione potrebbero storcere il naso. Lo statuto scientifico della biografia resta infatti una questione assai controversa. Nonostante Plutarco, è solo nell’età moderna che essa si impone con un certo successo. Basti pensare ad opere magistrali come “Methodus ad facilem historiarum cognitionem” di Jean Bodin (1566), “Dell’arte historica” di Agostino Mascardi, oppure “De la manière d’écrire l’histoire” di Gabriel Bonnot de Mably (1784).
Come ha sottolineato la storica Monica Rebeschini (“Acta Histriae”,14*2006*2), mentre i positivisti non misconoscevano le potenzialità descrittive e pedagogiche della biografia, la stagione dello storicismo — di matrice idealista o marxista — le demolisce: tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento l’attenzione viene interamente spostata sui grandi processi storici. Secondo Benedetto Croce, “L’individuo è pensato e giudicato solo nell’opera che è sua e insieme non sua, che egli fa e che lo oltrepassa” (“La storia come pensiero e azione”, Laterza, 1954).
Altrettanto autorevoli, tuttavia, sono state le voci favorevoli alla biografia: lo svizzero Jakob Burckardt la celebra addirittura come una delle più importanti scoperte del Rinascimento italiano. Mentre Arnaldo Momigliano sarà il primo a interrogarsi — in un ciclo di lezioni tenuto alla Harward University nel 1968 — sul rapporto ambiguo che lega il genere biografico alla storiografia, senza tuttavia negare sua legittimità e la sua autonomia nella ricerca sociale (“Lo sviluppo della biografia greca”, Einaudi, 1971).
In Europa il genere biografico conosce una apprezzabile fioritura nei decenni terminali del “secolo breve”, complici la disgregazione dell’impero sovietico, la fine del mondo bipolare, la crisi delle ideologie di massa, i travagli della transizione postcomunista. Crollano le antiche certezze sulla dimensione teleologica della storia, già messe a dura prova dalla Shoah e dal rischio di una guerra nucleare. Emergono atteggiamenti più cauti e disincantati, forme meno ambiziose e meno totalizzanti di comprensione degli eventi storici. Il genere biografico acquista così una rinnovata vitalità.
Già nel 1986 Pierre Bourdieau aveva denunciato l’assurdo scientifico costituito dall’opposizione netta tra individuo e società (“L’illusion biographique”). Mentre nel 1989 Jacques Le Goff, sul periodico “Le Débat”, definirà la biografia come un “indispensabile strumento d’analisi delle strutture sociali e dei comportamenti collettivi”. Nello stesso anno, un numero delle “Annales” si apriva con un intervento di Giovanni Levi sull’utilità della biografia nelle scienze sociali. Del resto, gli stessi fondatori della rivista, Marc Bloch e Lucien Febvre, erano piuttosto cauti di fronte alle pretese prevaricatrici della “storia delle strutture” (istituzionali, economiche, demografiche) sulla “storia degli uomini”. Non fortuitamente, si deve proprio a Febvre una superba biografia di Lutero (1928).
Questo mutamento di clima si rispecchia in modo esemplare nel percorso intellettuale di Ian Kershaw, uno dei maggiori studiosi del Terzo Reich. Lo storico inglese, di formazione strutturalista, approda alla stesura di una biografia di Hitler (uscita nel 1998) spinto dall’insopprimibile bisogno — come confessa nella prefazione — di “approfondire la riflessione sull’uomo che fu fulcro indispensabile e centro ispiratore” del regime nazista (“Hitler”, 2 voll., Bompiani, 2003). Servendosi del concetto weberiano di carisma per spiegare sia l’autorità assoluta del dittatore sia il gregarismo del popolo tedesco, il professore dell’università di Sheffield tratteggia un profilo del Führer che — come egli stesso ammette — si risolve in definitiva nella “storia del suo potere”.
Quel potere il cui consenso, secondo Carl Schmitt, affonda le sue radici in certi casi nella fiducia, in altri nella paura, a volte nella speranza, a volte nella disperazione” (“Dialogo sul potere”, Adelphi, 2012). Secondo il giurista di Plettenberg gli uomini hanno bisogno di protezione, e cercano questa protezione nel potere. Il legame tra protezione e obbedienza è dunque per lui l’unica spiegazione del potere. Chi non ha il potere di proteggere qualcuno non ha nemmeno il diritto di esigerne l’obbedienza. Viceversa, “chi cerca protezione e la ottiene non ha il diritto di negare la propria obbedienza”. Il potere ha una logica interna che va al di là di chi lo esercita: “è più forte di ogni volontà di potenza, più forte di ogni bontà umana e, per fortuna, di ogni umana cattiveria”. Il potere, insomma, non ha identità, ma produce identità, quella per il cui riconoscimento servo e padrone si affrontano nella hegeliana “Fenomenologia dello spirito”.
Quando Schmitt concepisce il suo pamphlet (1954), il potere veniva già identificato da Martin Heiddeger con la “gabbia della tecnica”, con la capacità di ridurre gli uomini a “piccoli funzionari” dell’apparato globale. Tuttavia, il pensiero di Schmitt si discosta non poco da quello del filosofo di “Essere e tempo”, di cui era buon amico. Il titolo esteso del “Dialogo” recita, infatti, “sull’accesso a coloro che lo detengono”. Il problema del potere è cioè quello di come sia possibile entrarvi in contatto.
Partendo dall’affermazione che “ogni potere diretto è sottoposto immediatamente a influenze indirette”, la sua conclusione è che “non esiste alcun potere senza questa anticamera, senza questo corridoio” (nel 1890 Bismarck si dimise quando l’imperatore Guglielmo rifiutò il preventivo assenso del cancelliere sui suoi ospiti a corte). L’essenza del potere viene insomma solo adombrata, ma non enunciata esplicitamente.
La condizione dell’uomo schimittiano di fronte al potere somiglia a quella del campagnolo della novella di Kafka “Vor dem Gesetz” (pubblicata nel 1915 e poi inserita nel romanzo “Il Processo”), che attende invano di poter varcare la porta della legge (“Gesetz”), perché un custode -da cui viene soggiogato- glielo impedisce. Analogamente, per il teorico dello “stato d’eccezione” davanti alla porta del potere c’è sempre “un’antichambre”, a cui prima bisogna accedere per poterla varcare.
Ciò significa che del potere non vediamo mai il volto, ma soltanto la sua immagine riflessa nello specchio della storia, della lotta per la sua conquista. D’altronde, l’idea che il potere vero stia “altrove”, che sia invisibile e remoto ancorché influentissimo, non è ancora oggi largamente diffusa?