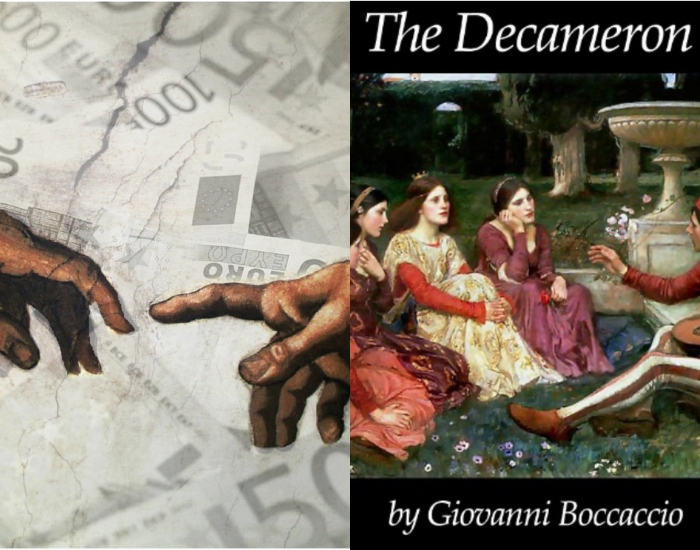Maso fu da Calandrin domandato dove queste pietre così virtuose si trovassero. Maso rispose che le più si trovavano in Berlinzone, terra de’ baschi, in una contrada che si chiamava Bengodi, nella quale niuno lavorava, essendo dal principe garantito reddito di cittadinanza e dai banchieri coniato e imprestato gratis dinaro per qualsivoglia necessità; e eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa facevano che far maccheroni e raviuoli e cuocergli in brodo di capponi, e poi gli gittavan quindi giù, e chi più ne pigliava più se n’aveva.
(Giovanni Boccaccio, Decameron, “Calandrino e l’elitropia”, terza novella dell’ottava giornata)
È tornato in piazza, a Roma. E si è ripreso la scena, al cospetto di una imbarazzata Elly Schlein e di un interdetto Giuseppe Conte. Proponendo la formazione di brigate di giovani incappucciati che di notte ripararino le aiuole e riempiano le buche stradali. Ma, accanto a questo folkloristico due di picche, Beppe Grillo ha messo sul tavolo anche un tre di briscola: l’idea di un reddito universale incondizionato. Unica misura, sostiene l’Elevato, in grado di contrastare la apocalittica disoccupazione tecnologica indotta dalla dittatura dell’algoritmo. Niente di nuovo sotto il sole. Le novità hanno suscitato sempre paura, a destra e a sinistra: paura della fabbrica perchè abbrutiva l’operaio; paura della macchina perché alienava la sua esistenza; paura del robot perché distrugge posti di lavoro; e, ora, paura dell’intelligenza artificiale perché si sostituisce all’intelligenza umana. Paure che contraddicono una verità elementare, pervicacemente contestata dai neoluddisti del terzo millennio: ogni rivoluzione industriale comporta la nascita di lavori nuovi e, parallelamente, la trasformazione di vecchi lavori, determinandone spesso la marginalità o la scomparsa.
Forse Grillo, quando pensa al futuro del lavoro, immagina fabbriche popolate solo di braccia meccaniche che si muovono freneticamente, o solo di professionisti delle “Stem” (scienza, tecnologia, engineering e matematica) che diventano il cuore pulsante dell’impresa. Poco importa. Ciò che conta è il messaggio: per effetto dell’automazione integrale dei processi produttivi, il tramonto del lavoro umano è ineluttabile. In questo senso, il reddito di cittadinanza, ricondotto al suo significato originario, funge sia da ammortizzatore sociale universale, sia da “sussidio all’innovazione”. Se non ho più l’obbligo morale di far lavorare le persone, posso spingere il progresso tecnologico fino alla sua ultima frontiera, senza preoccuparmi più di tanto dei “danni collaterali”.
Non è la scoperta dell’America. Forse i meno giovani ricordano un film di Nanni Loy, “Mi manda Picone” (1982). Racconta la frenetica ma vana ricerca di un operaio delle acciaierie di Bagnoli, scomparso in ambulanza dopo essersi dato fuoco davanti al consiglio comunale. Lo spettatore scopre lentamente, attraverso un viaggio tra i misteri di una Napoli che è la trasparente metafora dei vizi nazionali, che quell’operaio faceva mille mestieri diversi e aveva molte vite differenti. In altre parole, la sua identità sociale non era chiaramente definita, ma era ambigua e sfuggente, quasi inafferrabile. La sensibilità artistica di Loy aveva colto perfettamente la mutata percezione del lavoro di fabbrica, ormai vissuto come un ripiego e non più come motivo di orgoglio. Dopo un decennio di lotte straordinarie che ne avevano celebrato la centralità, la classe operaia sembrava sulla via di uno storico arretramento. Come già era era stato intuito dai vignettisti di Cipputi, la tuta blu sfidata dalla modernità, e di Gasparazzo, il proletario disincantato e scansafatiche. È allora che comincia a fiorire una vasta letteratura sul declino irreversibile del lavoro nella società industriale. L’aveva pronosticato già nel 1974 lo studioso marxista Harry Braverman, esaminando gli effetti della meccanizzazione di massa negli Stati Uniti. All’inizio degli anni Ottanta, André Gorz, davanti alla disoccupazione in salita e agli orari in discesa, decretava addirittura la sparizione della società dei salariati. Dal canto suo, il guru americano del guru genovese, Jeremy Rifkin, nel 1995 scriveva: “Oggi, per la prima volta, il lavoro umano viene sistematicamente eliminato dal processo di produzione […]” (La fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l’avvento dell’era post-mercato, Baldini & Castoldi).
Ma, a questo punto, è necessario chiarire cos’è il reddito universale incondizionato (“universal basic income” in inglese). È un reddito a cui hanno diritto tutti i cittadini di ogni età, e non richiede alcuna prova dei mezzi o disponibilità a lavorare. In quanto tale, esso si aggiunge a qualunque forma di retribuzione. Se non siamo proprio nella contrada di Bengodi citata nell’esergo, poco ci manca. Perché è iniquo, essendo corrisposto anche ai ricchi. Perché è sinonimo di un parassitismo di massa a carico dei contribuenti.Perché è insostenibile per le casse statali. Secondo Andrea Fumagalli, vice-presidente del “Basic Income Network Italia”, il costo complessivo per istituire in Italia un reddito universale incondizionato, di importo almeno pari alla soglia di povertà relativa, ammonterebbe a 480 miliardi di euro all’anno, equivalente a circa un quarto del pil. Senza contare il rischio di un’inflazione galoppante, qualora fosse finanziato stampando moneta.
Esaminando la sua storia, l’idea dell’universal basic income è come un fiume carsico: riemerge nei momenti di crisi economica per poi inabissarsi in quelli di maggiore prosperità. Viene avanzata per la prima volta da Thomas More nella sua Utopia (1516), l’isola dove a ciascun abitante dovevano essere assicurati i mezzi di sussistenza senza l’obbligo di un lavoro. Viene poi ripresa dal marchese de Condorcet che, durante la Rivoluzione francese, aveva immaginato una forma di “assicurazione sociale” prima di essere condannato a morte. Da allora ha inizio un lungo viaggio tra l’Europa e gli Stati Uniti, dove nel 1962 Milton Friedman nella sua opera eponima, Capitalismo e Libertà, formula la proposta di un’imposta negativa sul reddito. Non piace ai conservatori, in quanto è slegata dai meriti e dai bisogni dell’individuo. Non piace nemmeno a quei socialisti che amano lo Stato che definisce paternalisticamente i bisogni da soddisfare. Piace invece ai liberali, perché è alternativa al welfare state di ispirazione bismarkiana, troppo invasivo e quindi illiberale.
La proposta di Friedman è piuttosto nota. Si tratta di versare un sussidio automatico a tutti coloro che hanno redditi al di sotto di una certa soglia: un sussidio calante man mano che il reddito aumenta. È un sistema -spiega in Capitalismo e libertà- “diretto in modo specifico a risolvere il problema della povertà. Dà aiuto nella forma più utile agli individui, il denaro. È generale e può sostituire la multitudine delle misure speciali oggi in vigore. Rende esplicito il costo per la società”. L’economista della Scuola di Chicago era ben consapevole del problema politico posto dal suo sistema, che sottraeva risorse all’erario per redidistribuirle a chi non lavora e non guadagna abbastanza. Nel 1980, in Liberi di scegliere, Milton e Rose Friedman (sua moglie) sono pertanto costretti a precisare il loro pensiero. Il meccanismo dell’imposta negativa “fornirebbe un minimo garantito a tutti coloro che si trovano in condizioni di necessità, indipendentemente dalle ragioni della loro condizione, recando il minimo danno possibile al loro carattere, alla loro autonomia, a loro desiderio di migliorare la propria condizione”. Ma affinché funzioni davvero,dovrebbe sostituire l’attuale welfare, nel quale “alcune persone, i burocrati che amministrano i programmi, governano la vita di altre persone”.
È opinione diffusa presso gli ambienti culturali della “sinistra degli ultimi” che i sostenitori dell’economia di mercato siano sostanzialmente insensibili alle sofferenze dei più deboli e dei più poveri. Se questa è l’accusa, è interessante riflettere sulle parole di un padre del liberalismo contemporaneo, Friedrich A. von Hayek. In Legge, legislazione e libertà (1982) l’economista austriaco sostiene che molte delle comodità capaci di rendere tollerabile la vita in una città moderna vengono fornite dal settore pubblico: “La maggior parte delle strade […], la fissazione degli indici di misura, e molti altri tipi di informazione che vanno dai registri catastali, mappe e statistiche, ai controlli di qualità di alcuni beni e servizi”. Resta assodato, inoltre, che l’esigere il rispetto della legge, la difesa dai nemici esterni, il campo delle relazioni estere sono attività dello Stato. Ebbene, per Hayek “pochi metteranno in dubbio che soltanto questa organizzazione [dotata di poteri coercitivi: lo Stato] può occuparsi delle calamità naturali quali uragani, alluvioni, terremoti, epidemie e così via, e realizzare misure atte a prevenire o rimediare ad essi”. Per questa ragione, appare del tutto evidente “che il governo controlli dei mezzi materiali e sia sostanzialmente libero di usarli a propria discrezione” […]. Vi è poi tutta un’altra classe di rischi rispetto ai quali è stata riconosciuta solo recentemente la necessità di azioni governative […]. Si tratta del problema di chi, per varie ragioni, non può guadagnarsi da vivere in un’economia di mercato, quali malati, vecchi, handicappati fisici e mentali, vedove e orfani -cioè coloro che soffrono condizioni avverse, le quali possono colpire chiunque e contro cui molti non sono in grado di premunirsi da soli, ma che una società la quale abbia raggiunto un certo livello di benessere può permettersi di aiutare”.
In altri termini, solo una società aperta e dinamica, che abbia abbracciato la “logica di mercato”, può permettersi il conseguimento di fini umanitari, e se lo può permettere in quanto è relativamente ricca. Hayek non si limita a prescrivere un ruolo attivo dello Stato, ma ci dice anche la ragione: “Assicurare un reddito minimo a tutti, o un livello sotto cui nessuno scenda quando non può più provvedere a se stesso, non soltanto è una protezione assolutamente legittima contro rischi comuni a tutti, ma è un compito necessario della Grande Società in cui l’individuo non può rivalersi sui membri del piccolo gruppo specifico in cui era nato”[…]. E un sistema che invoglia a lasciare la relativa sicurezza goduta appartenendo ad un gruppo ristretto, probabilmente produrrà forti scontenti e reazioni violente, quando coloro che ne hanno goduto prima i benefici si trovino, senza propria colpa, privi di aiuti, perché non hanno più la capacità di guadagnarsi da vivere”. E questa è una scelta decisamente liberale: “La concezione di base del liberalismo classico, che solo può dar vita a un governo decente e imparziale, è che il governo deve considerare tutte le persone come uguali, per quanto diseguali possono essere nei fatti; e che in qualunque maniera il governo freni (o sostenga) l’azione di una persona, così deve, sotto le stesse regole astratte, frenare (o sostenere) le azioni di tutti gli altri. Nessuno ha una pretesa speciale sul governo, perché è ricco oppure povero, al di là della garanzia della protezione contro ogni violenza da ciascuno e la garanzia di un certo reddito minimo […]. È deplorevole che lo sforzo di assicurare un minimo uniforme a tutti coloro che non possono provvedere a se stessi sia stato collegato allo scopo, completamente diverso, di assicurare una ‘giusta’ distribuzione dei redditi”.
Sulla stessa scia di Hayek si collocano altri tre liberali: Luigi Einaudi, Luigi Sturzo e Wilhelm Röpke. In particolare il primo, riferendosi alle politiche attive contro la povertà, nelle sue Lezioni di politica sociale afferma che la legislazione sociale di uno Stato liberale deve avere come obiettivo strategico quello di “avvicinare entro i limiti del possibile i punti di partenza degli individui”, secondo “il principio generale che in una società sana l’uomo dovrebbe poter contare sul minimo necessario per la vita”. Beninteso, un minimo che non si trasformi in un diritto all’ozio, e che “non sia un punto di arrivo ma di partenza; una assicurazione data a tutti gli uomini perché tutti possano sviluppare le loro attitudini”. Le posizioni di Hayek e di Einaudi, come di Sturzo e di Röpke, dimostrano che si può essere profondamente solidali senza cadere, diversamente dall’assistenzialismo statalista, nel trade-off tra giustizia e libertà. Detto altrimenti, libertà e socialità non devono diventare due concetti contrapposti, ma si possono integrare nella concezione di uno Stato capace di affiancare le persone, di aiutare il mercato a funzionare meglio, di considerare le persone nelle loro potenzialità positive e non come sudditi che devono tacere e ubbidire. Fossero anche le alzate d’ingegno di un comico tornato sul palcoscenico della politica nazionale.
*Il Foglio