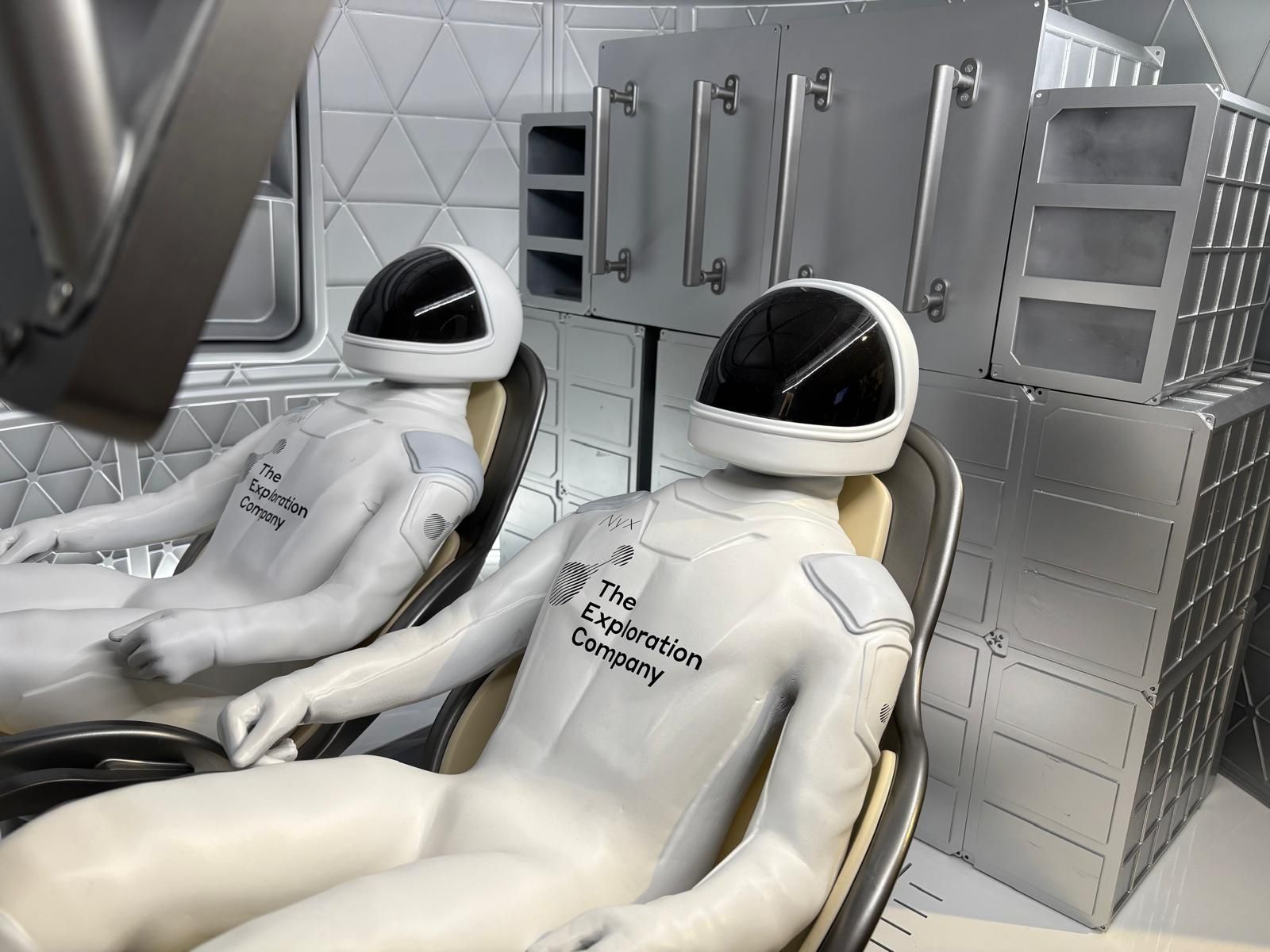È fuori discussione che la pasta sia un simbolo dell’Italia a tavola. Centinaia di formati e migliaia di ricette, realizzate con prodotti diversi e con diversi procedimenti, sono espressione di mille città e piccoli borghi. In quelle preparazioni si riflettono tradizioni e gusti che formano una cultura del cibo forse senza pari al mondo quanto a varietà di forme e di sapori.
Questa incredibile varietà trova la sua cifra unificante in una sostanza, la pasta appunto, divenuta da tempo l’icona della cucina nazionale. Gli spaghetti al pomodoro, possibilmente conditi col formaggio parmigiano, ne sono il segno identitario per eccellenza. Massimo Montanari ha raccontato le vicende di questo piatto in un dotto e divertente volumetto fresco di stampa (“Il mito delle origini. Breve storia degli spaghetti al pomodoro”, Laterza).
Interrogarsi sulle sue origini è ovviamente necessario, ma non basta. Come avverte l’autore, è interessante sapere non solo chi per primo ebbe l’idea di prepararlo, ma tenere presenti le condizioni ambientali, i luoghi, i percorsi che consentirono di coltivare quell’idea fino a farla diventare l’elemento distintivo di una tradizione gastronomica.
In questo senso, va preliminarmente sgomberato il campo da una fandonia. “Contro Marco Polo” è il titolo di un dossier pubblicato sulla rivista “Médievales” nel 1989, in cui viene smontata la frottola secondo cui il mercante veneziano, al ritorno dalla Cina sul finire del Duecento, avrebbe fatto conoscere nel nostro paese la pasta. Si tratta di un falso. La notizia è assente da tutti i manoscritti del “Milione”, dove invece si parla della farina di sago (l’amido estratto da una particolare specie di palma) che gli abitanti di Sumatra utilizzavano per fare “lasagne e altri tipi di pasta”.
L’equivoco nasce però due secoli dopo, quando Giovanni Battista Ramusio, pubblicando le memorie di viaggio di Marco Polo, fraintende e manipola il testo: attribuisce l’informazione sulla pasta di sago, di cui aveva portato un campione nella Serenissima, alla pasta in genere, facendo credere al lettore che l’ambasciatore alla corte del Gran Khan Kubilai ne avesse scoperto il segreto nella terra di Confucio.
Siamo nel 1559, e da allora la leggenda si è ingigantita anche grazie a strampalate invenzioni fra cui quella di un giornalista americano che nel 1929, sul “Macaroni Journal“, organo dell’associazione degli industriali della pasta, attribuiva la scoperta a Spaghetti (sic!), uno dei marinai di Marco Polo. Tutto comincia quando il nostro eroe, sceso dalla nave alla ricerca di acqua, si imbatte in una contadina intenta a mescolare in una ciotola un impasto semiliquido, che si solidifica al clima caldo e asciutto del Catay.
Il marinaio ha un’intuizione: pensa che un cibo secco, in grado di durare, potrebbe essere utile nei lunghi viaggi di mare. Ne compra un po’ e torna sovreccitato a bordo. Maneggia e tira l’impasto traendone dei sottili cordoncini, che prenderanno il nome dal loro inventore. Adesso bisognava cuocerli. La scelta è quella di bollirli nell’acqua salata del mare. Tornati in Italia, sarà un trionfo.
Passando dalle favole alla ricerca storica, gli studiosi hanno ampiamente dimostrato che il termine “macharoni”, attestato fin dall’undicesimo secolo, inizialmente indicava gnocchi di farina o di semola ritagliati da un impasto di un certo spessore. La loro inclusione nella categoria della pasta secca fu legata a pratiche come quelle descritte da Maestro Martino, il cuoco di maggiore talento dell’Italia del Quattrocento: assottigliarli o forarli all’interno erano modi per favorire l’essiccazione.
I maccheroni siciliani, scrive, “si debbono sechare al sole”, e in tal modo “dureranno due o tre anni”. La menzione dello “spagho” nella ricetta dei maccheroni siciliani si riferisce proprio al ferro per bucare la pasta. La via agli “spaghetti” era aperta, anche se bisognerà attendere la metà dell’Ottocento perché questo termine si affermi; “maccheroni” resterà per secoli -e tuttora rimane a Napoli- la parola d’elezione per indicarli.
A metà del Trecento è una celebre novella del “Decameron” a portarci -insieme all’ingenuo Calandrino- nella favolosa contrada di Bengodi, dove il cibo è assicurato a tutti, in abbondanza e senza fatica alcuna: al suo centro “eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la qual stavan genti che niuna altra cosa facevan che far maccheroni e ravioli, e cuocerli in brodo di capponi, e poi gli gettavan quindi giù, e chi più ne pigliava più se n’aveva”.
Bengodi è il fantastico paese di Cuccagna, che a partire dal Medioevo compare nelle utopie letterarie di mezza Europa. Come sottolinea Montanari, la montagna di parmigiano su cui rotolano maccheroni e ravioli ne è la variante tipicamente italiana. In età moderna i maccheroni saranno ormai altra cosa da come li intendeva Boccaccio, ma non cambierà il loro condimento, ormai un aspetto peculiare della nostra identità culinaria.
Trent’anni dopo la nascita del Regno d’Italia, Pellegrino Artusi pubblica “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, il libro che fonda la cucina italiana moderna attraverso la raccolta e la sistemazione delle ricette e degli usi culinari delle famiglie borghesi, contribuendo così alla costruzione di un patrimonio condiviso a cui, nel corso del Novecento, attingerà anche il mondo operaio e contadino.
Sarà lui a diffondere la consuetudine “meridionale” di condire la pasta con la salsa di pomodoro, la cui ricetta viene fatta risalire a un aneddoto curioso che ha come protagonista un prete di Romagna, il quale “cacciava il naso dappertutto e, introducendosi nelle famiglie, in ogni affare domestico voleva metter lo zampino”. Perciò “il popolo arguto lo aveva battezzato ‘Don Pomodoro’, per indicare che i pomodori rientrano per tutto; quindi una buona salsa di questo frutto sarà nella cucina un aiuto pregevole”. La salsa, aromatizzata con cipolla, aglio, sedano, basilico, olio, sale e pepe, si presterà “a moltissimi usi, [ma in particolare] ottima per aggraziare le paste asciutte condite a cacio e burro”.
Ancora Artusi aggiunge la salsa di pomodoro a piatti di pasta prevalentemente conditi con formaggio e burro, come nella più schietta tradizione italiana (almeno quella dei ceti medio-alti, giacché al popolo toccava piuttosto lo strutto). Solo nel Novecento le parti tenderanno a rovesciarsi: sarà il formaggio ad aggiungersi alla salsa di pomodoro.